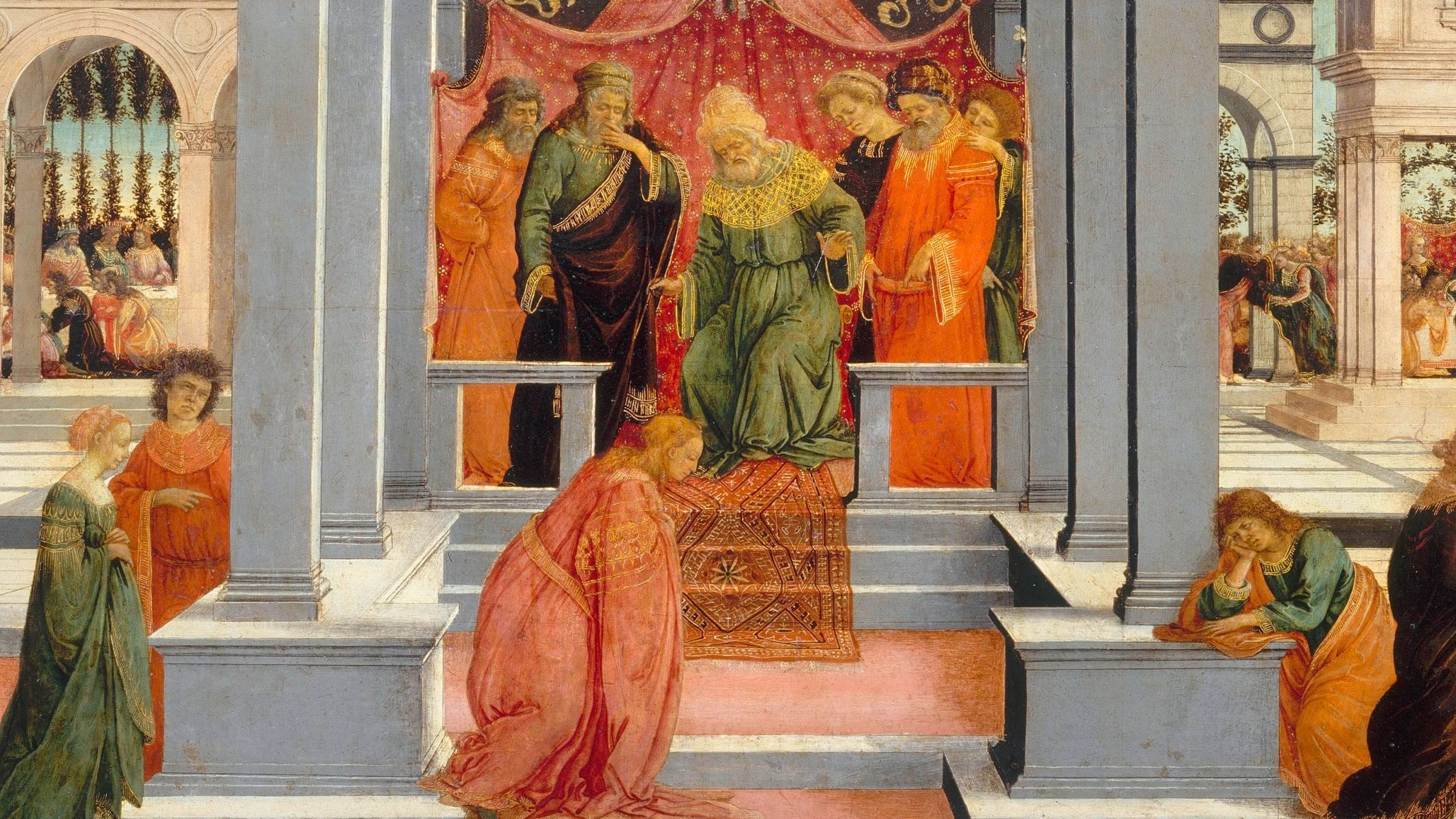
Le piattaforme digitali seguono regole proprie – o, meglio, le stabiliscono. E mai come in questi mesi è diventata chiara la trasformazione derivante da questi intermediari. Chi produce è un plugin.
“Non puoi sconfiggere il mostro. Puoi solo fartelo amico, my friend. Ogni tanto devi farti rispettare, ma non devi superare mai la linea di sicurezza, perché il mostro ti può distruggere senza pensarci due volte. Ma se gli porti una parte delle prede, lui ti lascerà prosperare. Basta che non prosperi più di lui”. Il mio interlocutore non è uno startupper, né un operatore della finanza d’assalto. È un imprenditore del turismo di Atene – organizza visite guidate, anzi “esperienze” come si chiamano ora – e ha una flotta di van in cui trasporta i turisti in giro per le migliori location della capitale e dintorni. Casualmente, vista la crisi turistica del 2020, è lui stesso alla guida del pulmino in cui sono seduto anch’io (assieme a un’altra turista tedesca, che lavora nella finanza). Il mostro non è nulla di mitologico, niente leggende alla Minotauro. Non ha niente a che fare con le bizzarre liti tra divinità elleniche che tanto appassionano i turisti (e anche me ovviamente, sennò non sarei in viaggio da due ore con lui verso Delfi sotto un sole accecante).
Il mostro, in questo caso, è ciò che – nel nostro gergo tecnologicizzato di addetti di marketing – chiamiamo la piattaforma. Marko nello specifico si riferisce a Tripadvisor e al suo braccio armato nella vendita di esperienze, Viator, da cui molti comprano cose come “escursione di due ore alle rovine del tempio di Poseidon al tramonto” o “un pomeriggio per imparare come si fa la feta” con un solo tap dalla iper-consultata app di recensioni turistiche e culinarie. Ci sono altre piattaforme, come Get Your Guide, ma la sostanza non cambia: devi mantenere buoni rapporti con tutte, alimentare un po’ tutti i mostri, non superare la linea gialla. Mi aspettavo la solita lamentazione tipica dell’albergatore medio su quanto sia rapace Booking (indovinate? altra piattaforma), e invece no. Sarà che in Grecia hanno avuto problemi peggiori del 25% da riconoscere al marketplace olandese su ogni prenotazione, sarà che in effetti, dal suo narrato stile di vita, capisco che male non gli è poi andata. Da Google in poi, il mondo – economico ma non solo – è stato divorato dalle piattaforme. E per capire meglio perché, forse è necessario approfondire cosa è davvero una piattaforma, quali sono i suoi geni che la rendono l’animale all’apice della catena alimentare dell’economia. Anche per capire se questi geni possono renderla più resiliente (e alla fine indistruttibile) a qualunque Covid-rimescolamento di carte in tavola.
Dal mercato al marketplace
L’antenato del marketplace è sempre stato sotto i nostri occhi: è il mercato rionale. Quell’aggregatore di bancarelle variopinte e vocianti è il nonno di Amazon. Il mercato settimanale ha sempre avuto qualche punto di forza: la convenzione per cui nello stesso luogo, nello stesso tempo, i compratori e i venditori si incontreranno. Ci sono i compratori perché ci sono i venditori, e viceversa. Il mercato rionale ha sempre evitato il problema che la letteratura del venture capitalismo americano ha definito il paradosso dell’uovo e della gallina. Chi devo far accorrere per primi nella mia piazzola asfaltata, il venditore di pesce fresco o la signora Rosalina? L’ha evitato perché il mercato era pubblico: era il comune che decideva dove e quando, da decenni solito posto e orario. Non che anche i mercati non muoiano di effetto uova e gallina: i miei genitori nel paesino padano mi raccontano di come nella piazza alla fine non vengano più di due o tre bancarelle, e che gli avventori si siano conseguentemente ridotti a poche decine di persone. Il modello, in un’era dominata dagli atomi, non era – come si dice nella Silicon Valley – scalabile. Puoi diventare grande come Porta Portese a Roma o la Montagnola di Bologna del sabato, ma non enorme, non totalizzante. La piazza ha una capienza limitata di persone e di venditori. Questo non vale per l’era digitale: quante piscine da giardino può contenere Amazon? Infinite. Quanti hotel può avere la catena di hotel Booking? Tutti gli hotel esistenti. Di chi sono i dipendenti da licenziare post Covid? Degli hotel. Quanti appartamenti ha Airbnb? Chi lo sa. Quanto spende in manutenzione? Nulla. Quanti curricula può contenere Linkedin? Miliardi. Quanto spende per aggiornarli? Nulla.
Nel momento in cui connettere velocemente milioni e milioni di compratori e venditori non costa più quasi nulla, la piattaforma si è trasformata nel modo più veloce per far crescere i fatturati in doppia cifra (non sempre i profitti, ma who cares se l’obiettivo è la conquista del mondo), nell’investimento più appetibile per ogni surplus di soldi nell’universo, e nel sifone di dati personali più efficiente della storia economica moderna. L’organizzazione e l’economia aziendale insegna ancora il modello che sta perdendo: l’oleodotto (in inglese, pipeline, suona meglio). Un’azienda è qualcosa che si procura qualcosa a monte, lo trasforma quel tanto che basta ad aggiungere valore, poi lo vende a valle. Più l’oleodotto era potente, più costava meno comprare a monte e più si aveva potere a valle. Immaginate Coca-Cola: economia di scala sulla produzione, economia di scala sulla pubblicità, potere assoluto sul mercato, soprattutto dei bar e simili, quello più remunerativo. L’oleodotto economico perfetto. Automobili, scatolette, tv lineare, pubblicità. Oleodotti impressionanti ovunque, apparentemente inscalfibili. E sarebbero rimasti tali, se non fosse arrivato internet a cancellare il costo di transazione, abbassare le asimmetrie nella conoscenza dei mercati tra venditori e compratori, rendere ininfluenti le scarsità nei magazzini, negli spazi prima di un programma televisivo e negli scaffali di vendita.
Nella mia visione l’era delle piattaforme è iniziata con la crescita dei veri motori di ricerca: Google. Tutti vedono nell’algoritmo di Google il motivo del successo, a buona ragione. Ma c’è un particolare meno studiato che diventerà una costante per tutte le piattaforme, a vari gradi di purezza. La piattaforma non produce, fa produrre; in ogni caso non si affeziona mai e poi mai ai propri prodotti, li lascia giudicare agli utenti (e, se serve, li uccide senza pietà). Google non ha in realtà mai prodotto un singolo contenuto, ha solo fatto arbitraggio (e molto bene) tra i “venditori” e “compratori di contenuto”. Ha incentivato, a fasi alterne, i creatori con due spiccioli a produrre video su YouTube, ma non ne ha mai prodotti. E alla fine ha trovato il miglior modo in assoluto per fare soldi, il “metodo piattaforma”: mettere un balzello tra domanda e offerta, in questo caso attraverso il pay-per-clic, tassando i contenuti più poveri o quelli più bisognosi di acquisti.
Le piattaforme hanno un peculiare vantaggio rispetto agli oleodotti: non hanno bisogno di molte persone per funzionare. Sono le due parti a fare tutto, a regolarsi. Al massimo, ci va messa un po’ di moderazione (ancora Facebook oggi si appella alla neutralità per evitare di impiegare troppe persone a filtrare e bloccare utenti e contenuti contrari alla civiltà). Si tratta però, rispetto all’esercito di persone che serve agli oleodotti, di qualcuno che dia qualche colpetto di qua, qualche regola di là, per mantenere il luogo di incontro – il mercato – efficiente e sicuro. Immaginate quante persone servono per gestire un database di milioni di curricula con il modello oleodotto (la classica agenzia di selezione, ma anche il digitale Monster, che “compra/incentiva” cv e li rivende), e quanti ne servono invece per tenere in piedi il modello piattaforma – Linkedin ricava 6,8 miliardi di dollari con 16.000 dipendenti, Monster circa 370 milioni di dollari con 3.700 dipendenti. Perfino nella peggior depressione post Covid per il mercato del lavoro degli ultimi dieci anni, Linkedin ne lascerà senza lavoro solo il 6%.
Piattaforma che vince
Non c’è storia, non c’è competizione possibile, almeno quando la piattaforma supera la soglia di non ritorno. Sì, perché le piattaforme sono come le tartarughe: tante uova deposte, ma pochissime riescono a diventare centenarie. Quelle che lo diventano però difficilmente possono essere scalzate. Per questo i venture capitalist le amano: sono scommesse così impossibili e così ad alto rendimento da adattarsi perfettamente al modello roulette tipico del finanziamento delle startup. Tanta crescita attira tanti soldi, tanti soldi producono crescita, e così via. Per ogni Linkedin, ogni Facebook, ogni Get Your Guide ci sono centinaia di migliaia di esperimenti abortiti o morti nella culla. Credo che ogni consulente in Italia abbia avuto a che fare con il classico business plan in cui qualcuno voleva creare l’Amazon, il Facebook di [un particolare settore/segmento/località]. Ma bastano poche storie di successo per convincere migliaia di startupper a sacrificare il loro tempo al probabile fallimento. Del resto, le piattaforme hanno completamente soggiogato lo storytelling dell’industria tecnologica. I giornali di settore (ma non solo) dipendono dalle loro notizie, da cosa i loro uffici stampa (e i loro viaggi stampa) vogliono comunicare.
Il fallimento, del resto, è parte stessa e fondamentale del modello piattaforma. Non solo perché è un gioco per highlander, in cui il vincitore prende tutto, ma anche e soprattutto perché le piattaforme sono demoni tentatori nei confronti dei partecipanti, o degli startupper. Lasciano apparenti spazi vuoti, e poi decidono “a test avvenuto” se prenderseli o no. Qualcuno più anziano ricorda gli esordi di Twitter. Era l’incarnazione della piattaforma open, rendendo tutti i geek fan che ne decantavano i futuri radiosi e le Api di programmazione aperte, con cui ognuno poteva crearsi un Twitter personalizzato e cercare di farne un business, lavorando sui bisogni di una parte degli utenti, quelli che la piattaforma non poteva soddisfare direttamente. All’inizio, che ci crediate o no, Twitter non aveva la funzione di upload di foto. Bisognava usare dei plugin o dei client ad hoc per inserirle. Sembra impossibile? Leggete la triste storia di Twitpic su Wikipedia. Ciò che funziona, la piattaforma lo internalizza, e se va bene ti paga, se va male ti copia. E quello che non funziona, be’, non funziona. Grazie utente per avere testato a tue spese! La stessa cosa funziona con Amazon: il marketplace di venditori terzi valorizza i prodotti più di successo (i gusci Meliconi di domani) e decreta l’oblio di oggetti scartati dal mercato. I prodotti di successo, verificata la continuità della domanda, sono venduti direttamente da Amazon. Oppure addirittura creati a marchio Amazon. Grazie utenti e venditori per essere l’indagine di mercato più grande del mondo – su cui Amazon inoltre ricava un gradevole 15% di commissioni! Le piattaforme non spendono in marketing (se non per accontentare qualche governo mostrando che ci tengono alle comunità locali), o molto meno rispetto agli oleodotti. Non fanno pubblicità, o almeno in una percentuale irrisoria dei propri ricavi. Nessuna piattaforma è mai cresciuta attraverso spot, mentre molti brand tradizionali non avrebbero potuto esistere altrimenti. Del resto, è molto più conveniente usare gli utenti come promoter, più o meno consapevoli. Dalle corse scontate di Uber per chi faceva registrare i propri amici, ai soldi gratis di PayPal (copiato poi da Satispay), dalle recensioni che lasciamo (gratis!) su Amazon, ai contenuti virali (produciamo e diffondiamo!) su Facebook, al “invita tutti gli amici” del primo Instagram (rubrica telefonica fornita gratuitamente!).
Superato un certo livello di quota di mercato, non serve il marketing, perché non puoi non esserci. Non conosco più una singola azienda che non venda anche su Amazon. Forse Nike ce la farà, ma la partita è ancora da giocare. E ora addirittura Amazon vende pubblicità per essere trovato sulla sua piattaforma, fatta in buona parte di prodotti che non produce e non vende. Whatsapp: se non ce l’hai probabilmente sarai considerato un po’ strano. Tinder: praticamente ogni stagione fa uscire un comunicato su quanti matrimoni produce, per lasciare al giornalista solo la chiusa “wow!”. L’effetto network non perdona: la piattaforma aggiunge valore al ritmo del quadrato del numero dei propri utenti. E rende il valore degli altri la radice quadrata.
Tutti amano le piattaforme
Del resto, le persone amano le piattaforme e questo non fa prevedere in futuro limitazioni politiche alla loro attività, a parte quando pestano i piedi a gruppi ancora avvezzi alla lotta politica – come i tassisti. Nella classifica di Brandz dei brand più amati/conosciuti, il loro predominio è incontrastato. Amazon, Apple, Microsoft (antesignana della piattaforma con Windows), Google, e pure Facebook, sia pure in un anno non facile per la sua reputazione. Il primo oleodotto è McDonald’s, al nono posto. Grande crescita per Netflix, Instagram e Linkedin, che entra nei primi 100 della classifica Interbrand: per una noiosa piattaforma per il business, un miracolo. C’è più di un motivo per questo attaccamento: le piattaforme semplificano la vita. Immaginate trovare un certo paio di jeans usati in un mercatino grande come tutta Milano. Impossibile. Immaginate ora trovarli su eBay: per quanto l’onusta piattaforma faccia di tutto per rendersi un po’ fuori moda, serve un attimo.
Aggregano, prioritizzano, semplificano. E usano la tecnologia per farlo. La piattaforma non esisterebbe senza internet, si è visto, ma anche senza la sua intelligenza artificiale, che si smazza un lavoro che non sarebbe economico fare altrimenti. In realtà non serve una grande intelligenza in senso stretto per convertire al credo-piattaforma le persone, a loro (a noi) basta qualcosa che renda più rilevante la realtà, meno caotica la ricerca, più veloce il raggiungimento dell’obiettivo. Netflix è una piattaforma o una rete televisiva? Entrambe le cose. Ma, da codice di comportamento delle piattaforme, anche quando produce non si innamora perdutamente del prodotto a costo di sacrificare tutto. Lo promuove, certo, ma lo lascia fluire tra i tag, tra le preferenze dei simili, esattamente come un episodio di Friends d’annata. E a volte il contenuto riemerge prepotente. Notavo come Borgen, vecchia serie danese come House of Cards ma con paesaggi più piovosi e molto più salmone nei piatti, sia arrivato tra i più visti nella settimana. Probabilmente è stato intercettato da tutti gli utenti con i tag nel profilo: politica, nordics, reduci di West Wing, eccetera. Se fosse andato male, amen, la piattaforma passa e va ad altro. Il sifone dei dati succhia informazioni agli utenti, questi sono felici perché la realtà proposta è a loro immagine e a portata di comprensione. La stessa cosa vale per Spotify: aggrega talmente tanta domanda da poter strizzare spiccioli sia agli utenti, con l’abbonamento, sia agli artisti. Quelli famosi guadagnano meno, ma non possono non esserci. Quelli sconosciuti apprezzano essere senza più barriere all’ingresso, ma con irte barriere all’attenzione. Di nuovo, la logica motoria della startup: il “sai mai”. Spotify non produce musica, lascia che sia il mercato a decidere. La piattaforma è come il banco al casinò, vince sempre.
The universe does not allow waste, l’universo non permette lo spreco (e internet fa lo stesso), si dice sostenesse Adam Neumann, protagonista di una saga incredibile di rapida ascesa e caduta precipitosa con la sua WeWork. Questa era un’azienda che si definiva/atteggiava come piattaforma per attingere al flusso apparentemente infinito di capitale (in pratica, era un coworking). Il mimetismo animale copiato dal capitalismo: alla fine era null’altro che un business immobiliare, solo molto costoso e malgestito. Un giorno Netflix ci farà una serie (ci scommetto). Contro lo spreco! Buona parte delle piattaforme sono cresciute nel favorevole clima di pubbliche relazioni stampa della sharing economy, un termine molto in voga anni fa. Airbnb doveva mettere fine allo spreco di tenere casa vuota quando eri fuori città. Uber Pop sfruttare le auto già in circolazione. What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption era il libro fondativo di una nuova epoca, in cui il possesso avrebbe lasciato spazio all’uso. Perché comprare un tagliaerba se te lo può prestare il vicino? Perché non rivendere un abito che non usi più? Peccato che tutti gli esperimenti di vicinato non abbiano funzionato, mentre le grandi piattaforme globali come Airbnb abbiano finito per inghiottire qualsiasi forma di affitto, scacciando gli stessi abitanti dalla loro città. Eppure, la gente adora Airbnb – e il livello di servizio degli hotel ha giocato un ruolo importante nella svolta. Perché la piattaforma aggrega, semplifica, rassicura (con le recensioni).
Aggregare, semplificare, rassicurare
Aggregare (la domanda, per fare economie di scala), semplificare, rassicurare. Era il compito del brand, la sua essenza, in tutta l’era dei mega oleodotti: comprare al minimo costo, produrre, competere per lo spazio fisico, attivare la comunicazione di massa per vendere milioni di oggetti. Ancora una volta Coca-Cola è l’archetipo: ci sarebbe stata senza la potenza dello spot, delle economie di scala di miliardi di bottiglie e lattine, senza l’occupazione di bar e ristoranti? Probabilmente no. Ce ne saranno altre? Non lo so, ma l’ecosistema dominante è cambiato per sempre. Al capitalismo non conviene creare nuove bevande gassate di massa. Lo spazio comunicativo è frammentato, le economie di scala non sono più così determinanti (pensate all’insensata proliferazione delle “birre artigianali”). Conviene lasciare che tante bevande di nicchia si scannino per trovare uno spazio al sole (di una piattaforma).
Ho scritto anni fa dell’era dei microbrand. Sono quelli che hanno un pubblico di nicchia, vivono in simbiosi (o almeno in un’accettabile convivenza) con le piattaforme, e sono sufficientemente diversi e unici perché una buona fetta dei propri clienti interagisca con il brand all’esterno della piattaforma dominante, di cui sfruttano la profilazione in pubblicità. Non è un caso che buona parte dei nuovi brand direct-to-consumer (c’è di tutto, dalle pentole al fashion, dagli ingredienti già porzionati alla cosmetica) non abbia boicottato (perché non si può permettere di farlo) FacebookGram, la piattaforma da cui traggono traffico e vendite e in cui la loro simbiosi è perfetta, in combinazione quasi sempre con uno store basato sul principale software as service per l’ecommerce: Shopify. L’azienda canadese punta del resto a diventare la piattaforma (standard, logistica inclusa) di riferimento per l’ecommerce fuori da Amazon. Nel suo recente accordo con lo sconfinato Walmart c’è l’unione dei puntini. Shopify diventa lo standard de facto per il sito ecommerce, Walmart passa da essere un enorme supermercato oleodotto a una piattaforma, su cui tutti gli store basati su Shopify potranno partecipare semi-automaticamente. Marko potrebbe insegnargli qualcosa.
Molto spesso anche questi microbrand ragionano a loro volta come piattaforme, ma per i contenuti e le interazioni con i loro fan: prosperano attraverso le community di utilizzatori, che svolgono per loro una serie di funzioni. I clienti suggeriscono, si auto-aiutano, creano contenuti e li diffondono. I brand direct-to-consumer sanno che non possono sfuggire del tutto alle piattaforme (quanto meno a FacebookGram, Amazon, Apple per l’App Store e Google per il traffico al sito), ma rivendicano strenuamente la loro unicità e indipendenza. Pensate – per i grandi – al modello Ducati, o Ikea, e – per i piccoli – a brand per appassionati di snowboard o bici, o alcune tra le più famigerate birre artigianali. Come Walmart, altri brand possono in fieri diventare piattaforme: si fa fatica a immaginare l’arretrato e italico mondo della grande distribuzione. Ora la selezione dei prodotti in vendita e la loro proposizione al cliente è svolta con un processo 100% oleodotto: il category manager seleziona i fornitori, con un mix di dati, gusti e rapporti personali e prezzo tirato all’osso, mentre le funzioni commerciali scelgono come e cosa vendere ai clienti negli scaffali (senza distinzione di preferenza). La storia recente sembra insegnarci che non puoi vincere contro le piattaforme, i dati e l’algoritmo che fa il lavoro sporco. Sarà sempre più inefficiente scommettere su propri prodotti, se puoi attivare un mercato e lasciare i prodotti lottare tra di loro, raccogliere miliardi di gigabyte di dati e dare con questi l’impressione al cliente che senza di te la vita non sarebbe la stessa. E con la spesa online definitivamente sdoganata dal Covid servirà ben più che il punto vendita fisico vicino a casa a fare da baluardo, per impedire che dopo informazione, amici, hotel, appartamenti, lavoro, app, sesso, sushi a domicilio e tv, alle piattaforme non interessino gli acquisti per cibo e casa.
La grande accelerazione digitale
La pandemia ci ha portato la grande accelerazione digitale, o ci ha fatto ripartire da uno scalino più alto nella scala digitale, con una discontinuità inusitata. Nuove abitudini si sono consolidate, su cui le piattaforme – maestre nel circolo virtuoso/vizioso fatto di profilazione, stimolo, soddisfazione, recensione, ripetizione – si trovano perfettamente a loro agio. Ci troviamo a ripensare ora, su due piedi, quello che doveva essere forse il 2023, qualcuno azzarda persino il 2030. E alle piattaforme piace, sono già pronte, lo erano da dieci anni. In un’epoca storica che sarà caratterizzata da mancanza di lavoro, nessuno si immolerà per inserire nuove regolamentazioni ai rider (i plugin del caso) delle piattaforme di delivery: più domanda da una parte (è più sicuro mangiare a casa, no?) e più offerta di lavoro dall’altra (bisogna pur arrotondare in qualche modo). La piattaforma è lì, pronta ad approfittarne. Anzi, ormai punta al ruolo istituzionale che era degli stati nazionali, che sembrano invecchiati di vent’anni: Apple e Google hanno deciso come dovevano essere costruite le app per il tracciamento del Covid (non un grande successo, a dire il vero). E Trump si preoccupa di TikTok.
Il mostro privatizza i profitti negli anni luminosi, “collettivizza” le perdite negli anni bui. Nel secondo trimestre, i ricavi di Google sono calati del 7%: confrontatelo con le perdite di giornali e tv. Facebook nello stesso periodo ha guadagnato l’11% di ricavi più del 2019. Perfino l’anno-senza-il-turismo come il 2020 non farà danni permanenti per Airbnb e Booking: certo, perdite a bilancio e qualche dipendente in meno, ma la loro struttura è molto più flessibile e minimale dei produttori dei servizi che vendono, e i soldi dei finanziatori arriveranno comunque. Anche con una previsione di un calo dell’85% delle prenotazioni come quella prevista nel secondo trimestre del 2020, Booking sostiene di essere in grado di stare sul mercato almeno fino a fine 2021, in attesa che le persone riprendano (almeno in qualche Paese) a viaggiare. E intanto ha incassato un finanziamento di quattro miliardi di euro ad aprile. È Marko, il mio imprenditore-guida di Atene, non loro, a dover mettere in cassa integrazione i dipendenti. È il destino dei plugin, di business che crescono, vivono e muoiono attaccati alla piattaforma come le remore, attaccate con la ventosa allo squalo – se paragonato alla piattaforma, lo squalo pare molto meno affamato. Se la piattaforma sarà un nuovo modello destinato a sostituire definitivamente e in gran parte il modello oleodotto, o solo un altro momento passeggero della storia economica umana, molto dipenderà dall’opinione pubblica e da quanto si attiverà (in tempo) per mettere regolamentazioni e paletti alla loro dominanza (su lavoro, fiscalità e tanto altro), posto che i consumatori vogliano davvero rinunciare a tutte quelle piccole comodità quotidiane, e posto che i Marko di tutti i settori vogliano rinunciare alla vita da orgoglioso e profittevole plugin. Di questo però non ci sono ancora segni all’orizzonte.
Gianluca Diegoli
Dalla Bocconi in poi osserva passare i trend dall’evanescente confine tra online e offline. Di giorno si occupa di marketing e digital, di notte ha scritto Svuota il carrello (2020) per UTET. È professore a contratto in IULM e in Master. Ogni venerdì alle 9 manda la sua newsletter.
Vedi tutti gli articoli di Gianluca DiegoliLeggi anche

Mediamorfosi 3
L’infinite Jest delle piattaforme


