
The Jinx, Serial e Making a Murderer: una lettura critica della loro coolness e della manipolazione operata ai danni dello spettatore “evoluto”.
Prendete, se volete, una puntata di Storie maledette. Prendete la puntata con Franca Leosini che intervista Rudy Guede nel carcere di Viterbo e gli fa ripercorrere la storia della sua vita, fino alla notte dell’omicidio di Meredith Kercher. Il senso ultimo della puntata è riassunto nel titolo, “Le rivelazioni di Rudy Guede”. La tecnica per arrivare al senso ultimo è puntare due telecamere addosso al detenuto e vedere come reagisce, lui, a certe domande. Lo stile è frutto di una logica: il pubblico di una prima serata Rai deve capire tutto senza mai fare fatica. Perciò avete la voce fuori campo leziosa, l’intervista spezzata da immagini di repertorio e da ricostruzioni filmate con attori, la musica sinfonica spalmata sui momenti solenni. Questo stile viene considerato fatuo e disonesto. Si usa spesso la parola manipolazione. La sua vera grande colpa è però un’altra: manipola lo spettatore, ma non lo fa in maniera abbastanza figa. I classici semi-documentari dedicati alla cronaca nera, quelli che riempiono i palinsesti di Investigation Discovery e TruTv, hanno il loro momento di gloria quando incrociano un prodotto più alto – la protagonista di L’amore bugiardo (Gone Girl) studia con cura quei programmi per meglio mettere in scena la propria scomparsa. Ma ai vostri occhi restano prodotti perdenti, consumi supremamente uncool. La serie D. Mentre voi, qui e ora, siete in mezzo a una rinascita della cronaca nera come materiale di partenza per storie rivolte a un pubblico che si considera sofisticato, desiderabile e sempre al passo con quanto è più rilevante. La serie A. I vostri amici guardano The Jinx, La vita e le morti di Robert Durst, ascoltano Serial, almeno la prima stagione, passano il fine settimana davanti a una maratona di Making a Murderer. Cambiano lo spettatore medio, la forma, lo stile. La manipolazione c’è sempre.
Per testare l’intenzione dietro la forma, provate a riassumere i vostri pseudo-documentari preferiti in un paio di frasi. Così:
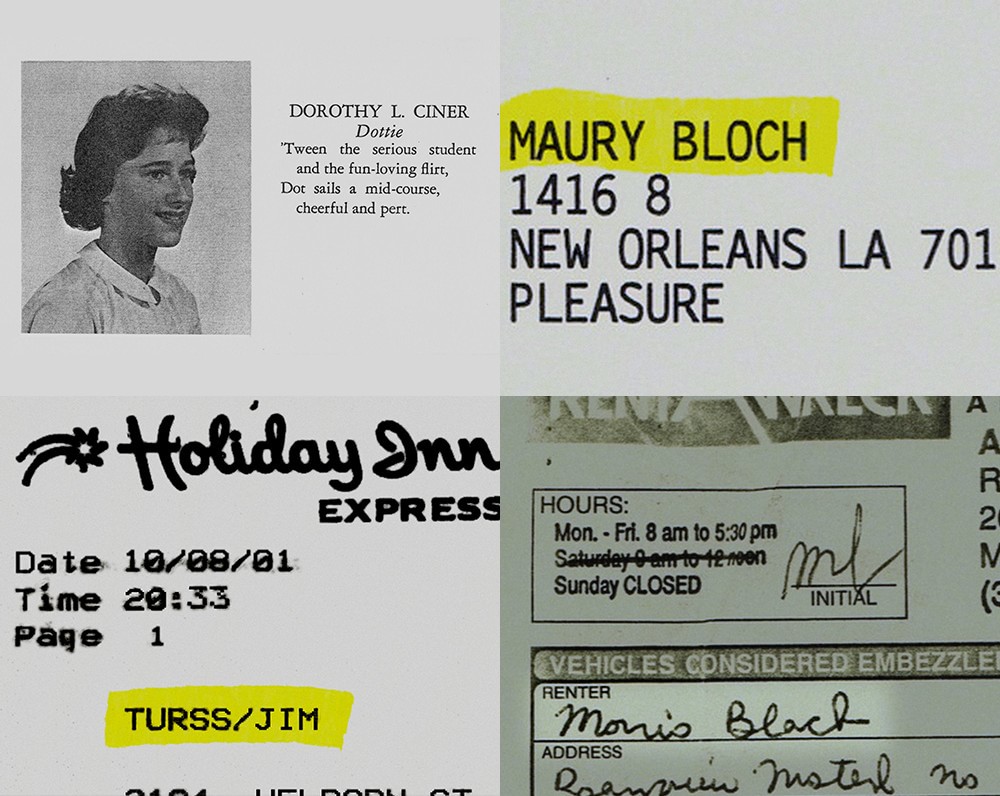
The Jinx: “Signor Robert, lei è un assassino? Eh? Eh? Che mi dice, signor Robert?”
Il miliardario Robert Durst è un personaggio che per amore di carità si può definire disturbante, e che sembra nato per incarnare le peggiori teorie sul privilegio economico come fucina di criminali: è sospettato di aver ucciso la prima moglie, una vecchia amica e un vicino di casa, però, fino a qui, se l’è sempre cavata; a volte parla di sé in terza persona; quando dice “sono innocente”, sbatte le palpebre con violenza; il bianco dei suoi occhi è appena visibile. Il punto forte di The Jinx. La vita e le morti di Robert Durst è il legame che si forma tra questo personaggio e l’uomo dietro la videocamera. Andrew Jarecki, prima del documentario, ha diretto un film di finzione ricalcato sulla storia di Durst, Love & Secrets. È stato Durst in persona a mettersi in contatto con Jarecki dopo aver visto il film. All’inizio delle riprese di The Jinx, l’autore sa già quasi tutto quello che c’è da sapere sul conto del protagonista: a motivarlo non è la ricerca della verità, quanto la possibilità di stare a stretto contatto con l’oggetto della sua ricerca, filmarlo per ore, da molto vicino, e capire quali confessioni riesce a scucirgli. È un rapporto maniacale. Un ossessivo risolto, con un lavoro socialmente accettabile, va a indagare un ossessivo non risolto e forse pluri-omicida. I due uomini sono cresciuti nella stessa città, appartengono per nascita alla stessa élite del denaro, hanno avuto un rapporto teso e competitivo con le rispettive famiglie. La loro storia è la stessa storia. Jarecki sceglie di raccontarla perché Durst è il suo specchio deformante, il suo worst case scenario. Quando si pone il problema di come raccontarla, la loro storia, quello che manipola è il tempo. Ogni puntata termina con un colpo di scena, aumentando sia la posta in gioco sia l’urgenza interna alla serie: il sesto e ultimo episodio è presentato come se fosse stato girato in fretta e furia, quando così non è stato. L’integrità della storia è contaminata per arrivare a chiuderla sulla nota più alta possibile. The Jinx brilla proprio grazie all’estrema personalizzazione dell’indagine. Non è un documentario: è un diario di lusso, uno strano oggetto privato che viene proposto al pubblico consumo. Il punto di vista è quello del filmmaker che tenta di dare un senso e un ordine a una storia. E la storia, per poter essere raccontata, a un certo punto deve finire.

Serial, stagione uno: “forse lui è colpevole, forse no… ragionevole dubbio?”
La prima stagione del podcast Serial ruota intorno alla storia di Adnan Syed, un ragazzo condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua ex fidanzata, che da quindici anni continua a dichiararsi innocente. È un caso di cui, fino a qui, non parlava nessuno. Tragico, sì: ultra-minore, anche. Prima di Serial, i fatti erano relegati alla cronaca locale della scena del crimine, Baltimora. Per portarli alla luce è necessario un grande lavoro umano: da un lato si va a recuperare il materiale del passato – gli interrogatori della polizia, il diario della vittima –, dall’altro si cerca di ottenere la fiducia delle persone vicine al caso, perché siano loro a parlare, di nuovo o per la prima volta. Allo stesso tempo, Serial sta raccontando una storia che non può essere ricostruita al 100% in nome della certezza. Alcuni personaggi-chiave rifiutano di essere intervistati. Altri ci provano, ma è trascorso troppo tempo, tra i fatti e il reportage, perché i loro ricordi siano davvero chiari e autentici. Lo stesso Adnan potrebbe mentire, la cautela che utilizza nelle conversazioni telefoniche con la giornalista Sarah Koenig potrebbe essere una strategia, così come l’apparente incapacità di spiegare nei dettagli dov’era lui il giorno della scomparsa della vittima. E il programma comincia a essere mandato in onda mentre l’inchiesta è ancora in corso: nessun finale all’orizzonte. Allora Serial diventa un intreccio di storie, dove sono le pause e i pezzi mancanti a parlare. È necessario affidarsi alla guida di Sarah Koenig perché il suo punto di vista aggancia una realtà opaca a una traccia materiale. Una voce, un corpo. Non è un radio-documentario, ma è un testo intimo per forza di cose. A intervalli regolari, Koenig teme di provare troppa simpatia per Adnan, oppure è frustrata dalle risposte di lui, e ragiona, insieme a voi, su cosa può succedere quando si perde il distacco. Il giornalista e l’ascoltatore interpretano una situazione affidandosi ai loro pregiudizi individuali. La storia, qui, è la traccia del passaggio umano attraverso una massa di fatti. Per la seconda stagione, Serial alza il tiro e si dedica a un caso di cronaca militare complesso e sfumato. Gli ascoltatori occasionali abbandonano il campo. Stanno tutti guardando un documentario lungo dieci ore.
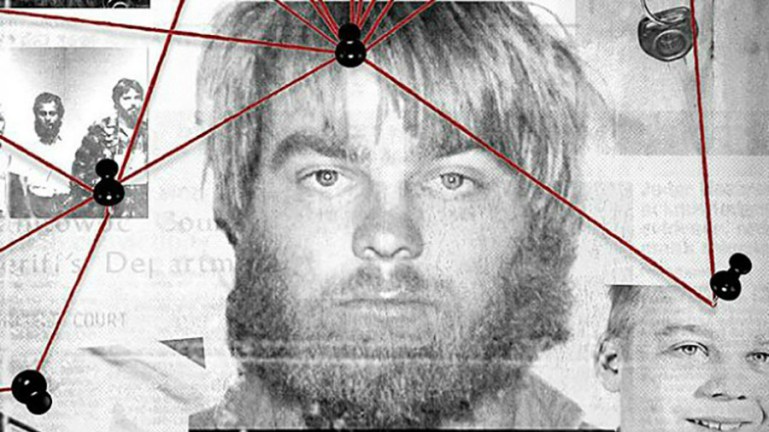
Making a Murderer: “dura dieci ore”.
Ecco la triste storia di Steven Avery, uno sfasciacarrozze del Wisconsin inviso alle autorità locali: passa anni in prigione per un reato sessuale di cui si dichiara innocente, viene scarcerato grazie al test del DNA, fa causa alla polizia… e poi viene accusato di omicidio insieme al nipote adolescente. Avery è diventato un mostro dopo il primo processo? Oppure è l’uomo più sfortunato di sempre, e viene messo in croce per aver reagito agli abusi di potere da parte delle istituzioni? Making a Murderer simula neutralità per un paio di episodi, poi abbraccia in pieno la seconda tesi. Si promette di presentare il materiale senza commenti – nell’arco di dieci ore si intervistano i personaggi coinvolti nel caso, ma soprattutto si portano sullo schermo le riprese del processo. Le telecamere a circuito chiuso, le conferenze stampa. La procedura. Si finge di raccontare una storia con distacco, lasciando parlare i fatti, mentre in concreto non si racconta nulla: si esibisce l’agonia di un tempo reale che non passa mai. Il materiale che mette a disagio sul serio arriva al giro di boa della quarta puntata, con la confessione di Brendan Dassey, un minorenne presunto complice di Avery che soffre di un ritardo mentale non specificato. Per come è presentato il video, in termini di framing e di tempi, è chiaro che la confessione non è genuina. Basta così, non serve altro. Invece il fatto non parla da solo, perché altri frammenti di dolore vengono seminati nelle puntate successive, come le conversazioni tra Dassey e la madre, in cui il ragazzo ogni volta nega di aver partecipato all’omicidio. È un documentario? No. Questo è mobbing verso lo spettatore. È anche una crociata non dichiarata per far uscire di galera almeno uno dei due protagonisti, dove numerose prove a carico di Steven Avery non sono tenute da conto. Eppure a voi piace. Sembra un lavoro accurato: quindi, per voi, lo diventa. Making a Murderer va in streaming su Netflix negli Stati Uniti il 18 dicembre. La prima ondata del suo successo virale parte intorno a Natale, la seconda dopo Capodanno: all’evidenza, per una bella fetta degli abbonati a Netflix, inocularsi dieci ore di telecamere a circuito chiuso urlando “avvocati di merda, sistema corrotto” è preferibile al rivolgere la parola a qualcuno durante le feste comandate. Hanno tutti le loro ragioni.
Se state partecipando a questo boom della cronaca nera, forse siete consumatori affezionati del genere, e adesso avete a disposizione una versione più lunga e più difficile di quello che già guardavate, magari con qualche scatto nella confezione. Se siete arrivati adesso, se siete gli spettatori cool, siete qui perché vi è stato promesso che state per immergervi in qualcosa di molto duro, angoscioso, inguardabile, e vi viene offerto l’alibi culturale per ostentare la vostra nuova abitudine sui social media. È lo stesso meccanismo per cui True Detective (stagione 1) è stato guardato ossessivamente, per qualche settimana, da chi tra di voi non aveva mai letto un romanzo noir, e fino a quel punto evitava con orgoglio tutta la fiction con sbirri e criminali, e di colpo si è scoperto amante del poliziesco nichilista. Il crollo della seconda stagione ha poco a che fare con il cambio di stile e tantissimo con la vostra gestione del tempo, la vostra percezione di cosa è rilevante qui e ora. E con la nascita dello spettatore kamikaze, felice di regalare giorni interi a una storia raccontata in maniera molto, molto faticosa.
Violetta Bellocchio
Autrice di Il corpo non dimentica (2014), ha fatto parte di L’età della febbre (2015), Ma il mondo, non era di tutti? (2016), ha curato l'antologia Quello che hai amato (2015) e la traduzione italiana di The Art of Rivalry (2016). Ha collaborato a Rolling Stone, Vanity Fair, IL, Rivista Studio.
Vedi tutti gli articoli di Violetta Bellocchio


