
Il sistema dell’informazione è in crisi da tempo. Ma spesso si tende a semplificare sotto etichette troppo facili quella che invece è una molteplicità di fattori. L’emergenza ha portato alcuni nodi al pettine, ma sta anche aiutando a chiarirli.
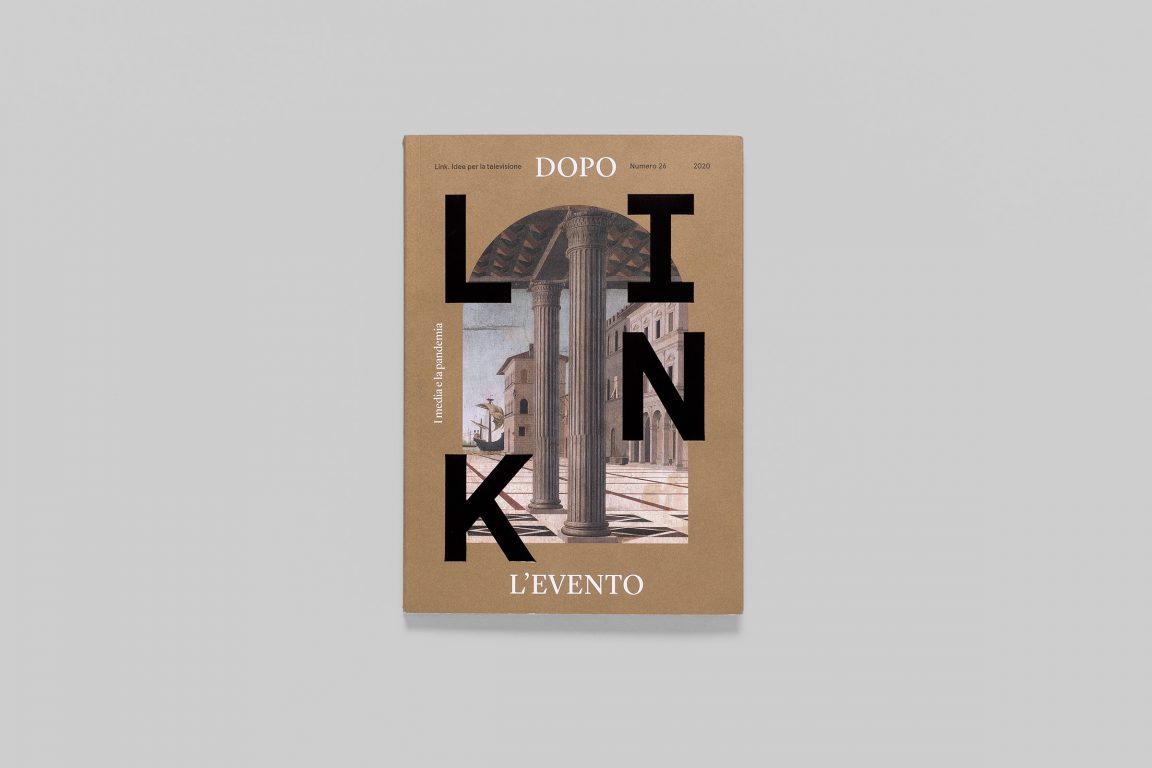
Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 26 - Dopo l'evento. I media e la pandemia del 09 novembre 2020
Dal 2016, sulla scia degli shock politici e culturali scatenati dall’esito del referendum sulla Brexit e dall’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, il ruolo delle tecnologie di comunicazione – e dei social media in particolare – è stato messo al centro di una discussione di amplissima portata che ha toccato numerosi aspetti statutari dell’informazione in questo passaggio storico. A quella discussione, che sin da subito era chiaro stesse andando in direzioni molto diverse e difficilmente conciliabili tra loro, è stata presto affibbiata l’etichetta fake news, adottando un termine diventato di dominio comune anche a causa delle esternazioni di Trump contro i giornalisti meno accomodanti nei suoi confronti, condite dalle medesime scelte lessicali. Abbastanza improvvisamente, a seguire il discorso pubblico verso la fine del 2016, sembrava che l’informazione online e non solo fosse stata investita da un tornado senza precedenti che ne aveva riscritto i paradigmi e gli statuti, mandando in rovina i principi illuministici che avevano fino ad allora ispirato le news contemporanee. Dalla società dell’informazione sembrava insomma di essere passati improvvisamente alla società della disinformazione. Varie voci però, e la storia stessa del giornalismo, hanno dimostrato in modo chiaro come la disinformazione non fosse di certo nata all’improvviso ed esplosa in quei mesi del 2016 che sconvolsero il mondo.
La disinformazione nelle sue varie forme – o la cattiva informazione, più nel complesso – ha inquinato i pozzi della democrazia da sempre, e non si sprecano gli esempi celebri, a cominciare dalle false prove portate a giustificare la seconda guerra in Iraq e apparse in pompa magna anche sui più prestigiosi organi di stampa occidentali, episodio ormai divenuto un topos della distorsione dell’informazione. Ciò che è emerso negli ultimi quattro anni è piuttosto l’estremizzazione di alcune dinamiche tecnologiche specifiche dell’ecosistema dell’informazione contemporaneo e di alcune sue debolezze, che hanno amplificato la presenza e l’evidenza della cattiva informazione. La sfida, nel 2020 post-pandemico inoltrato, è in primis quella di fare ordine in quel macro-discorso a cui è stata data l’etichetta fake news e scorporarlo, per affrontare in modo più analitico – e senza panici morali – le varie fette del problema. In seconda battuta, invece, occorre affrontare questo stato di cose alla luce della pandemia da Covid-19 e delle sue conseguenze, che si sono abbattute sui giornalismi di tutto il mondo, in questo caso sì, come una tempesta perfetta senza precedenti. La consapevolezza dev’essere quella di trovarsi al centro di un guado complesso e cacofonico e di una profonda riorganizzazione sia delle modalità con cui ci informiamo e con cui entriamo in contatto con l’informazione, sia dei ruoli dei vari attori coinvolti, dal giornalismo locale alle grandi piattaforme della Silicon Valley. La pandemia è arrivata nel momento più acuto di questo passaggio, sparigliando ulteriormente le carte in tavola e, forse, spingendo per la messa in soffitta di assunti che non possono più avere spazio nel giornalismo post-coronavirus.
Fake news!
Da subito, il termine fake news ha creato più confusione che altro e non ha contribuito in modo chiaro alla comprensione di un fenomeno ben più complesso di quanto l’etichetta sembra suggerire. Varie voci di esperti e firme del settore, compresa quella di Margaret Sullivan, una delle commentatrici statunitensi più note e celebrate, hanno chiesto l’abbandono di questa etichetta generica, poco chiara e facilmente manipolabile. Il governo britannico, dal canto suo, ha ufficializzato già nel 2018 la messa al bando del termine dai documenti ufficiali prodotti dai suoi organi. Come si può discutere un problema tanto urgente se non vi è una definizione condivisa, o men che meno un consenso generale, su cosa sia una fake news, dicevano tutte queste voci? Ai più scettici partecipanti a questo dibattito sembrava impossibile e finanche assurdo pensare di dare un solo nome a cose tanto diverse come la propaganda politica, i falsi giornalistici in malafede, gli errori giornalistici in buona fede, l’hate speech, lo sfruttamento deviato delle piattaforme e il clickbait. Fake news non spiegava nulla già allora, e le ragioni e cause che possono rendere qualcosa fake, su internet in particolare, possono essere tantissime.
La pandemia ci ha messo di fronte alla realtà di come il disturbo dell’informazione contemporanea vada oltre la dicotomia online/offline. Si tratta di un fenomeno trasversale a tutti i media, compresi quelli più tradizionali e popolari, televisione in primis, che troppo spesso diventano megafoni di contenuti non verificati, malamente raccolti, peggio raccontati e offerti con standard giornalistici bassi.
A mettere ordine a questa confusione ha contribuito in modo decisivo nel 2017 un report redatto per il Consiglio d’Europa, firmato da Claire Wardle e Hossein Derakhshan, divenuto rapidamente un punto di riferimento per la letteratura su questo tema. In quel testo si parla di information disorder (disturbo dell’informazione) e di come il flusso informativo possa essere influenzato negativamente, in quali modi e per quali ragioni. La tassonomia proposta da Wardle e Derakhshan propone di distinguere tra almeno tre forme di disorder: la disinformazione, la misinformazione e la malinformazione. La prima, secondo gli autori, rappresenta il terreno del falso creato ad arte e con intenti malevoli o a scopo di lucro. In questa categoria si possono inserire i vari siti web – o quelli che replicano in modo subdolo siti reali – creati con il solo scopo di pubblicare contenuti totalmente inventati e di farli diventare virali sui social media. Qui ci si trova nella sfera della pura invenzione e degli intenti apertamente negativi: falsi, complottismi, propaganda politica volta a disinformare e distorcere il dibattito pubblico. Quella della misinformazione, invece, è una sfera differente, principalmente caratterizzata da contenuti problematici che sono tali ma in buona fede: errori giornalistici, foto o video usati erroneamente fuori contesto o dati e statistiche imprecise o contestualizzate in modo erroneo. Quello della malinformazione, infine, è un campo meno frequente, caratterizzato da contenuti reali e veritieri ma utilizzati per finalità malevole o per attaccare singole persone e istituzioni per motivi politici o altri interessi specifici. A questo gruppo fanno capo, per esempio, le fughe di notizie o i leak senza particolare interesse pubblico che possono essere sfruttate – o “weaponized” – per scopi politici, come danneggiare una campagna, un esponente o un partito sotto elezioni.
La tassonomia di Wardle e Derakhshan è completa ed esplicativa e mostra chiaramente un aspetto: non si possono considerare tutti questi elementi alla stessa stregua – né dar loro il medesimo nome. Troppo diversi gli attori coinvolti, gli strumenti utilizzati, le tattiche e le finalità, oltre che il loro impatto sul dibattito pubblico. In particolare, questa tassonomia spinge a guardare al fenomeno come se non fosse solo digitale, ma potenzialmente connesso a ogni mezzo di comunicazione. Un fenomeno che tocca tutti gli elementi dell’ecosistema dell’informazione.
L’avvento dei social media ha certamente contribuito in modo dirompente a rendere ancora più complesso il problema del disturbo dell’informazione e ha sicuramente creato forme inedite in cui questo possa nascere e diffondersi capillarmente online, oltre ad aver creato un territorio particolarmente fertile per la creazione e diffusione di contenuti tossici, falsi ed erronei di varia natura. Ma di certo non l’unico. La pandemia, in questo senso, ha offerto uno studio di caso senza precedenti e particolarmente proficuo per avere una panoramica davvero euristica sul fenomeno del disturbo dell’informazione. Felix Simon, ricercatore dell’Università di Oxford e affiliato sia con l’Oxford Internet Institute (OII) sia con il Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) è co-autore di una delle prime ricerche sulle caratteristiche della “cattiva informazione” nel contesto del nuovo coronavirus, pubblicato proprio dal RISJ e guidato da J. Scott Brennen: “la nostra ricerca, svolta all’inizio della pandemia, ha mostrato come la maggior parte della misinformazione relativa al Covid-19 avesse a che fare con varie forme di riconfigurazione, dove informazioni già esistenti e molto spesso veritiere erano rivalutate, riconfigurate o mischiate, mentre meno misinformazione era invece inventata dal nulla”, spiega. “La maggior parte dei contenuti si concentrava sulle azioni o sulle politiche delle autorità pubbliche, inclusi Organizzazione mondiale della sanità e Nazioni unite, ma buona parte si concentrava invece su dove e grazie a chi il virus si stesse diffondendo, oltre a teorie complottiste sull’origine del virus. Ricerche più recenti hanno confermato i nostri primi risultati”.
Colpa dei social!
Ma quale è stato il ruolo giocato dai social media, in questo contesto? Sono effettivamente i canali più pericolosi per la diffusione della mis- e disinformazione? “Se con ‘pericoloso’ intendiamo che molta misinformazione connessa alla pandemia è distribuita tramite i social media, questo è certamente vero, anche se ci manca ancora un’osservazione sistemica, specialmente per quanto riguarda la distribuzione in ambienti digitali chiusi, come le app di messaggistica”, dice Felix Simon. “Le cronache giornalistiche e alcune ricerche iniziali indicano però che questo genere di misinformazione sia prevalente sui social. È però difficile definire questo come ‘pericoloso’ se non conosciamo la sua reale portata, specialmente a confronto con altri media, come quelli tradizionali come la televisione”. Se è palese e innegabile come la cattiva informazione corra veloce e numerosa sui social, è più complesso giungere a conclusioni sul suo effetto o su sul suo impatto sulle persone: “al momento, mancano prove chiare su questo aspetto, anche se alcuni affermano il contrario. Se le persone dichiarano di aver visto misinformazione in giro e dicono nei sondaggi di temere che i politici o i loro amici possano contribuire alla sua diffusione, né questo aspetto né l’esistenza della misinformazione sulla pandemia (anche se su larga scala) necessariamente implicano effetti su larga scala. È una fallacia che potremmo definire ‘esistenza-significa-impatto’”, spiega Simon, che aggiunge: “lo scienziato cognitivo Hugo Mercier ha ribadito come le persone non siano così ingenue o persuadibili come spesso riteniamo. Inoltre, molte persone hanno diete mediali più diversificate e si affidano a più di una fonte, in particolare se si tratta di prendere decisioni importanti: abbiamo visto, per esempio, come durante questa crisi molte persone in numerosi paesi si siano rivolte a fonti affidabili e agli esperti, in cui hanno riposto fiducia. Se è probabile che la misinformazione su Covid-19 abbia alcuni effetti, la sua portata è meno chiara e sopravvalutata nel discorso pubblico”.
Tutti i media, compresi i più tradizionali e popolari, troppo spesso diventano megafoni di contenuti non verificati e malamente raccontati.
Oltre agli aspetti strettamente mediali o tecnologici connessi alla diffusione del disturbo informativo, occorre tenere in considerazione anche le fonti che, per prime, contribuiscono a questo disturbo. E queste fonti, spesso, vengono da molto in alto: “celebrità, influencer e politici come Trump o Bolsonaro”. Spiega ancora Simon, “i nostri dati dicono che la misinformazione dall’alto rappresenta il 20% di tutta quella che abbiamo analizzato, ma conta per il 70% complessivo dell’engagement sui social media. Non è del tutto una sorpresa: le personalità pubbliche hanno seguito maggiore sui social. La misinfomazione è sia top-down sia bottom-up, ma è certo più problematica quando proviene dall’alto, perché raggiunge più persone”. Qualcosa di simile è avvenuto in Italia durante la pandemia, spiega Carlo Canepa, giornalista di Pagella politica, uno dei principali siti di fact-checking in Italia: “nella prima fase dell’emergenza, i politici italiani hanno spesso diffuso notizie false e fuorvianti dal punto di vista scientifico, dicendo che il nuovo coronavirus era stato creato in laboratorio o che la Covid-19 fosse poco più che una normale influenza”. A rendere ancora più complessa la situazione, è sopraggiunta la normale bagarre politica: “il governo ha rivendicato primati che non erano primati, come quello sul numero di tamponi fatti dall’Italia rispetto agli altri Paesi del mondo o sui risultati nel mercato del lavoro, mentre l’opposizione ha paragonato il governo Conte a quello di Viktor Orban in Ungheria o ha fatto confusione sui soldi che gli altri stati europei hanno stanziato per l’emergenza coronavirus”, spiega ancora Canepa, che ha lavorato sulla verifica di numerose notizie durante le settimane più dure della pandemia.
Approssimazione italiana
Anche per il giornalista di Pagella politica, esiste un problema di prospettiva quando si guarda al disturbo dell’informazione in Italia: “alcune recenti ricerche hanno iniziato a mostrare come si tenda a sovrastimare l’impatto della disinformazione online e a sottostimare quella che quotidianamente si trova sui quotidiani, in televisione e in radio”, spiega Canepa. “Quando ho iniziato a fare il fact-checker – tre anni fa – tra gli addetti ai lavori si diceva di concentrarsi di più sul ‘cattivo giornalismo’ piuttosto che sulle ‘fake news’, parola che ormai ha perso di qualsiasi utilità. Per esperienza, nel mio lavoro di tutti i giorni mi accorgo che i contenuti falsi e fuorvianti, diffusi dai politici o dalle persone sui social o al bar, spesso provengono da un lavoro giornalistico fatto con approssimazione”. Per quanto riguarda l’Italia occorre includere anche la tv in questo scenario, poichè, come emerge dai dati più recenti del Digital News Report del RISJ, il piccolo schermo è ancora il medium prioritario per l’informazione in Italia, elemento che paradossalmente si tende a sottovalutare se si parla di mis- e disinformazione: “posso dire con un elevato grado di certezza che spessissimo i contenuti che disinformano sono proprio quelli trasmessi in tv”, spiega Canepa. “Ci sono molti programmi che nella pandemia hanno fatto un pessimo servizio, per esempio invitando costantemente individui che diffondono, ancora oggi, disinformazione sulla Covid-19 e mettendoli sullo stesso piano di autorevoli scienziati”. I contenuti tendono ad avere una circolazione massiccia e molto pervasiva, spesso con ramificazioni imprevedibili: “nelle scorse settimane, ci hanno scritto colleghi da diverse parti del mondo, come la Germania o la Bosnia-Erzegovina, per chiederci una mano nel verificare video di Vittorio Sgarbi che circolavano dalle loro parti e ricevevano migliaia e migliaia di condivisioni. Se la disinformazione di questo tipo raggiunge altri Paesi, figuriamoci che effetti può avere su chi si informa solo guardando la televisione qui in Italia. E questo rende il ruolo della ‘cattiva tv’ ancora più centrale nel dibattito sulla disinformazione nel nostro Paese”.
La pandemia ci ha messo di fronte alla realtà di come il disturbo dell’informazione contemporanea sia sistemico e vada oltre la dicotomia online/offline. Si tratta di un fenomeno trasversale a tutti i media, compresi quelli più tradizionali e popolari, televisione in primis, che troppo spesso diventano megafoni di contenuti non verificati, malamente raccolti, peggio raccontati e offerti con standard giornalistici bassi. La crisi scatenata dalla pandemia ha spinto all’estremo varie dinamiche del fenomeno: i social media come amplificatori dell’emotività e della paura, oltre che terreno di scontro per la propaganda digitale e i giornali online ancora persi in modelli di business basati sull’aggregazione massiccia di like e attenzione, che inevitabilmente spingono alla sovrapproduzione e alla sciatteria. Non basterà solo un intervento tecnologico o di policy per fermare la prima, né soltanto gli appelli in favore della qualità giornalistica per tamponare le conseguenze della seconda.
Nel suo noto saggio On Bullshit (Sulle stronzate), il filosofo statunitense Harry Frankfurt sosteneva che uno dei principali problemi alla base della presenza pervasiva delle bullshit nella nostra cultura fosse l’assenza di una teoria per comprenderne appieno il ruolo. Questo vale anche per il disturbo dell’informazione e della sua cacofonia digitale e non digitale. L’unica strategia efficace è di lungo periodo ed è educativa per natura: formare cittadine e cittadini in grado di leggere con la dovuta consapevolezza tali dinamiche e il funzionamento dell’ecosistema mediale in cui si trovano. Viviamo con certezza nel momento mediaticamente più complesso di sempre, da un punto di vista economico, sociologico e anche tecnologico. Saper passare attraverso il disturbo dell’informazione significa capire dove ci troviamo.
Philip di Salvo
È ricercatore post-doc e docente presso l’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano e la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano. I suoi ambiti di ricerca includono il giornalismo investigativo, la sorveglianza di internet e i rapporti tra informazione e hacking. È autore di Leaks. Whistleblowing e hacking nell’età senza segreti (2019) e Digital Whistleblowing Platforms in Journalism. Encrypting Leaks (2020).
Vedi tutti gli articoli di Philip di SalvoLeggi anche

Cultura digitale
Internet, la televisione trash e Mark Caltagirone

Professioni tv
Media planner chi?

