
Tra i termini più usati, e abusati, degli ultimi anni, c’è “storytelling”. Freccero ricostruisce il concetto e le sue radici, andando oltre le frasi fatte.
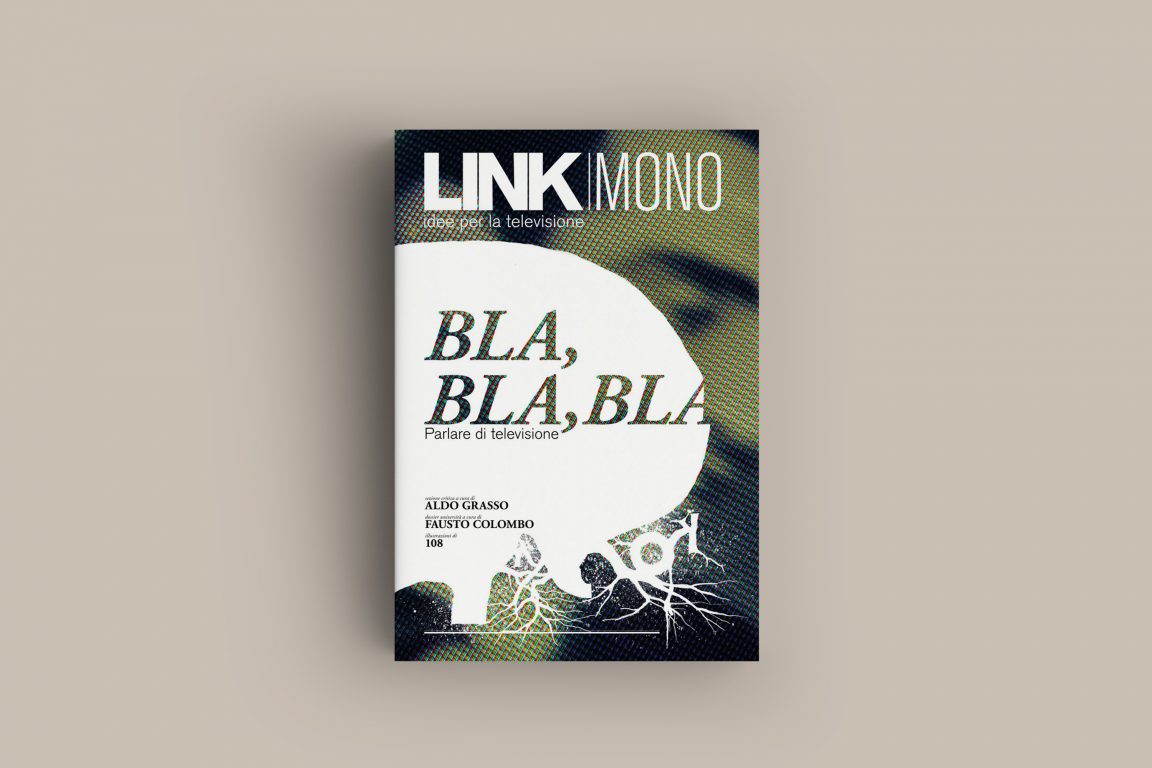
Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Link Mono - Bla, bla, bla. Parlare di televisione del 04 maggio 2009
Storytelling. Il valore del libro di Cristian Salmon, edito in Italia da Fazi, è tutto nella sintesi di copertina: “L’arte di raccontare storie è nata quasi in contemporanea con la comparsa dell’uomo sulla Terra e ha costituito un importante strumento di condivisione dei valori sociali. Ma a partire dagli anni Novanta del Novecento, negli Usa come in Europa, questa capacità narrativa è stata trasformata dai meccanismi dell’industria dei media e dal capitalismo globalizzato nel concetto di storytelling: una potentissima arma di persuasione nelle mani dei guru del marketing, del management, della comunicazione politica, per plasmare le opinioni dei consumatori e dei cittadini”.
È significativo che la stessa frase apra l’edizione francese del libro e la traduzione italiana. Sulla pagina bianca le lettere spiccano in caratteri decrescenti, senza illustrazioni o distrazioni grafiche. Il messaggio è chiaro e perentorio. Il bisogno di raccontare è antico come l’uomo, ma è primario, privo di effetti strumentali. Per la prima volta, il marketing e la comunicazione ne fanno un uso consapevolmente distorto, volto a ottenere un solo scopo: la manipolazione dell’opinione pubblica, dai consumi alla politica, dalla gestione delle aziende alla preparazione alla guerra. Negli anni Sessanta si identificavano potere e sapere. Lo storytelling è il sapere di oggi, non più declinato in chiave razionale e logica, ma tradotto in una sorta di grande racconto, in una parabola capace di catturare la nostra attenzione e i nostri sentimenti.
Storytelling è una ricerca ampia e argomentata, scritta nel linguaggio limpido e chiaro dei testi specialistici anglosassoni. Ma, rispetto al modello inglese o americano, c’è qualcosa di più: il bisogno di svelare una macchinazione, il terrore tipicamente europeo di essere manipolati, costretti ad agire e pensare secondo schemi imposti. Se i testi americani sono manuali per l’azione – alla fine quello che conta sono i risultati –, gli studi europei sono antidoti contro il condizionamento mentale. Ogni nuova lettura ci affranca da una visione “naturale” delle cose. E Storytelling è l’analisi di una manipolazione che investe campi diversi. Prima di tutto i consumi.
Consumo, guerra, politica
Da sempre la pubblicità affina i suoi strumenti per convincerci a consumare. Ma, in seno al messaggio pubblicitario, con lo storytelling si è consumata una rivoluzione. Il discorso dei consumi ha sempre parlato alla nostra ambizione, al nostro ruolo sociale. Compravamo oggetti per sentirci ricchi, importanti, ammirati o semplicemente inseriti e accettati in una comunità, costruita su gusti e consumi condivisi. Oggi invece la pubblicità, attraverso il racconto, parla alla nostra fantasia. Al nostro desiderio di avventura. Mette in scena una storia che condividiamo e che aspira a diventare nostra. Consumare un prodotto diventa condividere un racconto. Costruire, a livello simbolico, un tassello della biografia nostra e di chi fa le nostre stesse scelte.
La rivoluzione non investe solo il consumo, ma anche la produzione. Salmon ci racconta il silenzio che caratterizzava il lavoro nelle fabbriche durante il taylorismo: per lavorare in modo attento e coordinato, era necessario concentrarsi sui gesti invece della comunicazione con i compagni di lavoro. Adesso le aziende sono costruite su narrazioni. L’azienda non è più il luogo della produzione materiale, ma lo spazio di una grande storia che coinvolge dipendenti e consumatori, uniti e cementati dall’illusione di un’esperienza comune.
Lo storytelling rende accettabile persino l’esperienza più sgradevole: la guerra. Pensiamo all’interdetto che l’ha colpita dagli anni Settanta al primo conflitto nel Golfo. Il Vietnam ha avuto un impatto negativo così grande da rendere pacifista un’intera generazione: i giovani bruciavano le cartoline, l’Occidente e gli stessi americani tifavano per il nemico. La causa di questa violenta avversione è la presenza di un medium, la fotografia, sui campi di battaglia. Reporter indipendenti documentavano per la prima volta gli orrori della guerra, i corpi devastati dal napalm, la pistola alla tempia di una bambina terrorizzata. La violenza dell’immagine visiva ha reso a lungo impresentabile ogni forma di conflitto. Ancora durante la prima guerra del Golfo una totale censura colpiva le azioni di guerra. E Baudrillard, grazie all’assoluta mancanza di immagini, poté affermare che questa guerra non aveva mai avuto luogo. Lo storytelling riabilita la guerra costruendo racconti a partire dalle immagini. Pensiamo alla liberazione della soldatessa americana prigioniera degli iracheni: una storia di fantasia, su cui la Fox ha costruito una fiction degna dell’epopea. L’interdetto dato dalla brutalità dell’immagine può essere finalmente rimosso, facendo dell’immagine un momento della narrazione: un fotogramma di film di guerra degli anni Cinquanta, l’età dell’oro in cui valori come il patriottismo e il coraggio non erano ancora stati messi in discussione dall’empatia nei confronti del nemico.
Oggi la pubblicità, attraverso il racconto, parla alla nostra fantasia. Al nostro desiderio di avventura. Mette in scena una storia che condividiamo e che aspira a diventare nostra. Consumare un prodotto diventa condividere un racconto. Costruire, a livello simbolico, un tassello della biografia nostra e di chi fa le nostre stesse scelte.
Salmon analizza lo storytelling applicato alla guerra attraverso i videogiochi usati dall’esercito: da un lato per reclutare volontari via internet, dall’altro per addestrare le truppe al conflitto. Una delle caratteristiche principali del videogioco è quella di permettere al giocatore di consumare in prima persona una grande quantità di azione, senza esserne coinvolto emotivamente e senza provare empatia. In questo senso è figlio dei cartoni animati, di cui già negli anni Quaranta Adorno denunciava l’estrema violenza unita all’assoluta mancanza di eco emotiva. I personaggi si affrontano in un gioco crudele in cui a turno vengono fatti esplodere, si appiattiscono al suolo, precipitano in un dirupo. Ogni volta la vittima si rialza e riacquista la forma originaria, annullando totalmente gli effetti della violenza. Il videogioco diventa così l’ideale per preparare alla guerra: suggerisce una violenza leggera e priva di conseguenze. Tanto che, in un processo contro un militare accusato di aver provocato una strage senza validi motivi, l’avvocato della difesa addusse – secondo Salmon – la giustificazione che l’assistito si era limitato ad applicare alla lettera quanto appreso con l’allenamento sui videogiochi.
Infine, lo storytelling condiziona pesantemente la vita politica. Il primo narratore prestato alla politica è indubbiamente Reagan, che ha costruito la sua carriera sul sogno americano. Presto l’epopea è diventata il cavallo di battaglia repubblicano. Caso esemplare è la storia di Ashley, una ragazza traumatizzata dalla perdita della madre in seguito all’11 settembre, su cui si è basata buona parte della seconda campagna elettorale di George W. Bush. Sull’immagine del suo abbraccio al presidente è stata costruita una storia che ha commosso il paese. E che ha parlato di sicurezza molto più di quanto avrebbe potuto fare un elenco dettagliato di misure pratiche. Il pubblico chiede narrativa. Ed è un processo che non riguarda solo gli Usa, ma pure l’Europa. Basti pensare a Sarkozy. O, come noi italiani sappiamo bene, al fatto che uno dei tanti gesti di Berlusconi, una volta sceso in politica, è stato rivolgersi al paese con un libro illustrato, Storia di un italiano, inviato a ogni famiglia e dedicato a un solo soggetto: la storia della fortuna e degli amori del candidato a presidente del Consiglio.
Breve storia della narrazione
Sotto la massa di materiali e di notizie che Storytelling sottopone sono presenti temi più generali. Spunti per un libro ancora da scrivere. Se a partire dagli anni Novanta lo storytelling pervade ogni dimensione della vita pubblica, l’arte di raccontare – da espressione spontanea dell’uomo e del suo bisogno di avventura – diventa improvvisamente strumento di manipolazione e di condizionamento.
Perché, improvvisamente, la narrazione diventa più efficace di un’esposizione argomentata delle cose? La narrazione è antica come l’uomo, è vero. Ma non è un dato assoluto o perentorio. Le culture antiche si esprimono con narrazioni, come pure le religioni. La Bibbia è un insieme di storie, e il Vangelo rende comprensibile il suo messaggio ricorrendo non ad argomenti logici ma a parabole. Il mondo classico si basa sul mito, e la parola mito, in Grecia, significa narrazione.
C’è però un lungo periodo in cui la cultura umana si sottrae al fascino della narrazione: è il passaggio dal mito al pensiero razionale avvenuto nel V secolo a.C. con la nascita della filosofia, per protrarsi fino all’epoca moderna. Il pensiero occidentale si sviluppa secondo criteri rigorosi, ponendo basi razionali a ogni sfera umana: come la politica, la morale e in generale la vita associata. Secondo il saggio Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza di Julian Jaynes, è la comparsa della scrittura a consentire il passaggio dall’emotività alla logica, dall’uso prevalente dell’emisfero cerebrale destro, sede della creatività, a quello dell’emisfero sinistro, sede delle capacità verbali. La pagina scritta, permanente, obbliga il cervello umano a un rigore prima sconosciuto. E questa prima vittoria del rigore sulla fantasia giunge all’estreme conseguenze con la stampa, come dice McLuhan ne La galassia Gutenberg.
Questo filo, che si sviluppa dall’antichità al Rinascimento, trova compiuta espressione nell’Illuminismo. L’epoca moderna è espressione di razionalità espositiva. Ma l’ordine entra in crisi nella dimensione postmoderna in cui ancora ci muoviamo. Il moderno è il momento delle grandi narrazioni. Ma queste non significano narrazione in senso tradizionale. Sono le utopie politiche, la Fenomenologia dello spirito di Hegel o Il capitale di Marx. Non raccontano storie individuali, ma quelle di un soggetto collettivo: lo Spirito, il Proletariato. Prevedono necessità storiche che troveranno attuazione attraverso l’intervento umano o per leggi naturali, ma che non riguardano il privato. La narrazione si fa saggio, parla per universali e si appella alla nostra ragione. La politica rappresenta una scienza, una strategia: non parla all’immaginario. Mentre la narrazione pura è relegata alla sfera del divertimento. L’uscita dalla modernità non è legata solo al tramonto delle grandi filosofie capaci di parlare in nome di una verità universale, ma è legata anche all’affermazione di media che, come scrive Lyotard ne La condizione postmoderna, rivoluzionano il nostro modo di pensare e di sentire.
La pagina scritta richiede rigore, la società dell’immagine parla all’emotività. In un periodo limitato di tempo, si susseguono nuove tecnologie che alterano la nostra percezione delle cose, la nostra visione del mondo. Io stesso ho visto succedersi tre generazioni mediaticamente diverse. La mia generazione, quella dei baby boomers, ha imparato a leggere e scrivere prima della televisione. E anche quando è nata, l’ha conosciuta, scrive Debray, come “un complemento della pubblica istruzione”, strumento visivo completamente al servizio della cultura libresca, il cui scopo era insegnare a leggere agli analfabeti, divulgare la letteratura con gli sceneggiati, diffondere nozioni con i quiz. La generazione dei quarantenni è quella che ho battezzato, con un programma creato in Francia per le reti pubbliche, Les Enfants de la télé. I figli dalla televisione crescono con i telefilm americani e l’immaginario di Hollywood. Ma è solo l’ultima generazione, i consumatori di videogiochi, a essere coinvolta in prima persona, e dall’interno, nei meccanismi della narrazione. I giovani possono accettare una vita da precari anche perché il loro immaginario è nutrito dalla partecipazione a una serie infinita di storie di cui si sentono parte integrante perché, per la prima volta, ne sono coinvolti in prima persona. Possono marciare e lottare con le legioni romane e instaurare duelli con i pirati. Possono creare nuove identità giocando o chattando su internet.
Il ruolo della televisione va oggi ripensato soprattutto nella chiave di un nuovo universo immaginario. C’è fame di storie, di intrecci, di narrazione. C’è voglia di connessione e di comunicazione.
L’immateriale della pubblicità
La dimensione immateriale ha sostituito progressivamente la società dei consumi materiali. Così la pubblicità deve rivolgersi alla sfera dell’immaginario, tramite la narrazione. Per esempio, per Salmon lo storytelling interviene a ridare credibilità a marchi storici appannati dalle denunce per sfruttamento del lavoro minorile. Come la Nike, azienda priva di fabbriche proprie, costruita sul design e sulla creazione di uno stile di vita. No Logo di Naomi Klein rivela la delocalizzazione della produzione e il bagaglio di sofferenze legato alla fabbricazione dei prodotti: un simbolo che esprime libertà e leggerezza designa improvvisamente fatica e dolore. Salmon inizia dove finisce No Logo. Dieci anni dopo, lo storytelling ricrea, con il fascino del racconto, la verginità di un marchio pesantemente coinvolto nello sfruttamento della globalizzazione. Ma, secondo me, non si tratta solo di questo.
Gli anni Ottanta sono stati quelli della tv commerciale e dell’esplosione dei consumi materiali. Come ci insegna Ginger e Fred di Fellini, la prima società dello spettacolo è fatta di consumi primari: zamponi e lenticchie, ma anche pelati, detersivi e prodotti per l’igiene personale e della casa. L’avvento del pret-a-porter e della pubblicità promuove lo yuppismo degli anni Ottanta, che si protrae fino ai Novanta. I consumi sono vissuti sempre più come simboli di status. Già in Marx è presente un carattere feticcio della merce che trascende il puro consumo materiale, e già i classici della sociologia fanno dei consumi la chiave per leggere la differenza di status. Nell’America descritta da Veblen ne La teoria della classe agiata i consumi esprimono opulenza e benessere, ostentando l’impegno economico che ne è alla base. Nel più complesso universo europeo descritto da Bourdieu ne La distinzione si declinano invece secondo i due assi del capitale economico e culturale. Anche qui sono simboli di status, ma nell’universo europeo non è solo la ricchezza a simboleggiare prestigio sociale, ma anche la cultura in senso tradizionale. Il capitale economico ostenta ricchezza con consumi vistosi all’americana, il capitale culturale ostenta distinzione con consumi che implicano formazione culturale, educazione e gusto.
Oggi questo universo si è almeno in parte ridimensionato. I consumi dei giovani e delle classi emergenti riguardano soprattutto la sfera dell’immateriale. L’11 settembre e poi la crisi economica hanno ridimensionato l’esibizione di ricchezza. I consumi tradizionali sono in flessione, mentre resistono quelli relativi alla comunicazione: telefonini, computer, iPod, iPhone, videogiochi, televisori digitali. I giovani non aspirano allo zainetto firmato, vogliono media con cui stabilire contatti e stimolare la fantasia.
C’è tutta una serie di prodotti obsoleti che risalgono alla rivoluzione industriale precedente. Come i bisogni primari della Prima rivoluzione industriale sono stati sostituiti dagli status symbol degli anni Ottanta, così oggi questi ultimi ci appaiono superati e sostituiti dalle icone del nuovo immaginario. Per questo, secondo me, lo storytelling non ha tanto il compito di cancellare l’immagine dello sfruttamento connesso alla produzione delle merci della generazione precedente, quanto la vocazione di reinventarle, rendendole compatibili con un universo narrativo immateriale. Un televisore è assemblato in qualche fabbrica delocalizzata, da mano d’opera locale mal pagata, ma la sua vendita non conosce flessioni. Il suo valore d’uso non soddisfa bisogni materiali, ma ha il compito di nutrire l’immaginario. E nutrire l’immaginario è sempre più il compito della televisione di oggi in un universo simbolico complesso.
Ripensare la televisione
Abbiamo assistito a diverse fasi della tv. Lo spirito didattico del servizio pubblico, sostenuto dal canone e senza influenze rilevanti della pubblicità. Poi la tv commerciale degli anni Ottanta, completamente al servizio della pubblicità e del marketing. E la pay tv di oggi, sostenuta dagli abbonamenti e in grado di erogare in abbondanza contenuti premium, dal calcio ai film di prima visione.
Il ruolo della televisione va oggi ripensato soprattutto nella chiave di un nuovo universo immaginario. C’è fame di storie, di intrecci, di narrazione. C’è voglia di connessione e di comunicazione. La nuova tv che sta nascendo sulla piattaforma digitale terrestre può rispondere a questi bisogni perché dispone di una molteplicità di reti che depotenziano, di fatto, il modello tradizionale generalista. A questo universo multimediale e multinarrativo mi sono ispirato per Rai4. Il bisogno di narrazione si costruisce con i videogiochi, ma trova la massima espressione nelle serie tv, dall’intreccio articolato. Il bisogno di connessione e di comunicazione si riversa in prima battuta su internet e le varie forme di telefonia, ma può trovare in tv il luogo del confronto e della sintesi.
Questo nuovo modello non è più al servizio del marketing, ma fornisce ispirazione per la pubblicità, che acquisisce una nuova immagine. Ieri gli inserzionisti imponevano l’immagine della rete. Ora è il messaggio pubblicitario che tenta di adeguarsi alla rete. Per suggerire che il suo prodotto non è più così obsoleto. Che, in fondo, anche un’automobile o una scarpa possono parlare alla nostra fantasia, anziché parlare di noi e del nostro tenore di vita.
Carlo Freccero
Nella sua lunga carriera televisiva, è stato responsabile del palinsesto di Canale 5 dal 1979 al 1983, quando è passato a Italia 1 e poi a Retequattro. Nel 1985 assume la direzione di La Cinq. È direttore di Italia 1 dal 1987 al 1992, poi torna in Francia come responsabile di France 2 e France 3. Nel 1996 dirige Raidue e poi lancia Rai 4; infine torna a Raidue nel 2018. È stato consigliere d'amministrazione della Rai dal 2015 al 2019. Insegna presso l’Università di Genova.
Vedi tutti gli articoli di Carlo FrecceroLeggi anche

Mediaset e il cinema italiano
Nobilitare la tv privata. La serie Amori


