
Una storia vera, su cui il mondo intero si è fatto un’opinione. La sfida di American Crime Story è rappresentare migliaia di fonti e migliaia di voci insieme.
In una storia che ruota intorno a cento personaggi, tutti reali e tutti importanti, non ci dobbiamo stupire che uno dei protagonisti entri in scena dalla porta di servizio, come se volesse imbucarsi a una festa. Siamo al quinto episodio di American Crime Story: Il caso O.J. Simpson. Ecco la scena: il processo sta per iniziare, lo scrittore Dominick Dunne è l’inviato speciale di Vanity Fair; il giudice, Lance Ito, lo convoca nel suo ufficio. “Ho letto i suoi articoli”, dice il giudice, “non credo che lei sia qui per fare una cronaca imparziale”. No, Dunne ha già maturato un’opinione sulla colpevolezza di O.J., glielo conferma. “Le darò un posto fisso in tribunale”, dice il giudice. “La metterò accanto ai familiari delle vittime. Lei può capire quanto sia delicata la loro situazione”. Dunne conferma. Sua figlia è stata ammazzata, lui purtroppo lo sa, cosa si prova. E aggiunge: “il processo per noi fu una tortura, l’imputato se la cavò con una condanna minima… spero che stavolta vada meglio”. “Sì, certo. Vuole vedere chi mi ha mandato l’autografo oggi?”. Dal cassetto il giudice tira fuori la foto di un conduttore di talk show. La dedica recita “tante care cose a lei e alla sua signora”. La faccia di Dunne tradisce un piccolo sussulto. Ah, capisco. Cominciamo bene. Durante il processo, però, è Dunne che snocciola aneddoti e pettegolezzi sul caso, seduto a capotavola alle cene dei suoi amici ricchi. Ho sentito dire questo, ho sentito dire quello. E tutti lo ascoltano. Tutti hanno fame di dettagli sordidi, tutti amano l’uomo che li racconta.
Questa scena è assolutamente reale. A parte la faccenda della foto autografata, che è successa, ma pare abbia coinvolto un altro inviato. Il resto potrebbe andare in onda col sottotitolo: no, fidatevi, ci sono le prove. Gli archivi di Vanity Fair conservano tutti gli articoli di Dominick Dunne. Il primo era un reportage sulla morte della figlia Dominique Dunne, uccisa dall’ex compagno, e sulla sua esperienza di padre in lutto durante un processo-farsa. Dopo tanti alti e bassi, a settant’anni, era l’osservatore più influente del caso Simpson: lo paragonava a “un grande romanzo trash che ha preso vita” e lo utilizzava per tornare nelle grazie di un mondo professionale che l’aveva rifiutato quando lui aveva prodotto un brutto film di troppo. Ma i suoi articoli erano appassionanti, amari, pieni di informazioni. Erano i più letti. Court TV trasmetteva il processo in diretta, ma il pubblico voleva sapere cosa stava succedendo nei corridoi del tribunale, nei ristoranti dove pranzavano gli avvocati. Voleva i dettagli che Dunne era molto bravo a raccogliere – con lui parlavano le star, i poveri, i matti, i sani. Certi dettagli non hanno prezzo né data di scadenza. Tantissimo di quello che Dunne ha scritto tra il 1994 e il 1996 finisce oggi nel calderone di American Crime Story. La serie, in teoria, è l’adattamento di un libro solo – The Run of His Life, scritto dal giornalista del New Yorker Jeffrey Toobin –, ma in concreto prende spunto da qualsiasi biografia, memoriale, intervista, documentario o servizio tv sia mai stato generato da O.J. Simpson. Migliaia di fonti, migliaia di voci. Nei primi due anni erano già in commercio 67 libri sul caso. Tutti, presto o tardi, hanno offerto la loro versione dei fatti. Dunne è arrivato per primo, con un diario tragicomico delle sue giornate da inviato (“All O.J., All The Time”): sveglia all’alba, rassegna stampa, in tribunale dalle nove alle cinque, ritorno in albergo, un paio d’ore di tg e approfondimenti, e poi, la sera, cena o cinema con gente che parlava solo del processo. Non c’erano altri argomenti, nei quindici mesi tra l’omicidio e il verdetto. Nessuna linea separava il lavoro dalle relazioni sociali. “O.J. ha preso il controllo della mia vita”, scriveva. Però, documentando questo controllo, diventando il fedele narratore di se stesso, Dunne si è garantito un posto nel mondo. Allora come oggi.
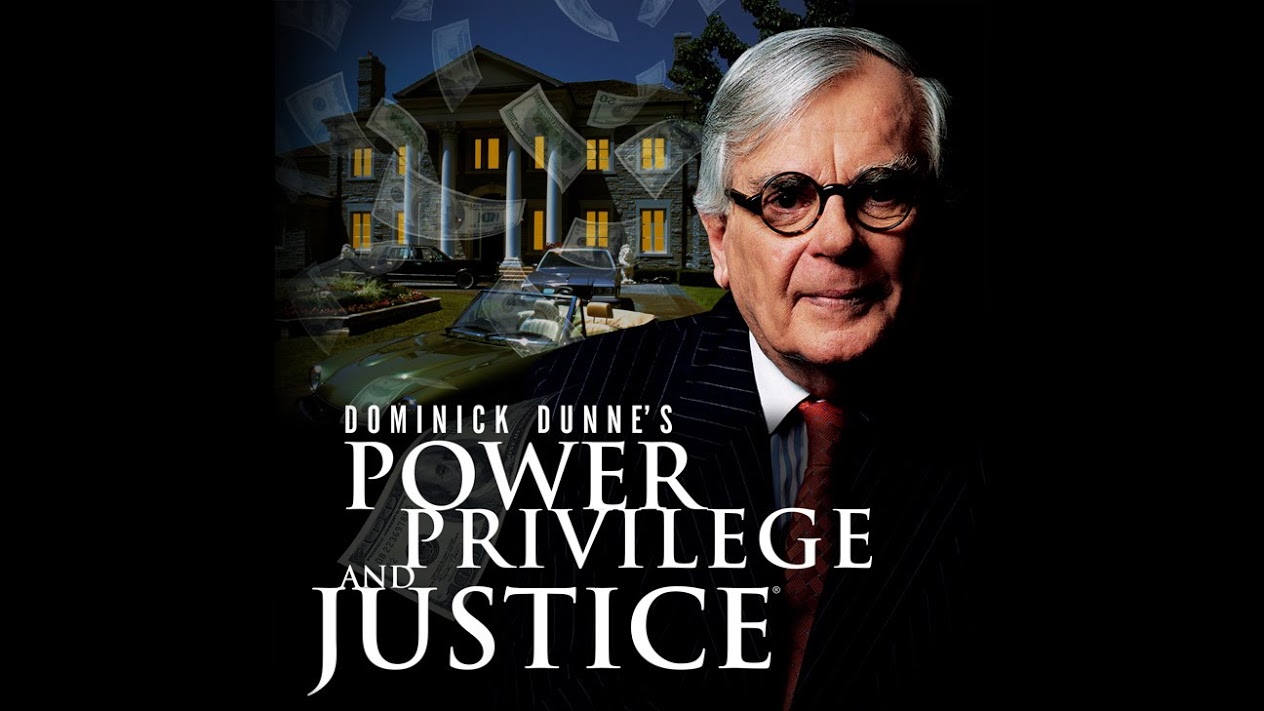
Con il beneficio della distanza, il caso Simpson ha un significato diverso per ogni persona. Qualcuno ci vede una storia di estrema tensione razziale, con i difensori di O.J. schierati contro la polizia bianca, e gli accusatori sospettati di agire in base ai loro pregiudizi sui neri. Per qualcuno è la nascita del reality show come formula per l’intrattenimento di massa, dato che l’indagine e il processo coincidono con l’affermazione dei canali all news 24 ore su 24, e rendono famose tante persone che non sembrano possedere talenti particolari. Sono tutte interpretazioni possibili, se vogliamo giustificare l’esistenza di una serie tv ambientata nel passato recente, e vogliamo chiederci perché è stata girata proprio adesso. Ma American Crime Story non deve giustificarsi. Non ci prova nemmeno. Il suo obiettivo è molto più alto: vuole raccontare tutto il mondo. Illuminare una “storia vera” nel periodo in cui stava cambiando la nostra percezione del vero.
In primo piano, per il racconto di tutto il mondo, viene messo il reale. I fatti, la cronaca, le testimonianze. È possibile ricostruire i movimenti dei personaggi, perché tutti hanno lasciato una traccia, tutti, presto o tardi, hanno parlato. Se quella traccia suona grottesca e inspiegabile, la responsabilità ricade sul personaggio in questione. American Crime Story è una mappa dell’inconscio collettivo nel primo momento dell’umanità in cui chiunque voleva dire la sua poteva farlo. Se avete mai digitato su una tastiera la parola “Simpson”, voi siete qui. Se avete mai rilasciato una dichiarazione sul caso, anche solo due battute al microfono aperto di una radio locale, voi siete qui. Se avete mai detto “negro”, se avete preso un aereo per gli Stati Uniti negli ultimi vent’anni, voi siete qui. La realtà è grande e indisciplinata. Prima degli sceneggiatori, sono i personaggi che devono capire quale posizione prendere. I furbi, come gli avvocati difensori, intuiscono il potere e il pericolo di questa ondata di reale, capiscono che bisogna incanalarla, selezionare i materiali con cura, ricavarne una storia convincente. I furbi rimettono in ordine la casa di O.J., per dimostrare alla giuria che l’imputato è un uomo perbene, al di sopra di ogni sospetto: via le foto di donne bianche, sui muri si appendono quadri edificanti e ritratti di afro-americani. I buoni, invece, credono di poter vincere presentando i semplici fatti, le cose come sono, disordinate, rauche e sgraziate, alle volte, e ci rimediano una brutta figura dietro l’altra. Il loro reale è molto più vero, ma non è la storia migliore.
American Crime Story non deve giustificarsi. Vuole illuminare una “storia vera” nel periodo in cui stava cambiando la nostra percezione del vero.
L’insistenza sui fatti non sta nell’occhio di chi guarda: ogni puntata ci ricorda che la storia vera è qui, davanti a noi. Ma portare in scena tutto quanto è documentabile lascia un grande margine di autonomia agli autori. La loro creazione è il dare una motivazione profonda ai personaggi, costruire un tessuto emotivo che si muove in parallelo alle decisioni, le forma, le rende possibili. È molto eccitante, da spettatore, vedere una storia pubblica raccontata con tanta attenzione e tanta libertà insieme. È possibile che l’amico fraterno di O.J., strada facendo, abbia qualche dubbio sull’innocenza dell’imputato? Certo, perché no. Allora Robert Kardashian diventa la chiave umana di tutto il processo, un privilegiato che deve rimettere in discussione la sua vita, la sua verità. È possibile che una donna avvocato, una persona logorata dai media che ne deridono l’aspetto fisico e i problemi sentimentali, venga sollecitata a rifarsi il look per risultare più simpatica? È possibile che l’avvocato reagisca molto male al suggerimento, ma per un attimo, solo un attimo, lei si illuda che un nuovo taglio di capelli possa alleggerirla da tutta questa pressione? Certo, perché no. Ecco Marcia Clark che si affida al parrucchiere con un accenno di sorriso. È possibile che uno dei difensori voglia far assolvere O.J. per segnare un punto a favore della sua razza, visto che lui ha affrontato tanta vera discriminazione e tanti veri poliziotti corrotti? Certo. Ed ecco Johnnie Cochran che prova i suoi discorsi a casa con la moglie, sussurrando “questo è il mio destino”, e poi offre consigli ambigui all’avvocato nero della controparte. Non sporcarti le mani. Certe cose falle fare ai bianchi.
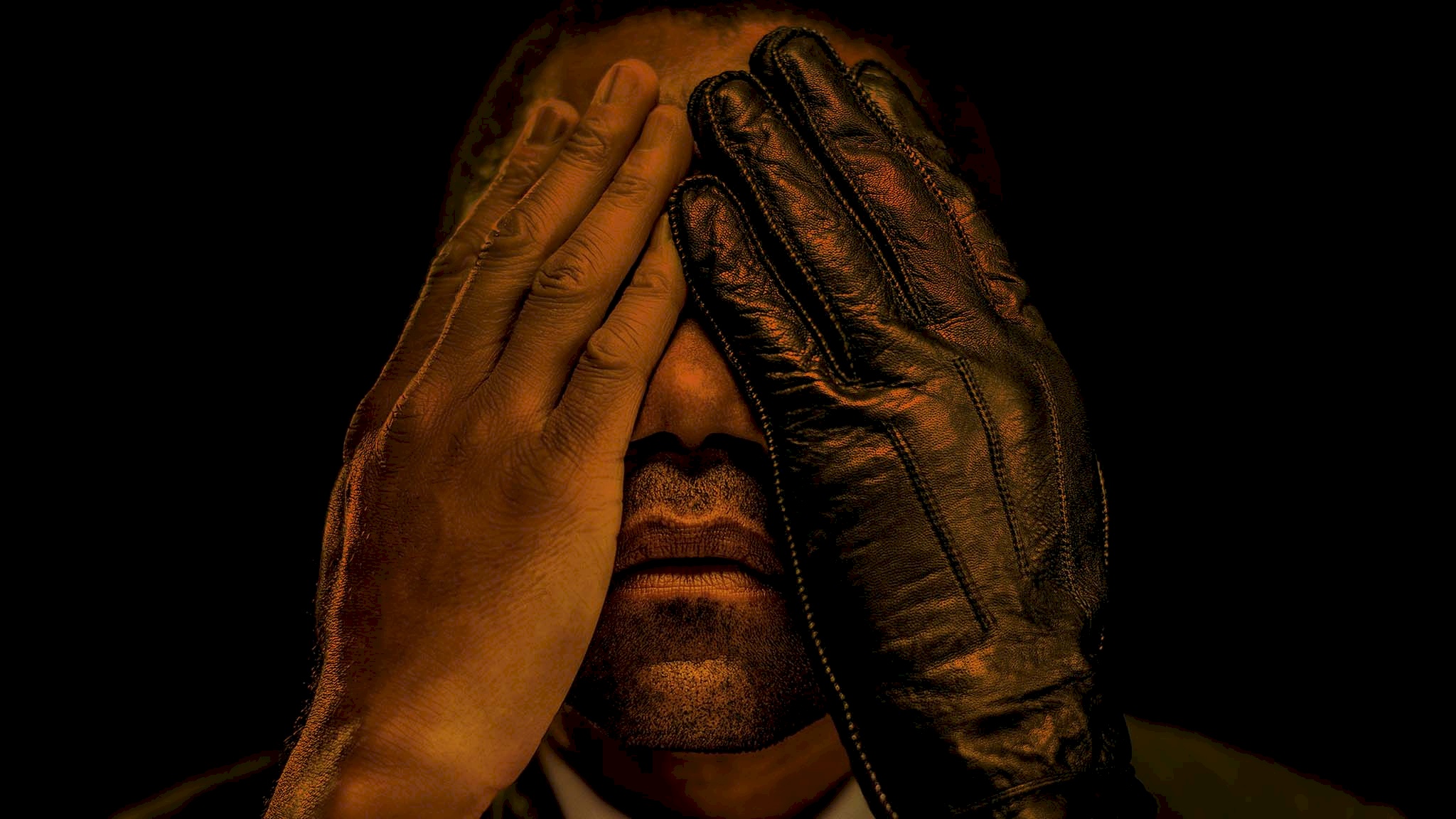
Una vecchia regola delle ricostruzioni storiche voleva che i grandi fatti epocali restassero sullo sfondo, e in primo piano ci fosse un personaggio di finzione, magari ispirato a numerosi uomini e donne reali. Qui non si può. Qui tutti sono reali: a noi viene chiesto di metterci nei loro panni, di provare a sentirci come si sentivano loro in un certo momento. È la soluzione più facile, forse, la più immediata, ma ha un valore anche sul piano morale. Il caso Simpson, vent’anni fa, è stato davvero un calvario di emozione, quindici mesi di grida e insulti, dove gli umori collettivi dominavano la discussione legale, e gli eccessi, in ogni senso, venivano interpretati come un’estensione diretta dei pensieri e desideri del pubblico.
Dominick Dunne è un personaggio di questa storia, uno tra i tanti. Ma non si poteva raccontare la storia facendo a meno di lui. “Il sindaco del tribunale”, lo chiamavano. La sua cronaca non è mai stata imparziale, il racconto personale era la sua cifra di scrittore. Dopo il verdetto condusse una lunga serie di documentari true crime, Power, Privilege and Justice, con parecchi episodi basati sui suoi articoli e libri. Si era ritagliato il ruolo della vecchia volpe che le aveva viste e sentite tutte, ma era anche un testimone eternamente disturbato dallo spettacolo umano in cui gli toccava vivere. Dunne era quel processo. Per come ci è raccontato, oggi, è una persona danneggiata che cerca di dare un senso alla propria presenza in un momento da cui nessuno è destinato a uscire rimanendo del tutto coerente e fedele a se stesso.
Violetta Bellocchio
Autrice di Il corpo non dimentica (2014), ha fatto parte di L’età della febbre (2015), Ma il mondo, non era di tutti? (2016), ha curato l'antologia Quello che hai amato (2015) e la traduzione italiana di The Art of Rivalry (2016). Ha collaborato a Rolling Stone, Vanity Fair, IL, Rivista Studio.
Vedi tutti gli articoli di Violetta BellocchioLeggi anche

Serie tv
I May Destroy You ribalta tutto

Videogame
Le scienze in gioco

