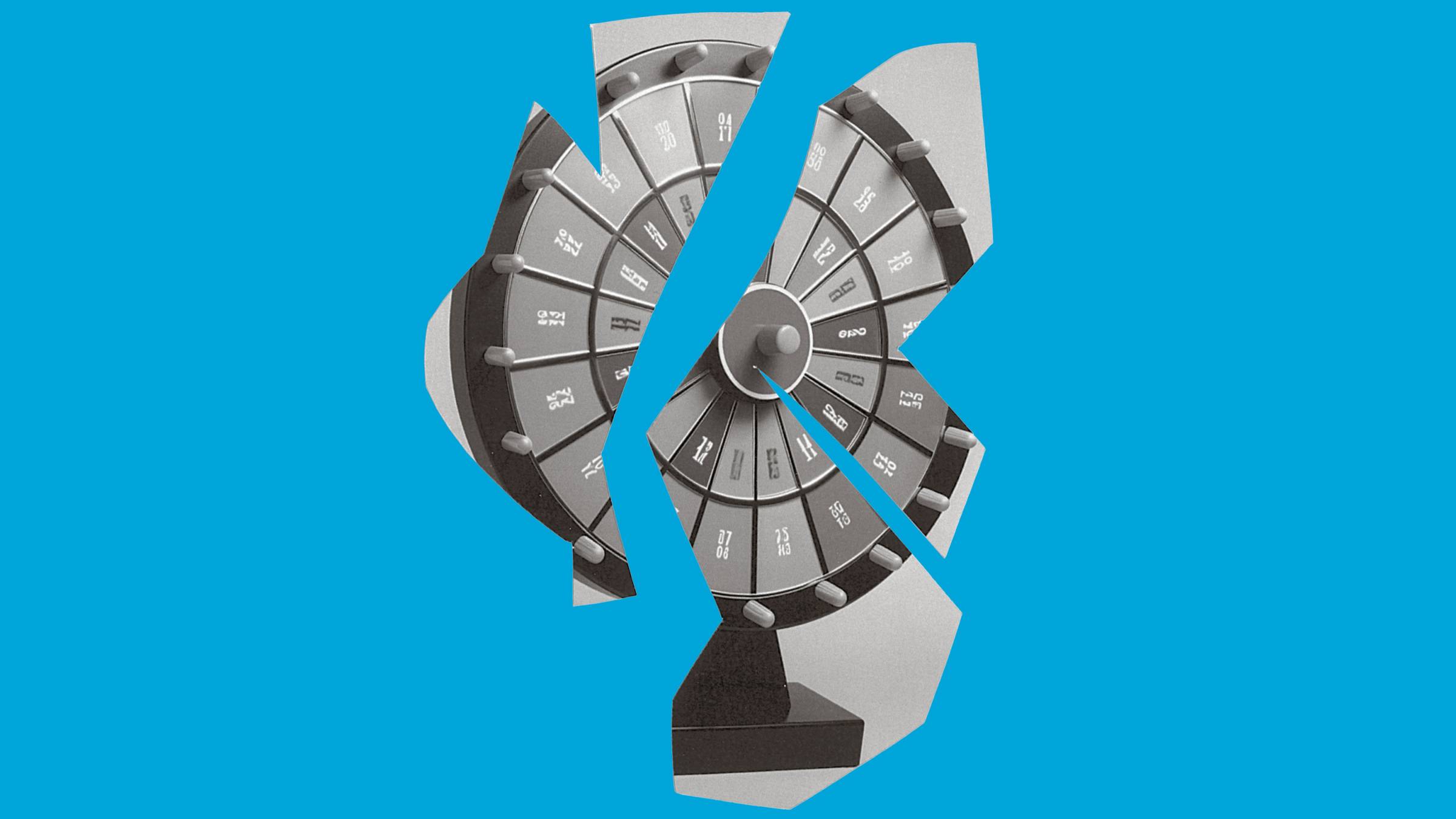
Dopo gli anni dell’esplosione, le piattaforme audiovisive digitali stanno attraversando un ripensamento profondo. Alla ricerca di un modello di business sostenibile, devono rimangiarsi la radicale novità dell’on demand sul piccolo schermo.
Si nasce incendiari, si diventa pompieri. Se ricostruiamo a grandi linee le traiettorie nell’ultimo decennio delle piattaforme audiovisive on demand, è facile ricorrere a questa piccola variazione su un detto celebre. Nel giugno 2015, quando dopo mesi di anticipazioni e voci che si rincorrevano Netflix ha annunciato ufficialmente il suo approdo in Italia, lo ha fatto per prima cosa con una lunga intervista all’allora Ceo e fondatore Reed Hastings sulle pagine dell’edizione locale di Wired. In copertina, troviamo Hastings, in giacca e cravatta, che si appoggia a un vecchio televisore, di quelli molto grandi, fatti di legno e dall’ingombrante tubo catodico, mentre con la mano destra si avvicina alla manopola; sullo schermo, piccolino, e immaginiamo tremolante, ovviamente in bianco e nero, leggiamo il logo dell’azienda; accanto c’è il titolo trionfante, “Questo signore spegnerà per sempre la vecchia tv”. Tra le risposte dell’intervista, compare anche l’invito a valutare gli obiettivi e i risultati della piattaforma solo dopo sette anni. Questo lasso di tempo è passato, e molte cose sono cambiate: Hastings non è più a capo dell’azienda, Wired Italia ha sospeso le pubblicazioni cartacee mensili, c’è stata una pandemia, ma la “vecchia tv” è lungi dall’essere spenta per sempre. Di più, proprio le basi della televisione generalista e della programmazione lineare sembrano diventate ora il reale modello, sottotraccia, delle piattaforme. Nella prima fase del loro sviluppo, di una diffusione prima statunitense, poi occidentale, infine globale, la parola chiave adottata dalle piattaforme quasi come un manifesto, una dichiarazione di intenti, è stata disruption. La rottura dell’esistente, la creazione di un’alternativa radicalmente diversa, e (sottinteso) migliore al vecchio regime. Ecco allora l’abbondanza di un’offerta pressoché infinita invece del contagocce dei broadcaster, la possibilità di vedere tutto quando, dove e come si vuole, il potere creativo affidato a dati e algoritmi, la grande abbuffata del binge watching al posto delle attese del palinsesto, la libertà creativa e di budget totale data ad autori che non devono più confrontarsi né con le necessità dei network né con le interruzioni degli spot, e così via. Regole altre, in un mondo altro. Dopo gli entusiasmi iniziali, però, la realtà ha presentato il conto – soprattutto economico. Per continuare a crescere, per restare sul mercato, per funzionare, una dopo l’altra le grandi aziende dello streaming sono dovute scendere a patti con tante necessità. Si sono accorte di aver gettato via il bimbo con l’acqua sporca, nell’ansia del nuovo a tutti i costi. Hanno capito che non sempre i desideri degli utenti coincidono con i loro comportamenti, con i bisogni più o meno confessabili. Sono dovute tornare alle basi dell’economia audiovisiva, rimangiandosi i balzi in avanti perché semplicemente non bastano. In qualche modo, negli ultimi anni – con il doping della pandemia e il successivo, necessario riequilibrio – la disruption è stata a sua volta disrupted. Si è così creata una divaricazione: da un lato, le piattaforme audiovisive digitali continuano, solo con qualche moderazione in più, una promozione fatta di novità, di hype, di distanza dal vecchio mondo televisivo e mediale; al tempo stesso, però, sotto il travestimento rivoluzionario, sono tornate ai vecchi meccanismi. L’on demand è così impegnato in una brillante reinvenzione della ruota, in una riscoperta dei fondamentali che mette in luce una verità profonda: il pubblico, il mercato, l’immaginario di reti e piattaforme è soltanto uno, quello televisivo.
Ritorna la pubblicità
Per quanto questo cambio di passo sia stato tenuto il più possibile sottotraccia, non è certo sfuggito né agli utenti né ai concorrenti. Nell’autunno 2022, un grande cartellone pubblicitario esposto a Madrid, e commissionato da Atresmedia, uno dei due grandi gruppi della tv commerciale spagnola, ha preso in giro in modo efficace le grandi piattaforme globali, servendosi della loro stessa comunicazione: usando le riconoscibili grafiche e colori di Netflix, di Amazon Prime Video, di Hbo Max, di Disney+, la prima parte della frase recita “a tutti quelli che garantivano che non avrebbero mai trasmesso pubblicità”, per poi concludere con un sarcastico “benvenuti in televisione!”. Era un passaggio a lungo smentito, ma inevitabile: una dopo l’altra, le piattaforme globali ibridano il modello subscriptional con la pubblicità e creano piani di abbonamento più economici compensati dagli spot, così da avere ulteriori fonti di ricavo capaci di fare fronte alle ampie spese, da allargare il bacino di utenti al di fuori dei (tanti, ma non abbastanza) spettatori disposti a pagare un abbonamento per i contenuti televisivi, da sfruttare fino in fondo il valore dei tanti dati a loro disposizione.
L’on demand è impegnato in una brillante reinvenzione della ruota, in una riscoperta dei fondamentali che mette in luce una verità profonda: il pubblico, il mercato, l’immaginario di reti e piattaforme è soltanto uno, quello televisivo.
A pensarci bene, è lo stesso processo che, qualche decennio prima, è stato affrontato dalle reti premium, dalla pay tv: prima una promessa di televisione libera dagli spot, poi l’aggiunta lenta di break, infine un carico di pause sempre maggiore, compensato da qualche accorgimento (come il conto alla rovescia per la ripresa del programma). Le piattaforme sembrano ora impegnate nello stesso graduale, e abbastanza veloce, cambio di paradigma: prima aggiungendo opzioni apposite, poi riducendo il numero di piani più economici per aumentare gli utenti abbonati con spot e con tutta probabilità a tendere facendo diventare la prima scelta quella dei programmi interrotti dalle inserzioni.
Ritornano le household
Una seconda modifica profonda è quella che riguarda il pubblico a cui le piattaforme on demand si sono rivolte prima, e quello a cui si rivolgono ora. Tra le tante libertà promesse dal nuovo corso digitale, c’era anche quella di non essere vincolati a spazi e dispositivi precisi, di poter disporre del proprio abbonamento non solo anytime, liberi da costrizioni temporali, ma anche anywhere, in ogni luogo. Corollario: la subscription si può, anzi si deve condividere, passare ad altri familiari, amici e conoscenti, ognuno con il proprio profilo, ognuno portatore di preziosi dati ed entusiasta evangelista della bontà e generosità delle piattaforme. Momento clou di questa fase è stato il famigerato tweet del profilo ufficiale in lingua inglese di Netflix, nel marzo 2017, con la frase “Love is sharing a password”: la condivisione di una password è il vero simbolo dell’amore. Un messaggio sepolto nel flusso continuo dei messaggi in un’era di content overload, ma riemerso, e ampiamente ricondiviso con parecchio sarcasmo e un filo di rabbia, appena la stessa piattaforma ha deciso la stretta su queste pratiche di condivisione, limitando al singolo nucleo familiare la possibilità di usufruire di un abbonamento e attivando controlli legati a spazi e indirizzi IP. È tornata allora, presentata come se fosse un’invenzione nuova ma proveniente da una lunghissima tradizione dell’industria televisiva, quella parola, household, che tiene assieme genitori e figli, mogli e mariti, coinquilini, e chiunque condivida alcune stanze nella vita quotidiana. Quell’unità base al centro delle analisi della visione televisiva, a livello industriale (le “famiglie Auditel”, da noi) così come in chiave accademica (con gli audience studies, solidi fin dagli anni Novanta).
Ritorna la selezione
Se l’innesto della pubblicità dentro a film e serie tv precedentemente liberi, o le restrizioni all’accesso da parte degli abbonati sono state necessariamente oggetto di opportuna comunicazione, anche se timida e avvertita, un terzo ripensamento del modello originario è stato invece in larga misura nascosto sotto ai lanci scintillanti di titoli sempre nuovi e di recuperi d’archivio. Un’avvisaglia però c’era già: nella scrolling fatigue, nella complicata ricerca di qualcosa che valga la pena vedere in un catalogo in teoria infinito ma in realtà ben più frustrante del previsto. Una delle scene più discusse di Strappare lungo i bordi, la prima serie animata di Zerocalcare per Netflix, è proprio quella che vede il protagonista passare ore tra i tanti riquadri, blocchi, immagini in evidenza della piattaforma per poi rinunciare a vedere alcunché; l’attesa di qualcosa da guardare finisce per assorbire tutto il tempo dedicato alla visione, nonostante gli algoritmi e le campagne di marketing, le classifiche dei più visti e le novità in tutt’evidenza. Così l’abbondanza iniziale si riduce a una ben più fattibile disponibilità e l’eccesso di zelo si trasforma in una selezione più accorta di progetti e contenuti.
C’è un ulteriore modo, più subdolo, con cui le piattaforme stanno ricalcando, passo dopo passo, le tradizioni della vecchia televisione. Ed è nella ricostruzione dell’esperienza di un flusso continuo, inarrestabile di contenuti, che tutti ci travolge e ci trattiene.
Da un lato, questo si esplicita in un minor numero di progetti originali, e in generale in una contrazione dei budget, al di là dei titoli flagship che soli possono davvero portare nuovi abbonati; questi progetti, inoltre, devono poter interessare al pubblico, e non solo a una nicchia ma a quello più ampio, di massa o quasi – ancora una volta, una versione appena rinfrescata della cara vecchia audience generalista, della programmazione trasversale ai generi, alle fasce d’età e alle classi socio-economiche, e persino del least objectionable programming. Anche così si spiegano le cancellazioni dei progetti troppo targettizzati, incapaci di trovare una loro audience. Dall’altro, questo agire trova rispondenza anche nell’uscita fuori dai cataloghi dei titoli della coda più lunga, per cui anche i costi bassissimi non sono giustificati dalle pratiche, monitorate, degli spettatori sulla piattaforma – e stupisce l’ampio stupore che ha circondato le “epurazioni” dalle library degli streamer americani. Da un altro lato ancora, infine, si inserisce in tale quadro il graduale ritorno a forme di distribuzione dei titoli più avvertite rispetto alla release immediata e simultanea di tutti gli episodi di una stagione, che troppo spesso rischia di sprecare in poco più di un weekend l’attenzione e le visioni per prodotti su cui si è lavorato a lungo, investendo energie e denari. Ecco allora la suddivisione delle stagioni in blocchi più piccoli, o il passaggio (o, meglio, il ritorno) alla scansione settimanale degli episodi, meglio capace di tenere acceso l’hype, scatenare ipotesi, creare affetto, e in generale creare valore. Addirittura, viene il sospetto malizioso che le piattaforme ora centellinino il materiale più interessante e si “liberino” in un solo binge solo di ciò di cui non sono particolarmente convinte. Ma anche se così non fosse, è il palinsesto televisivo, la scansione rituale, la visione sincronizzata e condivisa, che rientra in scena.
Ritorna il flusso
Infine, c’è un ulteriore modo, più subdolo, con cui le piattaforme stanno ricalcando, passo dopo passo, le tradizioni della vecchia televisione. Ed è nella ricostruzione dell’esperienza di un flusso continuo, inarrestabile di contenuti, che tutti ci travolge e ci trattiene. Questa era l’essenza della tv commerciale, notata già a metà anni Settanta da Raymond Williams nei suoi viaggi americani: una giustapposizione di programmi, promo e pubblicità; un fluire senza posa di materiali da guardare; uno spettatore che ne ritaglia una parte accendendo e spegnendo l’apparecchio, cambiando canale, andando avanti e indietro all’interno dell’offerta lineare. Anche in questo caso, la prima fase dell’on demand è stata caratterizzata dall’esigenza opposta: non l’accozzaglia ma il singolo testo, il contenuto pregiato, il film o la serie e lo spettacolo o la partita di valore, a cui è giusto dedicare tempo e denaro. Ma non tutto può essere figura, quando c’è pure un sacco di sfondo: la televisione è quello che vogliamo guardare davvero, ma anche tutto ciò in cui ci imbattiamo per caso, quello che ci fa compagnia, quello che scorre – appunto – mentre siamo concentrati altrove, quello che riempie il nostro tempo vuoto senza troppe pretese. Ed ecco allora la reinvenzione del flusso: l’episodio che subentra a quello appena finito tranciandone di netto la sigla di coda (esattamente come ha sempre fatto, tra mille proteste, la tv commerciale); la scelta limitata tra due o tre alternative una volta finita tutta la serie, per vedere subito qualcos’altro; i trailer e promo (e ora gli spot) che si affastellano; il tasto che sceglie qualcosa di casuale, versione futuribile di uno zapping sfrontato; e poi i canali lineari, monotematici o più articolati, che sempre più spesso arricchiscono l’offerta, disponendo in un’interfaccia comoda e facilmente riconoscibile la ricchezza di un database che nessuno ha tempo e voglia di esplorare fino in fondo. Il principale rivale di Netflix è il sonno, come nella famosa frase di Reed Hastings, ma la concorrenza per il nostro tempo e la nostra attenzione è parecchio affollata, e comprende ogni forma culturale e mediale, comprese le altre piattaforme, comprese le classiche reti tv. Anche l’on demand si pone allora il problema di far compagnia, di occupare il tempo, di sorprenderci e rassicurarci. Di farci restare il più a lungo possibile non solo per guardare qualcosa, ma per guardare qualsiasi cosa. La necessità dei servizi audiovisivi on demand, oggi e nel prossimo futuro, è insomma ben riassunta dalla frase dei conduttori tv prima di una pausa pubblicitaria o per invitarci a tornare il giorno dopo: “restate con noi”.
Luca Barra
Coordinatore editoriale di Link. Idee per la televisione. È professore ordinario presso l’Università di Bologna, dove insegna televisione e media. Ha scritto i libri Risate in scatola (2012), Palinsesto (2015), La sitcom (2020) e La programmazione televisiva (2022), oltre a numerosi saggi in volumi e riviste.
Vedi tutti gli articoli di Luca BarraLeggi anche
Mediaset e il cinema italiano
Ficarra e Picone. Come Franco e Ciccio, oltre Franco e Ciccio

Serial Writers
Intervista a Craig Thomas

