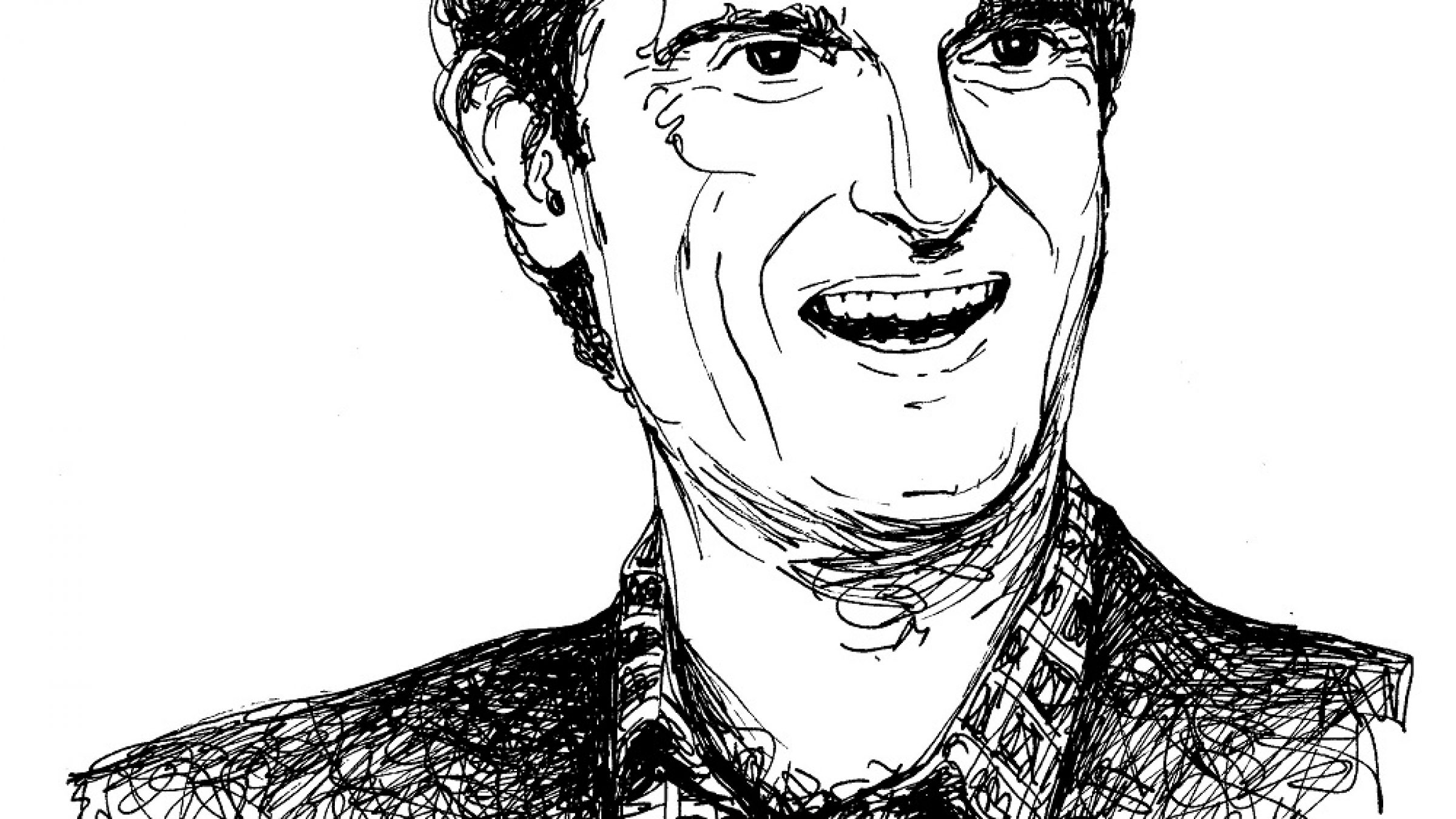
Anche la sitcom ha sfide di scrittura non indifferenti. Far ridere, sì, ma non soltanto. Ne parliamo con il co-creatore di How I Met Your Mother.
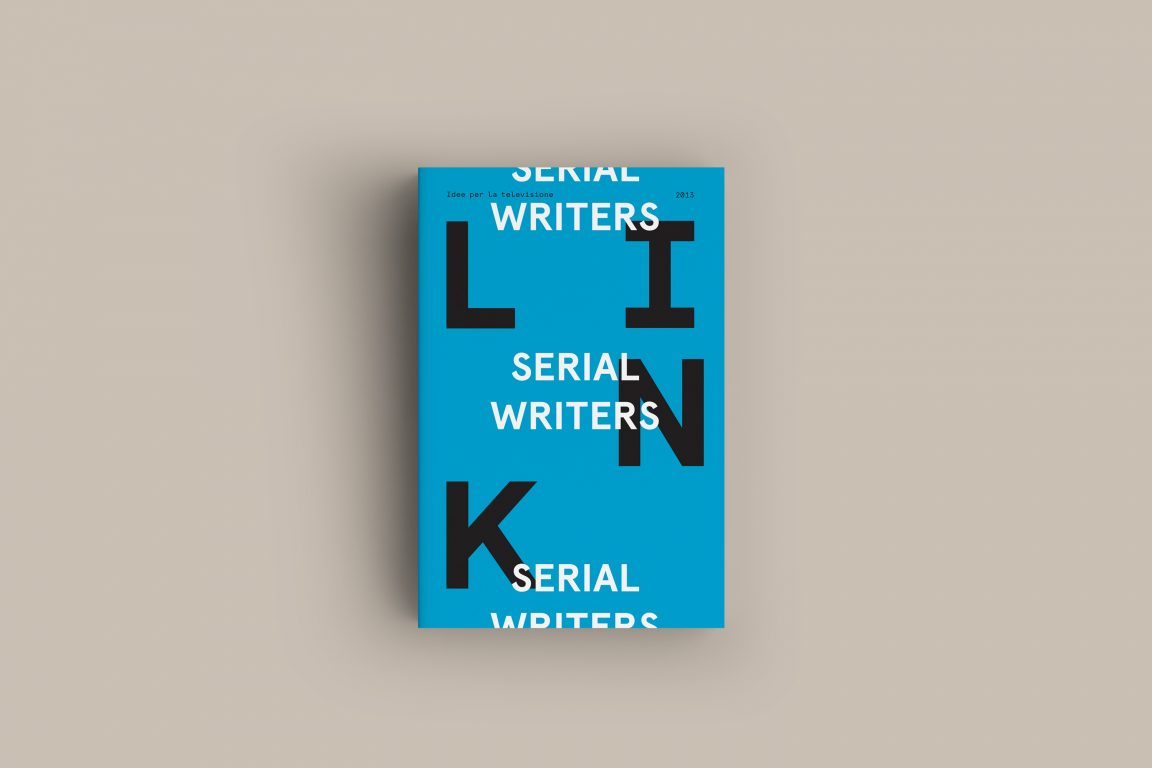
Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 15 - Serial writers del 01 ottobre 2013
Si fa presto a dire sitcom. Nel confronto con le storyline intricate e i dialoghi pensosi delle serie drama, la situation comedy – che pure tiene davanti agli schermi televisivi, ogni settimana, decine di milioni di spettatori – finisce per sembrare facile, formulaica, persino banale. Eppure non è così facile far ridere, per davvero, nonostante l’aiuto dato dalla laugh track registrata. Nella storia della tv statunitense molti dei grandi autori, sceneggiatori e produttori comici si sono fatti le ossa (e a volte i soldi) proprio con le sitcom degli esecrati network. A volte, poi, la sitcom riesce a diventare qualcosa di più: un linguaggio condiviso e generazionale, un insieme di personaggi che diventano di famiglia, una storia che non si esaurisce nella commedia, ma lascia spazio anche a toni diversi, e persino a momenti drammatici. È il caso di How I Met Your Mother, sitcom partita nel 2005 su CBS e ormai giunta alla nona, e ultima, stagione (in Italia è andata in onda su Italia 1, Italia 2, Joi, Cielo, Fox). Sulla carta, è la classica storia di un gruppo di amici ventenni (e mano a mano adulti) a New York: Ted, Marshall, Lily, Barney e Robin. Ma, fin dall’inizio, c’è una differenza importante: la storia è narrata da un Ted ormai adulto, che vuole spiegare ai suoi figli adolescenti in che modo ha conosciuto, si è innamorato e ha sposato la loro madre. Uno sfasamento che si riverbera nella scrittura, che scompagina le linee narrative, e che ci mette nelle mani di un narratore che, a volte, può persino prendersi gioco di noi. Ne parliamo con Craig Thomas, che in coppia con Carter Bays è il creatore della serie. Formatosi alla scuola del David Letterman Show, dove ha lavorato dal 1997 al 2002, prima di realizzare la sua sitcom ha scritto sceneggiature per l’Ali G Show di Sasha Baron Cohen e per American Dad di Seth McFarlane. Sempre in coppia con Carter Bays, e con l’aggiunta di Chris Harris, nel 2013 ha creato per Fox la sfortunata The Goodwin Games. È How I Met Your Mother, però, non solo il suo progetto più importante, ma anche la palestra di scrittura seriale in cui mettere alla prova meccanismi e strategie narrative.
Com’è nata l’idea di How I Met Your Mother? Come siete riusciti a sviluppare personaggi così a tutto tondo, partendo dall’esperienze personali?
Mentre stavamo scrivendo il pilota di How I Met Your Mother, ci siamo attenuti alla saggezza senza tempo delle regole della scrittura: scrivi-di-ciò-che-conosci. Almeno in un primo momento, così, abbiamo basato i personaggi su noi stessi e sulle nostre vite. Quando avevamo vent’anni, il mio collega sceneggiatore Carter [Bays, ndr], proprio come Ted, era single e aspettava di incontrare la persona giusta. Io invece stavo con mia moglie fin dal primo anno di università, proprio come Marshall e Lily. Barney, dal canto suo, è partito come uno strano mix di alcuni amici assurdi che conoscevamo a New York. Solo dopo abbiamo preso queste fondamenta relativamente reali dei personaggi e vi abbiamo costruito sopra: li abbiamo abbelliti, abbiamo creato tratti, fissazioni e back-story che hanno reso i protagonisti finalmente loro stessi, persone del tutto uniche e speciali. Alcuni fan dicono: “Mi piace How I Met Your Mother, perché mi ricorda quando io e i miei amici usciamo insieme”; ecco, questo è probabilmente il complimento che apprezziamo di più.
Mi pare poi che la sitcom segua la tradizione della buddy comedy newyorkese, da Seinfeld in avanti… È così? In che modo invece se ne distanzia?
Sia io sia Carter siamo grandi fan di Seinfeld e di Friends, le sitcom newyorkesi più importanti per la nostra generazione. Per cui sì, questi titoli ci hanno influenzato parecchio. Detto questo, però, non abbiamo mai voluto copiarle in alcun modo: anzi, abbiamo talmente paura di ricalcarle che ogni volta in cui ci siamo accorti che un’idea era troppo vicina a un episodio di questi programmi, l’abbiamo immediatamente abbandonata. D’altra parte, il nostro produttore Suzy Greenberg ha prodotto Seinfeld a lungo, mentre Greg Malins, che ha scritto per noi per molti anni, è stato showrunner di Friends: insomma, abbiamo avuto buoni maestri che ci hanno aiutato a rimanere onesti!
A proposito di Seinfeld, quanto siete stati influenzati dagli episodi della serie che non hanno una struttura narrativa canonica – penso a quello interamente ambientato nell’atrio di un ristorante cinese, o quello in cui la storia è presentata al contrario dalla fine all’inizio… – nello sviluppare l’idea alla base di How I Met Your Mother?
Carter e io adoriamo giocare con la struttura narrativa e sfidare la tradizionale forma di storytelling della sitcom. Quando eravamo teenager, vedere Seinfeld alle prese con queste operazioni è stato per noi di grande ispirazione, ma non tutte le nostre idee e i nostri modi di divertirci con la narrazione arrivano necessariamente dalla televisione. Per esempio, siamo anche grandi fan di Quentin Tarantino, e del modo in cui trova sempre modi inventivi per raccontare una storia. Aggiungo una divertente nota a margine: abbiamo saputo di recente che proprio Tarantino è un fan del nostro lavoro. Per noi è semplicemente sconvolgente!
Quali sono le sfide principali da affrontare nella scrittura di una sitcom per un network?
La sfida principale per ogni sitcom è quella di fare in modo che agli spettatori importi dei personaggi. Né io né Carter abbiamo mai avuto l’obiettivo di rendere How I Met Your Mother soltanto una joke machine, una macchina che produce continuamente scherzi: altri sceneggiatori potevano farlo, probabilmente meglio di noi! Invece, noi volevamo che la sitcom funzionasse (almeno in alcuni momenti) più come un romanzo, come uno spettacolo teatrale o come un film. Insomma, che fosse un mondo in cui puoi portare i personaggi in un viaggio emozionale, facendoli arrivare persino in alcuni angoli bui, ma che alla fine, lungo la strada, trovasse il modo di essere divertente. Un’altra sfida, poi, è il bilanciamento tra gli episodi stand-alone e gli archi narrativi più lunghi, che continuano per più episodi. Da una parte, vogliamo che il programma sia accessibile agli spettatori settimana dopo settimana, ma al tempo stesso amiamo scrivere storyline più lunghe, complesse e intricate. Il problema è trovare il giusto punto di equilibrio, dove riusciamo a non far sentire lasciato indietro lo spettatore casuale e, allo stesso tempo, diamo un premio al pubblico più fedele, quello che non si perde un episodio. Dal momento che ormai sempre più americani consumano grandi quantità di puntate in un solo colpo (con il dvr, con Netflix eccetera), gli archi narrativi diventano più gratificanti e più accessibili.
Escludendo indizi e false piste, per otto stagioni non abbiamo avuto idea su chi fosse la madre dei figli di Ted. Quali sono i limiti, e quali invece le soddisfazioni, nello sviluppare una storia che ha previsto la soluzione del “mistero” finale così tanto avanti nel tempo?
How I Met Your Mother è in realtà molto di più che la semplice risposta alla domanda “Chi è la madre?”. È un padre che racconta ai suoi figli che tipo di persona fosse prima di avere dei bambini. Allo stesso tempo, però, ci piaceva avere un grande mistero che si costruiva man mano durante la serie. L’intero show ne risulta pieno di suspense. Così, come conseguenza, molti nostri episodi e archi narrativi individuali contengono qualche tipo di elemento misterioso minore nella narrazione, come a rappresentare un microcosmo dell’intera serie. Il mistero, insomma, è inscritto nel Dna del programma.
Come riuscite a trovare un equilibrio tra le storyline verticali degli episodi e le trame e sottotrame orizzontali principali, a volte piuttosto articolate?
Ancora una volta, è questione di giusto bilanciamento. Direi che soprattutto nelle ultime stagioni abbiamo esplorato archi narrativi più lunghi e intricati. Giunti così avanti nella serie, pensiamo che i fan di How I Met Your Mother possano accettare con facilità la continuity e i cliffhanger. Mentre molti nuovi spettatori divorano l’intera serie nell’arco di poche settimane, grazie a Netflix, ai dvd, all’online o alle reti in syndication. Questo ci dà la sicurezza di poter raccontare storie sempre più lunghe e serializzate.
"La sfida principale per ogni sitcom è fare in modo che agli spettatori importi dei personaggi. Volevamo che fosse un mondo in cui puoi portare i personaggi in un viaggio emozionale, facendoli arrivare persino in alcuni angoli bui, ma che alla fine trovasse il modo di essere divertente".
Veniamo ad alcuni caratteri della scrittura seriale. Fino a che punto potete spingervi nell’usare battute ricorrenti e catchphrase, come quelle di Barney?
Siamo piuttosto sfrontati nell’uso di catchphrase nella serie. Il nostro scopo però è sempre quello di farle sembrare simili, più che agli slogan industriali tipici di altre sitcom, a quegli inside joke che sono presenti in tutti i gruppi di amici. Non abbiamo forse tutti battute che capiamo solo noi e stupidi riferimenti condivisi che ripetiamo continuamente con i nostri amici? Sono sicuro che è così! Un’altra cosa che cerchiamo di fare è di inserire quanti più colpi di scena riusciamo a trovare per ciascun inside joke e ciascuna catchphrase. Per fare un solo esempio, abbiamo persino chiuso la seconda stagione con Barney che dice “Legen – wait for it –” e poi siamo andati in nero, così gli spettatori hanno dovuto aspettare tutta l’estate per sentire il “dary!” [l’adattamento italiano ha tradotto con “Leggen – Non ti muovere –” e “dario!”, ndr]. Più questi modi sono pazzi ed elaborati, meglio è!
Nella serie, fate un continuo uso di flashback e flashforward. Come possono interagire con la storia senza frammentarla troppo?
Speriamo che tutti i flashback e i flashforward (e più in generale la continua giocosità a livello di struttura narrativa) aiutino a impedire che le scene sembrino troppo lunghe o troppo statiche; e siamo convinti che questi strumenti siano diventati parte importante del linguaggio narrativo della nostra serie, più che farla sembrare incostante o frammentata. Nel bene e nel male, è il modo in cui ci piace raccontare storie. Se giriamo un episodio e ci sembra troppo lento o lineare, cerchiamo di trovare un espediente per spezzettarlo in sala di montaggio: incrociamo scene diverse, creiamo flashback con il narratore. How I Met Your Mother è al suo meglio quando ha lo slancio di un treno fuori controllo.
Una delle caratteristiche principali di How I Met Your Mother, poi, è la sua abilità nel “dare un nome” agli aspetti comuni che popolano la nostra vita quotidiana, raccontando fenomeni e teorie emozionali che sono, non viste, sotto gli occhi di tutti. Come ci riuscite?
Come con le catchphrase, cerchiamo davvero soltanto di far parlare i nostri personaggi così come faremmo noi o i nostri amici. Tutti noi abbiamo teorie e regole sulla vita, tutti noi ci inventiamo dei nomi per quegli strani fenomeni di cui ci accorgiamo nel fidanzamento, nelle amicizie, nel mondo in generale. Quindi cerchiamo soltanto di catturare il modo in cui le persone reali parlano e interagiscono tra loro: se qualcosa ci sembra 1) divertente e 2) vero, lo mettiamo subito nella sceneggiatura!
Nelle ultime stagioni, How I Met Your Mother ha ampliato i suoi toni, aggiungendo alla commedia un sapore più drammatico – penso, per esempio, all’episodio in cui viene a mancare il padre di Marshall. In che modo questa ampiezza di emozioni incide sulla vostra scrittura comica? Con quali risultati?
Forse il più grande vantaggio di fare una sitcom per otto anni (e ora ancora per un’ultima, nona, stagione!) è che ti conquisti la possibilità di approfondire i personaggi. Nel corso del tempo, ci siamo accorti di come gli attori siano bravi e versatili, non solo nella commedia: non c’è un solo membro del cast di How I Met Your Mother la cui performance non sia riuscita a farmi piangere, e spesso più di una volta. Tutto questo è dovuto al numero di stagioni che siamo riusciti a fare. Non avremmo mai scritto una linea narrativa sulla perdita del papà di Marshall nella seconda stagione, ma nella sesta ormai ce l’eravamo guadagnata. Come sceneggiatori, il fatto di poter scrivere scene dove questi personaggi a cui tieni così tanto passano attraverso esperienze di vita reale – e non soltanto attraverso classiche storyline da sitcom – è una di quelle cose che Carter e io in assoluto preferiamo fare. E speriamo che questo sia qualcosa che ci contraddistingue da un mucchio di altre sitcom…
Luca Barra
Coordinatore editoriale di Link. Idee per la televisione. È professore ordinario presso l’Università di Bologna, dove insegna televisione e media. Ha scritto i libri Risate in scatola (2012), Palinsesto (2015), La sitcom (2020) e La programmazione televisiva (2022), oltre a numerosi saggi in volumi e riviste.
Vedi tutti gli articoli di Luca BarraLeggi anche

Podcast nazionali
Veleno: intervista a Pablo Trincia


