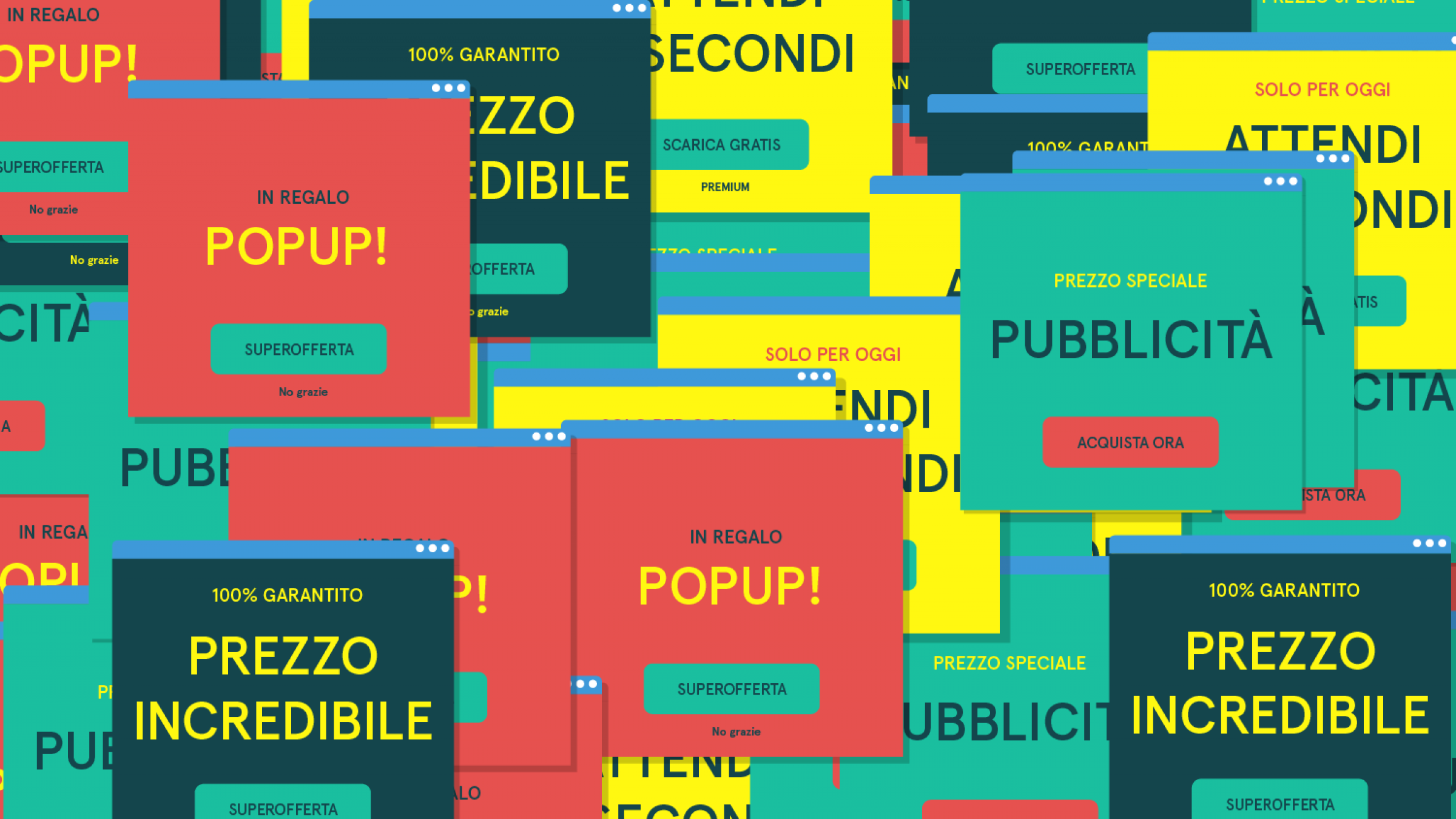
Gli investimenti pubblicitari digitali stanno per superare, secondo le previsioni, quelli televisivi. Ma davvero è tutto oro quello che luccica?
“Il sorpasso, il sorpasso. Nel 2017 avverrà il sorpasso”. È da oltre un anno che si leggono studi e articoli di settore con questa frase scritta in toni concitati e pregni di futuro: e il sorpasso in questione riguarda gli investimenti pubblicitari digitali (web, digital e social) rispetto a quelli sulla televisione.
Secondo l’ultimo Advertising Expenditure Forecasts pubblicato dal centro media Zenith, nel 2017 la pubblicità su internet crescerà del 13 per cento, per arrivare a un valore di 192,3 miliardi di euro a livello globale, superando quella televisiva che si assesterà a 180 miliardi. In Italia, invece, la tv rimane ancora, seppur con una crescita moderata, il medium dominante nelle pianificazioni: secondo l’ultima rivelazione dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, l’internet advertising tocca i 2,4 miliardi di € (+9%) e vale il 30% del mercato pubblicitario, alle spalle della tv che raccoglie il 50% degli investimenti. Sempre secondo le previsioni di Zenith Media, nel 2019 gli investimenti sui social supereranno a livello globale quelli sulla stampa – c’è solo da capire se il concetto di social media tra due anni sarà lo stesso che intendiamo ora, o se nel frattempo si saranno imposte nuove piattaforme che di fatto si sostituiranno al web. Ma le ricerche predittive, come è noto, non sempre tengono conto degli eventuali incidenti di percorso.
Molti grandi inserzionisti si sono accorti che le pubblicità dei loro marchi erano associate a messaggi (video o testi) di incitazione all’odio razziale, religioso, politico e sociale, a volte direttamente legati ad associazioni criminali internazionali. Un contesto inquinato.
Comunicazione e controllo
All’inizio di questo 2017 è infatti accaduto qualcosa di destabilizzante per chi lavora nel mondo della comunicazione di marca. Molti grandi inserzionisti si sono accorti che le pubblicità dei loro marchi erano associate a messaggi (video o testi) di incitazione all’odio razziale, religioso, politico e sociale, a volte direttamente legati ad associazioni criminali internazionali. Un contesto inquinato, dal quale i grandi marchi chiaramente intendono tenersi fuori. Così il tema del cosiddetto brand safety, che il web e le grandi corporation che in gran parte lo gestiscono non sono capaci di garantire, torna prepotente alla ribalta sulla scenario mediale. Siamo arrivati al punto in cui molti inserzionisti multinazionali e i loro centri media, per protesta, hanno cancellato gli investimenti su YouTube e su Google Display Networks (GDN) per un totale di oltre 750 milioni, fino a quando Google, proprietaria della piattaforma di video sharing, non troverà opportuni rimedi a questo fenomeno.
La società di Mountain View non ha eliminato i siti in cui sono stati trovati i messaggi razzisti, per riaffermare il concetto di non essere responsabile dei contenuti che circolano lì sopra (altrimenti il suo valore si sbriciolerebbe), ma ha migliorato gli algoritmi di machine learning per affinare la targetizzazione dei video, impegnandosi a rimuoverli entro due ore dal reporting nel caso vengano associati a contenuti inappropriati. Tutto questo però non è ancora sufficiente, visto che il disinvestimento da parte di molti big spender è tuttora attivo. C’è inoltre chi, come il centro media del gruppo pubblicitario Publicis, in accordo con alcune piattaforme tecnologiche, ha implementato su tutte le campagne da loro gestite un servizio di controllo semantico e “keyword sensitive”, con aggiornamento quotidiano su una serie di argomenti ritenuti poco sicuri, al fine di combattere i casi di ad fraud.
Ma c’è di più. Questo incidente ha infatti fatto scoprire una serie di vasi di pandora: la protesta contro Google ha spinto molte aziende a rivedere la pianificazione servita attraverso il sistema di programmatic advertising, che smista l’annuncio pubblicitario su oltre due milioni di siti per “raggiungere” indiscriminatamente l’audience più grande possibile. Operando in tal modo, molte aziende – tra cui leader nel mondo della finanza come JPMorgan Chase – hanno scoperto che, pur eliminando circa 400 mila siti tra le testate online in cui girava la loro pubblicità (tra cui siti neo-nazisti che inneggiavano all’odio razziale), non è stato minimamente danneggiato nessuno dei parametri di visibilità e notorietà monitorati quotidianamente: questo significa che la miriade di siti e micro-siti su cui Google faceva girare l’annuncio non erano visti praticamente da nessuno.
In fondo, la promessa di una pubblicità basata sulla profilazione personale, con il “taglio sartoriale” del messaggio indirizzato alla persona giusta, nel momento e nel contesto giusto, oggi non funziona alla perfezione, nella qualità e soprattutto nella quantità. Forse sarebbe il caso di pensare a un limite sull’affollamento pubblicitario.
Ritorno all’ordine?
Insomma, molti investitori si stanno rendendo conto che la valanga di pubblicità su internet – senza alcun rispetto dei limiti di affollamento, anche quelli di buon senso – non serve poi a molto. La coda lunga applicata al web advertising non funziona: oggi JPMorgan Chase è passata a programmare le proprie pubblicità solo su 5mila home page, minimizzando il rischio di rovinare l’immagine del loro brand ed evitando che una parte di ricavi, grazie al sistema di revenue sharing, finisse per alimentare siti di fake news o associazioni estremiste. Altri brand hanno modificato in corsa le loro pianificazioni, tornando su alcuni brand media garantiti (televisioni e giornali in primis).
Ma c’è di più: oggi i brand non sono neppure tanto convinti dell’effettiva visibilità degli annunci sul web. Il Media Rating Council, l’organismo internazionale che stabilisce le metriche per i mezzi di comunicazione, pone due condizioni per considerare un annuncio visibile sul mobile: il numero di pixel (almeno il 50% dev’essere in chiaro) e il tempo (un secondo per un’immagine, due secondi per un video). Tempi davvero molto ristretti per ipotizzare che un messaggio sia davvero “passato”.
Recentemente anche un grosso gruppo come WPP, attraverso il CEO Sir Martin Sorrell, in occasione di un intervento all’IPA Festival of Brtish Advertising a Londra, ha puntato il dito contro Google e Facebook (che insieme attraggono il 60% della pubblicità online), rei di non assumersi responsabilità sui contenuti postati sulle loro property – e in questo il tema delle fake news ingigantisce ancora di più la questione.
Tutto questo riguarda il lato dell’offerta, ma anche dal punto di vista degli utenti, letteralmente inseguiti da annunci di sneaker, cuffie ed elettrodomestici che magari abbiamo già acquistato, le cose non vanno molto meglio. In fondo, la promessa di una pubblicità basata sulla profilazione personale, con il “taglio sartoriale” del messaggio indirizzato alla persona giusta, nel momento e nel contesto giusto, oggi non funziona alla perfezione, nella qualità e soprattutto nella quantità. Forse sarebbe il caso di pensare – per il bene di tutti, investitori e utenti – a un limite sull’affollamento pubblicitario, da applicare nella libera frontiera del web, come avviene in tv. Chissà se a fine del 2017 questo sorpasso ci sarà davvero, o se forse invece sarà rinviato al prossimo anno, quando queste acque si saranno calmate o regolate.
Michele Boroni
Scrive per Il Foglio, Wired, Il Messaggero, Rockol e Studio. Si occupa di contenuti e comunicazione per brand. Un tempo aveva un blog, ma gli è rimasto solo il nome – EmmeBi – con cui firma i suoi tweet. È stato autore tv e radio (tra gli altri Ghiaccio Bollente su Rai5 e Ogni Maledetta Domenica su Radio2) e ha scritto alcuni saggi sul marketing, ma sono tutti fuori catalogo.
Vedi tutti gli articoli di Michele BoroniLeggi anche

Piattaforme social
Il lato commerciale dell’algoritmo di Facebook


