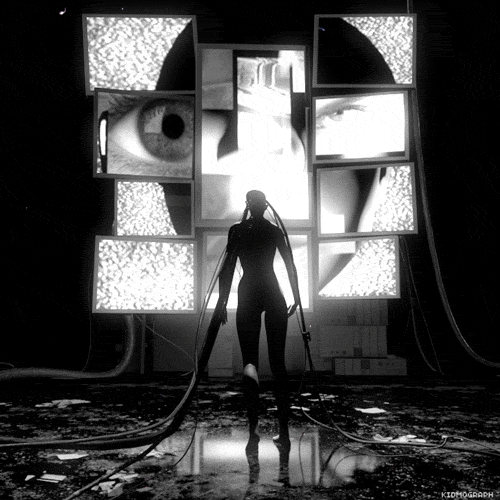
Riempire la timeline di contenuti rilevanti per utenti e investitori pubblicitari è da anni la missione di Facebook. In un difficile equilibrio, con aggiustamenti continui.
Vi ricordate quel tempo in cui i valori legati alla rete erano la democrazia, l’assenza di barriere, la libera circolazione delle idee e le pari opportunità? Sembra passato un secolo, e invece fino a quindici anni fa erano questi gli argomenti sulla bocca di tutti, non solo degli entusiasti dell’internet. Oggi invece i social e il web sono spesso associati a temi come la sicurezza, il controllo dei contenuti, le fake news, il cyber-bullismo, l’hate speech, il revenge porn, e così via. In particolare, quando in questi ultimi mesi si parla di Facebook si fa spesso riferimento alle interferenze della Russia, alla capacità di avvantaggiare i messaggi negativi, alle frenetiche modifiche dell’algoritmo, alla trovata di demandare alla community l’affidabilità delle fonti o all’alto tasso di abbandono da parte dei millennial e della nuova generazione Z, che preferiscono piattaforme sempre più targettizzate sulla base di interesse specifici come la fotografia e il video (Instagram, Snapchat), la musica (Musical.ly, Spotify) o più semplicemente i gruppi chiusi di WhatsApp (peraltro, sia quest’ultima sia Instagram, sono proprietà di Mark Zuckerberg).
Qui però vogliamo concentrarci su quel lato di cui si parla meno, ma che oggi è decisamente l’aspetto più rilevante, quantomeno dal punto di vista economico: Facebook come medium pubblicitario. E vogliamo provare ad analizzare l’algoritmo che lo guida, in continua mutazione.
Se un tempo Facebook basava tutto sulla mission di alto profilo – “dare vita a un mondo migliore, più aperto e connesso, che porti a un’economia più forte con più opportunità e a una società che rifletta i valori di tutti” –, oggi il gioco è molto più smaccato. Sono gli stessi manager della società a presentare la piattaforma come la migliore su cui investire il proprio budget di comunicazione, prima che come social network. Per farla breve, sono gli inserzionisti a essere i veri clienti, mentre gli utenti sono il prodotto.
“Per un brand non è più sufficiente produrre contenuti interessanti, è necessario che investa in pubblicità, perché l’algoritmo di Facebook ora premia le aziende che mettono più soldi sulla piattaforma”. La forbice tra il cosiddetto traffico organico e quello a pagamento si sta facendo negli anni sempre più ampia.
La comunicazione commerciale
Proviamo per un attimo a mettere da parte i temi della privacy e delle fake news, in modo da concentrarci più su Facebook come un ecosistema per la comunicazione commerciale. Diamo però prima alcune cifre per avere la misura del fenomeno. Nel mondo, gli utenti mensili di Facebook sono 2 miliardi. In Italia sono 30 milioni (circa l’80% di coloro che usano internet), e 25 milioni lo usano ogni giorno (di questi, 24 lo fanno da mobile). Questo è il prodotto che Facebook vende a una potenziale clientela di circa 70 milioni di aziende con una pagina sulla piattaforma, di cui 5 milioni già investono in pubblicità attraverso spot sponsorizzati e altri strumenti proposti dal gruppo che fa capo a Zuckerberg.
A guidare tutto questo c’è un algoritmo che, sulla base dei dati di ciascun utente, permette a questi di vedere sulla propria timeline contenuti ritenuti interessanti, secondo quelli gli interessi e le passioni dichiarate o quelli rivelati mediante la navigazione. Gli algoritmi non sono neutrali, anche se appaiono come tali: sono progettati in realtà con un valore specifico in mente, quello di massimizzare la quota di attenzione al fine di ottimizzare i profitti.
Ma tutto questo è efficace per un’azienda che vuole comunicare in rete ottimizzando il suo budget? Lo abbiamo chiesto a chi lavora quotidianamente con aziende e social network per capire da dentro come è vissuta questa funzione. “Facebook e Google hanno di fatto un monopolio sulla pubblicità in rete, e per un brand quindi è in qualche modo obbligatorio investirci”, racconta Elena Merazzi, social media specialist di The Big Now, agenzia pubblicitaria italiana (ma con sede anche ad Accra, in Ghana) dalla forte specializzazione sul digital. “Innanzitutto Facebook ha il potere del dato socio-demografico, geografico e degli interessi dimostrati dall’utente, che affascina e attira le aziende: se un tempo si misurava tutto senza mai utilizzarlo davvero, oggi i dati sono spesso l’oggetto principale delle campagne sui social”.
Fino a pochi anni fa, con una buona strategia di contenuto, un’azienda riusciva a mantenere il contatto e la relazione con un alto numero di utenti Facebook. Ma adesso la situazione è cambiata. “Per un brand non è più sufficiente produrre contenuti interessanti, è necessario che investa in pubblicità, perché l’algoritmo ora premia le aziende che mettono più soldi sulla piattaforma”, continua Merazzi. La forbice tra il cosiddetto traffico organico e quello a pagamento si sta facendo negli anni sempre più ampia.
Questo scenario ha un effetto dirompente anche sul lavoro della filiera dietro alla comunicazione di un brand. “Il fatto di avere un buon contenuto creativo è sempre alla base di tutto, ma oggi forse non è più l’elemento principale: puoi avere un contenuto bellissimo e perfetto per il tuo target, ma se non ci investi sopra c’è il rischio che lo possa vedere solo un misero 5-10% dei fan della tua pagina. Le aziende sono quindi costrette a investire molto più sul media che sulla creatività”.
Per tutto il 2017, le nostre timeline di Facebook hanno avuto un numero di post sponsorizzati spesso pari a quelli di amici e parenti. Ed è forse anche per questo che nelle prime settimane del 2018 gli sviluppatori e i sistemisti della piattaforma hanno deciso di cambiare ancora l’algoritmo: di fatto, nelle bacheche degli utenti da adesso in avanti saranno visualizzati meno articoli provenienti da pagine pubbliche (aziende e testate in primis) che seguiamo, meno video e meno “virali”, offrendo più spazio ai contenuti personali pubblicati dai nostri amici – fotografie, consigli e opinioni con il rischio di restringere ancora di più la filter bubble di ciascuno di noi. Insomma, Facebook torna, almeno in parte, ad avere la sua storica funzione di social network.
La voce di Facebook
Tuttavia, il lato commerciale della piattaforma continua a essere quello su cui i manager puntano per far crescere fatturato e contatti. A questo punto, resta da chiedersi se, una volta fatto un piano di investimenti continuativo su Facebook, i risultati per un’azienda siano davvero soddisfacenti.
Sentiamo cosa dichiarano i diretti interessati. “La filosofia che guida la nostra attività commerciale è la creazione del valore: il contenuto della pubblicità dev’essere interessante per la persona che lo legge e deve generare un ritorno sull’investimento elevato per l’impresa, altrimenti l’equazione non funziona”, dice Marco Grossi, senior manager di Facebook, responsabile SMB (small medium business). “Invece di dare la posizione dell’annuncio a chi offre di più, come succede nelle normali aste, l’algoritmo di Facebook calcola il valore che l’annuncio genererà sia per la persona che lo vedrà – la cosiddetta rilevanza – sia per l’annunciante. La somma di questi valori è un punteggio finale che consente di apparire in timeline”.
Secondo Nielsen, il target pianificato su Facebook è preciso al 91%, mentre quello medio del web è solo del 63%. “Facebook non ci restituisce il dato preciso di chi ha visto la mia campagna, ma il riscontro empirico che facciamo internamente è sempre positivo: per esempio, se pianifichiamo su uomini italiani dai 25 ai 35 anni, la campagna non andrà su altri target”, racconta ancora Merazzi.
Dietro a tutti questi ragionamenti di buon senso c’è però poi un’applicazione forzata: ultimamente sono state create e perfezionate tecniche e modalità che spingono l’utente a consultare in continuazione il proprio smartphone, finendo per creare una vera dipendenza, con tutte le conseguenze del caso. Il libro Chaos Monkeys: Obscene Fortune and Randon Failure in Silicon Valley, scritto nel 2017 da Antonio Garcia Martinez, ex project manager di Facebook, racconta come l’azienda neghi di sfruttare lo stato emotivo dei suoi utenti per dare in pasto agli inserzionisti audience composte da persone che si sono dimostrate più suscettibili a un determinato tipo di messaggio e fa ancora oggi molto rumore. “Per due anni ho avuto l’incarico di trasformare i dati di Facebook in denaro, usando ogni strumento legale”, scrive Martinez. “Se fate ricerche su internet o comprate oggetti in un negozio e poi trovate su Facebook pubblicità legate alle vostre ricerche o ai vostri acquisti, prendetevela con me: sono io ad aver partecipato alla creazione di questa tecnologia”.
Ricordiamoci comunque che un modo per capire perché vediamo un contenuto sponsorizzato piuttosto che un altro c’è sempre: basta cliccare in alto a destra del post e, dal menù che si apre, scegliere la voce “perché vedo questo annuncio?”. Scopriremo così quali caratteristiche (età, interessi, comportamenti) interessavano agli inserzionisti e, nel caso la pubblicità fosse per noi inappropriata, offensiva o semplicemente poco interessante, è possibile nasconderla o segnalarla all’algoritmo per non vederla più. In fondo, questa resta una caratteristica di “libertà” e “democrazia” che appartiene alla vecchia idea di internet, prima che tutto fosse regolato dalle grandi multinazionali digitali.
Michele Boroni
Scrive per Il Foglio, Wired, Il Messaggero, Rockol e Studio. Si occupa di contenuti e comunicazione per brand. Un tempo aveva un blog, ma gli è rimasto solo il nome – EmmeBi – con cui firma i suoi tweet. È stato autore tv e radio (tra gli altri Ghiaccio Bollente su Rai5 e Ogni Maledetta Domenica su Radio2) e ha scritto alcuni saggi sul marketing, ma sono tutti fuori catalogo.
Vedi tutti gli articoli di Michele BoroniLeggi anche

Social tv
Gnip. Alla fonte del Big Data

Tecniche
Un sound design silente

