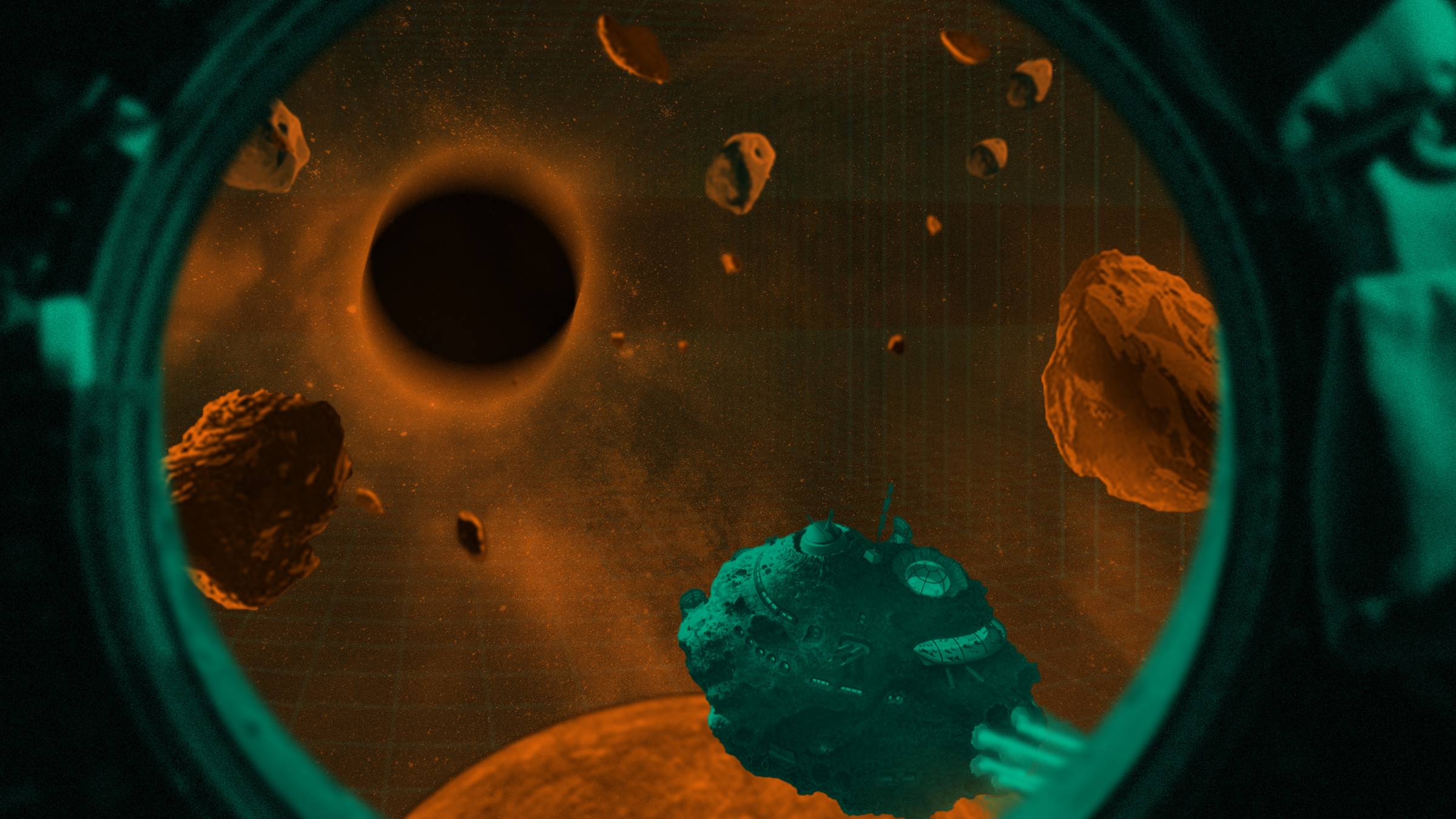
Di fronte alla ricchezza di dati del marketing digitale, ci siamo convinti di poter misurare passo passo il percorso di chi consuma e l’efficacia della pubblicità. Ma è un’illusione, perché le variabili sono molte.

Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 28 - Metrix. Viaggio all’ultima frontiera delle metriche del 24 marzo 2022
“Metà della mia pubblicità è sprecata, solo non so quale metà”. È la frase trita e ritrita che ritroverete nella metà delle presentazioni odierne di ogni operatore del mercato della pubblicità digitale, in cui lo spreco è quasi sempre identificato con gli “utenti fuori target”, mentre nella versione analogica originaria il suo significato era esteso anche al numero di persone raggiunte e agli effetti sul loro comportamento di acquisto. Chissà quanti avrebbero visto lo spot, chissà quanti avrebbero notato quel paginone sul giornale. Erano le domande che il cliente di Don Draper, il geniale pubblicitario della serie Mad Men, si faceva, nell’età dell’oro della pubblicità tra gli anni Sessanta e la fine degli Ottanta. È la grande promessa dell’advertising nell’epoca dei dati: riuscire a comunicare il prodotto giusto alla persona giusta nel momento giusto, trovare il gancio perfetto per far scattare il bisogno, direttamente nelle persone giuste, senza sprechi.
Senza sprechi
In un mondo antico, monocanale o quasi, le misurazioni erano paradossalmente rudimentali, ma semplici e condivise: lo share dell’Auditel, le copie del giornale, che facevano da base per altre misurazioni pubblicitarie. Eravamo tutti d’accordo su cosa misurare, anche se i dati erano, per così dire, statisticamente inferiti, e non direttamente ottenuti dai comportamenti del target. Oggi il pubblicitario digitale si trova di fronte a un pannello di controllo più complicato di quello di un Boing 747: in tempo reale vede il contatore delle visualizzazioni che sale, il numero di chi clicca, di chi mette like, di chi acquista. Accende i motori su un target, li spegne su un altro, accelera su quell’audience particolare che improvvisamente si è rivelata “aerodinamica” verso la conversione. La ricerca dell’investimento perfetto sul consumatore perfetto è un po’ il Sacro Graal del marketing: quando sembra di essere vicini alla sua scoperta, ecco che qualcosa va – inevitabilmente – storto. L’umanità non si lascia targetizzare e analizzare così facilmente nemmeno dagli algoritmi, e quando sembra di avvicinarsi al traguardo il prezzo da pagare non è irrilevante. La misurazione verso la perfezione non è semplice, e non è gratis. E se la misurazione della perfezione costa più del vantaggio che porta, ecco che il marketing e la pubblicità sono scacciati indietro verso l’obiettivo.
Eppure, lo scorrere della storia minore del marketing sembrava convergere senza deviazioni verso l’inevitabile granularizzazione del messaggio: a ognuno il suo micro-target, morte allo spreco del broadcasting. La macchina dell’advertising digitale si dichiarava in grado di segmentare il target fino nei minimi aspetti, in quelle informazioni che al marketing di Don Draper erano sempre negate: dove sei ora, quali siti hai visto, cosa hai messo nel carrello, che profili frequenti, in che punto del video ti sei fermato, il tutto potenzialmente rivolto a micro gruppi omogenei di poche centinaia di persone con tratti simili. Al suo apice, si è celebrata nei case study dell’industria la campagna digitale di Donald Trump, in cui migliaia di messaggi diversi erano stati chirurgicamente impiantati dividendoli tra quartieri, origini etniche e idee politiche fino a creare mille diversi Trump nella mente delle persone. A ognuno il più adatto a convogliare la rabbia verso una direzione. Da Cambridge Analytica in poi l’opinione pubblica, fino a quel momento schierata per il futuro luminoso dei “dati aperti” a tutti, ha cominciato a diffidare (di nuovo) dell’advertising personalizzato, anche incentivata dai predestinati perdenti, i giornali, che vedevano in quel nuovo modo di fare pubblicità il nemico finale. La pubblicità passava dall’essere solo una scocciatura collettiva apparentemente innocua a qualcosa che si infilava di nascosto nelle vite di ciascuno e le condizionava.
L’umanità non si lascia targetizzare e analizzare così facilmente nemmeno dagli algoritmi, e quando sembra di avvicinarsi al traguardo il prezzo da pagare non è irrilevante. La misurazione verso la perfezione non è semplice, e non è gratis. E se la misurazione della perfezione costa più del vantaggio che porta, ecco che il marketing e la pubblicità sono scacciati indietro verso l’obiettivo.
La demonizzazione ha fatto passare persino in secondo piano l’anello debole nella formula del marketing digitale. Anche se seguiamo le tracce dell’utente ovunque vada, non sappiamo davvero cosa scateni l’acquisto, non sappiamo valutare la casualità, e non tutti i passaggi. I punti di contatto con il consumatore sono in grado di fornirci informazioni parziali: checché se ne dica, il percorso di acquisto, anche nel 2021, è ancora per molti versi un buco nero. E dunque, anche se possiamo apparentemente misurare tutto, non sappiamo esattamente cosa misurare per capire quale pubblicità funziona allo scopo. In mancanza di punti fermi, è stata la stessa industria digitale (e le grandi piattaforme in primis) a proporre nuovi Kpi, indici che dovrebbero essere rilevanti per misurare l’efficacia pubblicitaria (e quindi darne indirettamente un valore di acquisto per gli investitori). Un caso unico in cui il venditore indica al compratore cosa misurare per valutare l’acquisto del proprio servizio.
L’illusione delle Kpi
L’invenzione del Cpc, cost-per-clic, sfruttata da Google per indicare il prezzo a cui comprare i clic rimane ineguagliata per efficacia commerciale: la pubblicità non era più un costo, era un investimento, perché generava fatturato direttamente rapportabile alla spesa. In azienda nessuno poteva fare nulla davanti ai numeri sonanti. E poi ancora, il famigerato Cpm, il costo per mille impression, in cui al nome carico di significato corrispondeva una definizione tecnica molto meno altisonante: quel rettangolo di pixel è stato caricato, forse visualizzato, più difficilmente visto. Con i social nasce il Cpe, cost per engagement, uno degli indici di valutazione della spesa pubblicitaria più impalpabili ed esoterici, basato sul numero di utenti che interagivano con azioni peraltro a loro volta incentivate dalla piattaforma social (like, commenta, condividi!). Fino ad aggiornarsi, dopo l’esplosione del video come contenuto dominante, al Cpv, costo per visualizzazione di video, in cui il tempo di visualizzazione standard è sceso fino agli ormai standard tre secondi per Facebook, Instagram e altre piattaforme: è il marketing con il cronometro in mano.
Cosa hanno a che fare questi indici con l’acquisto vero e proprio è più che altro una scommessa, una supposizione: più clicchi, più vedi il mio prodotto, più probabile è che lo compri, oppure semplicemente più mi vedi, più lo ricorderai, e forse lo comprerai (lo stesso paradigma di sempre). Il problema è però che fare pubblicità – in generale – non dovrebbe significare solo convertire i convertiti, ma soprattutto convincere o spingere gli indecisi. E invece spesso questi indici, nella divisione a silos delle aziende, facevano convergere gli investimenti verso i pubblici che erano lì lì per acquistare comunque – nella parte bassa del funnel, direbbe un digital marketer. Per chi per esempio ha lasciato nel carrello il prodotto, il remarketing ha un basso Cpc e indici di conversione alti, ovviamente, perché sto agendo sui quasi decisi. Se investo molta parte del budget lì, vado sul sicuro, raggiungo i miei micro-obiettivi, pensa l’ecommerce manager. E le piattaforme digitali ovviamente incentivano questo comportamento.
La iper-ottimizzazione apparente basata sui Kpi digitali porta però storture anche nella fase iniziale del percorso di acquisto: quando non si parla ai quasi convertiti. Se per l’acquisto di pubblicità digitale mi baserò sul minore Cpm possibile, cosa otterrò in cambio? Probabilmente le visualizzazioni di persone più facili da raggiungere (oppure delle non-persone, cioè dei bot) e probabilmente in luoghi periferici della rete. Il targeting digitale funziona perché convince gli individui più fertili o perché è basato sulla spasmodica ricerca di chi ha già lasciato tracce di un probabile acquisto? Il dubbio rimane. L’epoca del “tutto è misurabile” si scontra quindi con la difficoltà di definire qualsiasi parametro oggettivo di valutazione del valore della pubblicità, che prenda in considerazione l’incrementalità nei comportamenti dei consumatori, e non il raggiungimento di un obiettivo in sé.
Nel frattempo, la centralizzazione del web ha fatto sì che, all’interno dei walled garden di Google, Facebook e Amazon, l’unico autorizzato a misurare i dati dei visitatori sia il giardiniere stesso. Chi sa davvero quante sono state le visualizzazioni di un post su Facebook o le visualizzazioni degli annunci su Google? Solo Facebook e Google, autocertificazioni. Chi mi dice che quella audience che mi vendono sia davvero interessata al cibo biologico? Chi ci lavora oggi ha molti dubbi che le tracce lasciate dagli utenti siano davvero profonde. A volte basta guardare un video di Gucci per essere definiti “interessati a prodotti di lusso”. Insomma, dobbiamo fidarci.
Lo spazio aperto non è migliore
In realtà, non che oggi la situazione dell’open web, frazionata in centinaia di operatori della filiera, la cosiddetta display in programmatic, sia molto differente. Sia pure in una fase di concentrazione post-Gdpr l’industria è composta da una babele di misurazioni diverse, formati diversi, posizionamenti di qualità molto diversi. Dopo quanti pixel, quanti centesimi di secondo dobbiamo considerare un banner “visualizzato”? L’industria ha dovuto riunirsi per deciderlo. E quante di quelle visualizzazioni “certificate” sono di persone in carne e ossa e quante di bot ospitati in qualche click farm in paesi a basso costo di lavoro ed elettricità? Seguendo le infinite tracce della navigazione personalizzata degli utenti nell’open web, non sai davvero dove la tua pubblicità potrebbe finire, se va ad alimentare indirettamente un blog di sovranisti neonazi dell’Ohio o di fake news tradotte da qualche sito russo, se i click su quel banner su di una mobile app siano davvero voluti, e se lo stesso banner sia davvero comparso e per quanto tempo in una frazione di uno schermo, e ancor meno comparso nella retina, e ancor meno nella mente di qualcuno.
Anche i costi sono tutt’altro che trasparenti: vari studi, di cui il più importante del 2020 a cura di Isba-McKinsey-Aop indicano come su cento euro spesi dall’inserzionista, solo 50 euro vadano al publisher: gli altri 50 euro vanno a intermediari tecnologici che comprano spazi, migliorano il targeting, distribuiscono gli annunci, o semplicemente spariscono nel processo. La pubblicità targetizzata e programmatica ha dunque un costo tutt’altro che residuale. Nel caso di Facebook e Google il problema non si pone: intermediario e publisher sono lo stesso organismo, e fanno il prezzo totale con l’asta, un meccanismo di per sé che premia gli estremi, e quindi probabilmente sposta il prezzo a un livello superiore al valore. Prendere o lasciare.
Il marketing digitale rischia di cadere nella trappola che prende il nome dall’economista Charles Goodhart: “Quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona misura”. Quando il Kpi diventa l’obiettivo, finisce per essere un cattivo indice. Soprattutto se a indicare i Kpi è chi ci vende la pubblicità. In un mondo ormai multi-canale, multi-mediale, multi-tutto, il marketer anziché essere guidato dal dato, rischia di essere guidato di nuovo dal suo fiuto. Perché sente che in quel basket di dati, le mele sono mescolate alle pere, che l’attenzione spesso semplificata in “tempo e pixel di visualizzazione” della tv non è paragonabile (in senso stretto) a quella di YouTube, e quella di un tweet è diversa da quella di un banner su Repubblica.
Piccoli e grandi
Questa situazione si sviluppa senza particolari sollevazioni da parte degli investitori perché anche il panorama degli inserzionisti pubblicitari è cambiato con il digitale: rispetto agli anni Ottanta in cui il mercato pubblicitario above the line era composto da una ristretta cerchia di selezionati brand altospendenti di pochi soliti settori e solitamente riuniti in associazioni (Wfa quella mondiale, Upa per l’Italia), dal 2010 in poi il digitale ha liberato una coda lunghissima di pasticceri, micro brand, venditori di corsi, ecommerce, startupper, perfino aziende del B2B della periferia profonda. Oggi la stragrande parte, non solo in numero ma anche in valore, degli inserzionisti di Google e Facebook sono Pmi o professionisti. Nel primo trimestre 2020, la spesa media di un inserzionista di Facebook era poco più di 2.000 euro (fonte: Statista). Per questo finora ogni tentativo di boicottare le ads di Facebook, per ragioni più o meno giustificate, da parte dei brand altisonanti non ha minimamente impattato sui conti di Meta: appena visto il vuoto nelle aste, i micro-business hanno utilizzato gli spazi lasciati dai grandi inserzionisti per infilarcisi con l’ultimo modello di scarpa semi-artigianale, o la nuova sciarpa colorata, o l’ennesimo paper gratis-ma-devi-lasciare-la-mail su come far svoltare il tuo lavoro di gelataio. Per questi business, la misurazione puntuale non è il problema principale: i budget sono così piccoli e i perimetri limitati che possono misurare direttamente sui risultati finali. Quanti visitatori al sito, anzi, quanti compratori, quanti avventori al ristorante, quante email di informazioni ricevute. Sono state davvero 30.000 quelle visualizzazioni, o 29.000? Non è un gran problema, finché porta visite. Non sanno se quella audience proposta è davvero interessata al biologico? Se non funziona in termini di vendite, si spegne tutto e si riprova con altri parametri di targeting.
Il marketing digitale rischia di cadere nella trappola che prende il nome da Charles Goodhart: “Quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona misura”. Quando il Kpi diventa l’obiettivo, finisce per essere un cattivo indice. Soprattutto se a indicare i Kpi è chi ci vende la pubblicità.
Al contrario, i grandi spender tradizionali sono spesso appartenenti al settore Cpg, cioè dei beni di largo consumo, che non hanno nessun contatto diretto digitale con il proprio cliente, e sono i principali scontenti del nuovo corso. L’advertising per loro è qualcosa che va ancora misurato necessariamente con l’impatto sulle menti di compratori molto meno differenziati e segmentabili di bucatini, carne in scatola, cioccolata, detergenti per il bagno venduti alla grande distribuzione. Perché le variabili di quell’acquisto non stanno nei dati dei touchpoint di un funnel o nelle visite al sito, ma risiedono ancora ora in tre fattori cruciali: il ricordo di marca, la disponibilità a scaffale e la promozionalità. Per i responsabili dell’acquisto di advertising dei grandi brand nati dalla tv il mercato digitale è un’insidia: perché sono valutati internamente (e con grande incertezza) sull’attenzione che l’advertising produrrà, mentre l’impatto sulle vendite dipenderà da molti altri fattori. E non potendo misurare l’attenzione è necessario almeno misurare la visualizzazione, possibilmente definita in modo standard.
Operazione ritorno al futuro
Non è un caso il timing delle proposte dalle associazioni di inserzionisti ai publisher e alle piattaforme: l’idea è di ricreare di nuovo un sistema in cui ci sia un arbitro giudicante e terzo, e un insieme di norme formali sulle quali basare l’acquisto di pubblicità. Ma siccome il mondo è cambiato, il sogno è di seguire un folto gruppo di persone, un panel, in ogni momento della loro vita, dalla fruizione di Netflix fino a L’isola dei famosi, passando per Repubblica ma anche da Amazon e dal negozio fisico. Il risultato è un complesso Auditel più Audiweb più mega-Google Analytics aggiornato a un mondo omnicanale, di complessa realizzazione tecnica e “politica”, dai presupposti friabili sul fronte della privacy. E nel mirino principale il focus è ovviamente la misurazione standard, come si legge nel documento di Upa: “Una corretta misurazione produce benefici ai consumatori attraverso una migliore esperienza della pubblicità, evitando i fenomeni di rigetto e di ostilità, e un maggiore valore per gli inserzionisti attraverso una maggiore efficacia ed efficienza nel mercato dei media”. Non si capisce in che modo una corretta misurazione potrebbe migliorare la loro esperienza della pubblicità, forse limitandone l’eccessiva ripetitività?
E il maggior valore è sicuramente dei grandi inserzionisti, non certo dei piccoli, per lo più disinteressati ed estranei alle logiche delle associazioni di inserzionisti. E cosa si misurerà? Per quanto riguarda l’impatto, alla fine appare, di nuovo, una linea di demarcazione astratta, non si sa se dettata da studi di neuromarketing o semplicemente una media accettabile per tutti, di visualizzazione “tecnica”: “Viewability […] dovrebbe essere definita al 100% dei pixel per almeno due secondi consecutivi di visione”. La proposta operativa di Upa pare prendere in considerazione, oltre al mega panel, anche i dati dei siti e delle piattaforme, in cui i partecipanti inserzionisti dovrebbero far confluire in qualche modo i dati profilati degli utenti. Ma chi decide il peso e la composizione di questo mix nell’insieme? E soprattutto, chi convincerà i walled garden duopolisti a farsi misurare, quando la maggior parte dei loro investitori pubblicitari non solo non lo richiede, ma non capisce nemmeno di cosa si sta discutendo? E gli utenti consenserebbero (per usare il linguaggio dell’industria) l’afflusso dei loro dati in questo audi-omni-web in cambio di una vaga promessa di minor rigetto e ostilità?
Con queste premesse, c’è da dubitare che l’operazione ritorno al futuro vada in porto. La strada potrebbe essere diversa: e se invece questa necessaria crescita nella capacità di misurare, confrontare, valutare l’advertising che gli inserzionisti comprano fosse basata su una migliore capacità delle stesse aziende di correlare spese e risultati, e di raccogliere dati di prima parte volontariamente dai propri utenti, anziché definire controversi standard validi per tutti? Il Sacro Graal continua a sfuggire di mano.
Gianluca Diegoli
Dalla Bocconi in poi osserva passare i trend dall’evanescente confine tra online e offline. Di giorno si occupa di marketing e digital, di notte ha scritto Svuota il carrello (2020) per UTET. È professore a contratto in IULM e in Master. Ogni venerdì alle 9 manda la sua newsletter.
Vedi tutti gli articoli di Gianluca DiegoliLeggi anche

Mediamorfosi 3
L’infinite Jest delle piattaforme


