
Qual è il rapporto tra Marshall McLuhan, letterato cattolico studioso di media, e le controculture? Frammenti di una storia sbilenca, ma sorprendente.
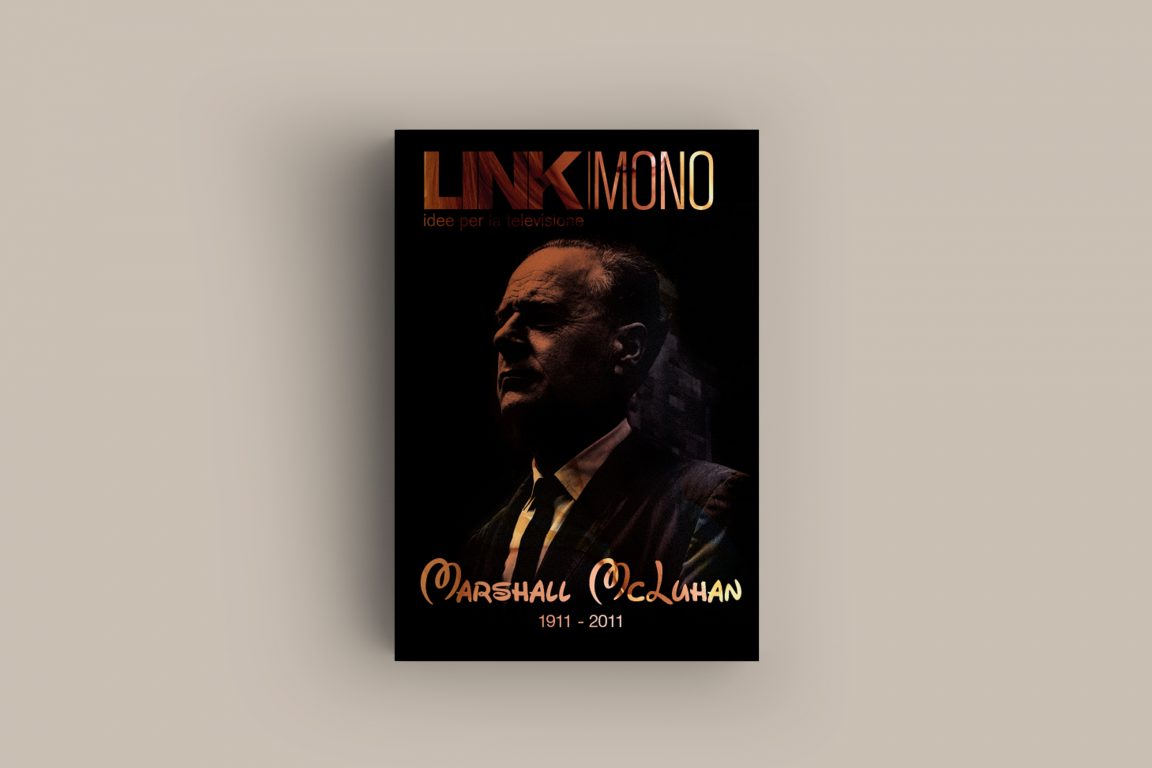
Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Link Mono - Marshall McLuhan del 04 luglio 2011
Il rude slogan controculturale, figlio del crudele secessionismo anagrafico dei Sixties, “Non fidatevi di chi ha più di trent’anni”, ammetteva solo qualche sparuta eccezione alla regola. Erano esentati dal sospetto solo i padri della beat generation, gli accademici devianti, qualche barbuto guru himalayano, sparse personalità eccentriche-rivoluzionarie del mondo della politica, dell’arte e della musica.
Eppure proprio quella scena ribelle giovanile, così schizzinosa verso il mondo adulto, aveva adottato con entusiasmo un professore canadese che non rientrava in nessuna delle categorie sopra menzionate. McLuhan non era un tipo pittoresco, un soggetto socialmente pericoloso né tanto meno un pensatore eretico. Era un signore normale, eterosessuale, persino monogamo. Il suo look, in tempi di mise esotiche e stilisticamente imbarazzanti, era fermo all’insipiente anonimato della giacca e cravatta. Anche il suo curriculum ideologico stonava con l’agenda rivoluzionaria. Nessun outing politico arrischiato, nemmeno una blanda condanna all’intervento americano in Vietnam. In passato era stato un divulgatore dell’opera di un chiacchierato artista britannico, antisemita e apologeta di Hitler, Wyndham Lewis. Non vedeva di buon occhio l’emancipazione femminile e attribuiva il declino della famiglia tradizionale all’ingresso nel mondo del lavoro delle donne. Protestante per nascita, era approdato al cattolicesimo più intransigente, schierandosi senza riserve, dopo il Concilio Vaticano II, contro le scelte modernizzatrici e “lassiste” della nuova dirigenza papale. Non aveva nessuna velleità anti-sistema, collaborava con l’establishment, era consulente di aziende multinazionali e agenzie pubblicitarie.
La sua fortuna risiedeva in una stupefacente verve oracolare. Da intellettuale perfettamente sintonizzato con i tempi, sapeva che le tante Alici in cerca del Bianconiglio nel vasto giardino dell’infosfera si sarebbero tenute ben alla larga dai libri e concetti “senza neanche una figura” e quindi accompagnava la sua teoria, imperscrutabile e nebulosa, con un uso massiccio di geniali slogan, aforismi, battute e citazioni randomizzate. E, se era il caso, si affidava al supporto grafico dell’art director Quentin Fiore, creando un mood comunicativo contiguo a quello della stampa underground. Un apparato perfetto per chi – come i baby boomer – era cresciuto a fumetti e jingle televisivi. Il suo linguaggio era talmente cool da stregare persino un maestro di snobismo letterario baroccheggiante come Tom Wolfe. Con la sua opera offriva una specie di giustificazione al turbinoso senso di spaesamento delle comunità più radicali. Le esperienze psichedeliche, gli approcci olistici al mondo, le derive nell’irrazionale e nella non-linearità, i bombardamenti multisensoriali a cui si sottoponevano i giovani più avventurosi o imprudenti non venivano più considerati pericolose forme di alienazione, bizzarrie, ma addirittura esaltati come epifanie di un futuro a base di interconnessioni ardite e persino scorporate.
Proprio quei ragazzi stonati e confusi erano indicati come esempi concreti della capacità di gestire il cambiamento in atto. Finalmente qualcuno li pigliava sul serio. Per loro, il mantra di McLuhan, che prospettava la trasformazione dell’intero pianeta in un caleidoscopio, grazie ai sensi amplificati dalla tecnologia, alle estensioni del sistema nervoso attraverso i media, suonava non solo probabile ma persino ovvio. Chi meglio dei baby boomer mutanti poteva capire quella faccenda del Villaggio Globale? Loro vivevano già nel nuovo ambiente intasato di stimoli comunicativi, si cullavano con il rock’n’roll (la prima colonna sonora elettrica della storia), giocavano alla roulette russa con l’ego e la prospettiva di collettivizzare la coscienza non li spaventava. Si espandevano, scomponevano, scioglievano negli spettacoli multimediali son et lumiére. Molti, durante i viaggi con l’acido lisergico, avevano provato l’emozione di sentirsi risucchiati nell’impianto elettrico di casa, per poi ritrovarsi, tutti uniti, nella Dinamo Celeste cantata da Allen Ginsberg.
McLuhan non era un tipo pittoresco, un soggetto socialmente pericoloso né tanto meno un pensatore eretico. Era un signore normale, eterosessuale, persino monogamo. Il suo look, in tempi di mise esotiche e stilisticamente imbarazzanti, era fermo all'insipiente anonimato della giacca e cravatta. Anche il suo curriculum ideologico stonava con l'agenda rivoluzionaria.
Nel 1967 sul giornale underground newyorkese East Village Other appariva un articolo/manifesto che segnalava inequivocabilmente l’endorsement alle idee del professore.
Noi siamo la generazione dell’età elettrica, i primi a sentire l’impatto dell’effetto retribalizzante del nuovo ambiente multimediale. Siamo cresciuti con la televisione, che nutre i nostri cervelli con milioni di puntini neri e bianchi, elettronicamente assemblati e riassemblati in immagini e schemi della durata di microsecondi. Siamo nell’età del gesto e della forma, non siamo più parte di un meccanismo nazionale. Siamo una tribù. Siamo i nuovi indiani d’America che fumano hashish e erba e ingoiano peyote come un rito tribale. Siamo la reincarnazione dell’uomo pre-letterato e orale.
McLuhan accettava i complimenti di cattivi soggetti, come il rivoluzionario hippie Abbie Hoffman, duettava con il beatle John Lennon in fase militante, dava consigli a Timothy Leary sul modo migliore di farsi fotografare durante le interviste. La scena artistica lo adorava, perché offriva un supporto ideologico e parascientifico alle attività più strampalate, laddove la presentazione, la relazione tra media e fruitore, era più importante del contenuto. Era una popstar intellettuale, molto trasversale secondo i canoni del post-modernismo; le sue teorie erano diventate materia di conversazione nei cocktail party.
Il Villaggio Globale assomigliava molto – per chi stava flirtando con le culture orientali – all’Oceano induista in cui la molteplicità delle anime si fondeva nell’unità così come fanno le gocce d’acqua dopo la pioggia. Era la mente universale del gnosticismo, l’anima mundi junghiana. McLuhan, da parte sua, stava costruendo una mitologia integrativa, sviluppando un pensiero spiritualista vicino al trascendalismo tecnologico del gesuita Pierre Teilhard de Chardin. Il suo Villaggio Globale si sarebbe trasformato – con l’aiuto dell’elettronica e dei media – in una comunione psichica dell’intera umanità, nella mente universale, nel Corpo di Cristo Cosmico definitivo, nientemeno che nella fine del processo evolutivo dell’umanità, un’eventualità che non sarebbe dispiaciuta nemmeno all’hippie più sballato. Come un mistagogo, stava adattando il mito cristiano (“non un semplice racconto ma qualcosa di più reale della realtà ordinaria”) all’era elettrica. McLuhan considerava il mito come il processo finale di una storia condensata e accelerata, percepita ad alta velocità. Agendo in concerto con il cambiamento tecnologico, il mito si velocizza ulteriormente e svela la natura stessa del processo in atto.
Nel suo zelo missionario non esitava a tenere a distanza la ragione e il mondo euclideo, facendo ampio uso degli strumenti creativi agitati da James Joyce, Ezra Pound e Lewis Carroll. Il caso e l’azzardo – così apprezzati dalla scena artistica coeva – gli avevano dimostrato la loro benevolenza ed erano strumentalmente utili nel momento in cui si erano manifestati in un refuso, che aveva trasformato il roboante “Il medium è il messaggio” nel fantastico “Il medium è il massaggio”.
Affinità elettive?
Peccato che la storia della retribalizzazione fosse un brillante artificio retorico, qualcosa che non aveva nulla a che vedere con le comuni hippie, con i crash pad rivoluzionari, con gli accampamenti di tepee e cupole geodesiche nella natura. McLuhan assegnava ai nuovi media il compito di restaurare una tradizione comunitaria idealizzata. Una mitologia postmoderna, costruita intorno a un modello conservatore, organicamente patriarcale e anti-individualista, ricalcato sulla retorica del Vecchio Sud degli Stati Uniti culla di una società basata su ordine e decenza, onore e rispetto. Il suo villaggio globale assomigliava tanto a un villaggio puritano, dai costumi austeri, moralista e occhiuto. Una comunità semitollerante per le sperimentazioni giovanili, basata sull’inviolabilità del matrimonio e sull’indiscutibile centralità della famiglia; dove infedeltà e divorzio erano considerati come gravi violazioni del contratto sociale. Una società che puniva e bandiva chi trasgrediva e offendeva i suoi valori tribali.
Quanto fosse reazionaria la faccenda lo aveva ben capito Guy Debord che derideva – in tempo reale – il “saggio di Toronto”, impegnato da decenni a tessere lodi sperticate “alle grandi libertà offerte dal villaggio globale, comodamente accessibile a chiunque”, senza farsi troppe domande sul modo di arrivarci. Il polemista francese (parte della Trimurti massmedialogante con McLuhan e Andy Warhol) sottolineava quanto i villaggi, da sempre, fossero sinonimo di piccineria nei rapporti tra individui, di conformismo, controllo sociale, noia e infiniti pettegolezzi sugli stessi soggetti. Quel suo celebrare la realtà quotidiana solo come rappresentazione o mediazione, aderendovi con l’entusiasmo di un apologeta dello spettacolo, era francamente ridicolo. Tanto più che il Nostradamus canadese offriva conforto agli araldi del consumismo e ai loro avversari, teorizzando la neutralità delle scoperte scientifiche. Per Debord non era altro che il pensiero postmoderno coniugato con il capitalismo up to date, la riduzione/sintesi della cultura in slogan, la prospettiva di un felice stato di servitù nel villaggio globale.
Chi meglio dei baby boomer mutanti poteva capire quella faccenda del Villaggio Globale? Loro vivevano già nel nuovo ambiente intasato di stimoli comunicativi, si cullavano con il rock'n'roll, giocavano alla roulette russa con l'ego e la prospettiva di collettivizzare la coscienza non li spaventava. Molti, durante i viaggi con l'acido lisergico, avevano provato l'emozione di sentirsi risucchiati nell'impianto elettrico di casa.
Dopo le drammatiche rivolte razziali di Watts, la priorità per McLuhan non era la riapertura delle scuole, quanto il veloce ritorno dei bambini afro-americani davanti ai teleschermi. Riteneva che per i bambini “tribali” il paesaggio virtuale avesse la stessa intensità e importanza delle praterie sconfinate per gli indiani d’America. Un luogo dove imparare a vivere, fare esperienza. È degno di nota che la sua percezione alterata di gruppo non fosse legata a un concetto etnico: i campioni del tribalismo moderno a cui faceva riferimento – in opposizione al tanto detestato individualismo americano – erano gli hippie, i francofoni del Quebec e gli afro-americani. La società dello spettacolo apprezzava le sue parole, e il mcluhanismo diventò un fortunato stereotipo. Poi, con la fine dei Sixties, anch’esso perse il favore popolare seguendo la sorte dei pantaloni a zampa d’elefante.
Verso la metà degli anni Settanta si registra un breve momento di rivalutazione del suo lavoro, operato dalla scena punk che intingerà il biscotto nel suo elogio del dilettantismo, nell’apologia dell’approccio amatoriale, del fai-da-te e dell’incompetenza come valori. La tecnologia non spaventa il punk e la faccenda della sfida al diritto d’autore, al professionismo, è quanto mai allettante. Tra le altre cose, McLuhan aveva intuito che, con la diffusione delle fotocopiatrici, chiunque poteva diventare autore ed editore di se stesso; aveva persino profetizzato l’avvento della pirateria con il “Furto istantaneo!” di testi, foto e brani musicali. Detto, fatto! Le fanzine xerografate – un vero inno alla molteplicità comunicativa – entrano di diritto nell’armamentario della subcultura più spillata della storia. Per il punk, McLuhan è l’uomo che istiga a comporre collage esperienziali, il teorico della scomplessata giustapposizione postmoderna. A differenza dei suoi fratelli maggiori hippie, il punk scopre e sottolinea il fondo di cinismo presente nella sua opera; ridicolizzare il passato, senza nemmeno aver bisogno di un futuro. Gli slogan coniati o usati dal mass-mediologo – tipo “Il dilettante può permettersi di perdere”, “Il mestiere del futuro è essere pericolosi” o “La nuova arte è violenza sensoriale esercitata contro le frontiere dell’esperienza” – sono miele per le orecchie dei giovani antagonisti. Ma è soprattutto quello che recita “L’arte è qualcosa con cui puoi sempre farla franca” a stimolarne la fantasia. È uno slogan che sembra coniato su misura per l’inventore del punk – o quanto meno della sua immagine pubblica.
Lui è Malcolm McLaren, coscienzioso studente della sopra citata Trimurti. Naturalmente il partner in crime della stilista Vivienne Westwood aveva nei riguardi delle idee del professore canadese un approccio più interessato rispetto al semplice richiamo “vibrazionale” del cameratismo hippie. I due Mc si assomigliavano per lo scarso interesse per il latore del messaggio; per il resto avevano poco da spartire, aspirante rivoluzionario il primo, rivoluzionario suo malgrado il secondo. McLaren applicava, con una certa ferocia, l’idea che l’etichetta (il nome Sex Pistols o gli abiti scarruffati da lui prodotti) fosse più importante del contenuto (la musica, i testi o la qualità del tessuto). Il mezzo identificava il suo prodotto (quattro ragazzotti senza arte né parte o una linea di abbigliamento improbabile) come qualcosa di sordido, pericoloso, insolente, sovversivo: appetibile per i tempi grami del thatcherismo. Se McLuhan aveva avuto al suo servizio Quentin Fiore, McLaren si era affidato ai servizi di Jamie Reid. Negli anni Novanta, una deriva letteraria del punk, il cyberpunk, rispolvererà “l’idiota del Villaggio Globale” che sarà venerato dagli esegeti del cyberspace, dai fan del post-umano protesizzato e interconnesso. L’esplosione di internet e dei social network lo piazzerà stabilmente ai primi posti della hit parade della visibilità mediatica.
A ogni modo, il mezzo è il messaggio, ma la mappa non è il territorio. Tra mezzo e messaggio dov’è finito il messaggero?
Matteo Guarnaccia
Artista, saggista e storico del costume. È attivo nel campo della comunicazione, della musica, del design e della moda. Ha scritto una ventina di saggi dedicati alle avanguardie e controculture del Novecento, e collabora con Vogue, Rolling Stone, Abitare, Wired e Alias. Ha curato mostre skate art, sul movimento Provos, sulla psichedelia, su Vivienne Westwood e Giorgio Gaber.
Vedi tutti gli articoli di Matteo GuarnacciaLeggi anche

Serial writers
Intervista a Valerio Bergesio

Media
Plenitudine digitale

