
Il 17 dicembre 1989 va in onda negli Stati Uniti il primo episodio de I Simpson, Un Natale da cani. Sono passati tre decenni, e vale la pena tornare alle radici del fenomeno per ricordarci cos’è stato.
C’è davvero bisogno di scrivere de I Simpson? La serie-barra-cartone-barra-fenomeno-culturale creata da Matt Groening che debuttava in prima serata il 17 dicembre 1989 non è un titolo che va riscoperto, un prodotto come Seinfeld o Friends. Friends è finito da un pezzo e la gente ancora ne parla, Seinfeld (distante dai discorsi dell’uomo della strada) non si può scalfire tanto ineccepibili sono le sue sceneggiature. I Simpson hanno invece perso molta della street cred accumulata nei primi, brillanti, anni e, nell’indifferenza di molti, ogni stagione porta con sé una ventina di nuovi episodi pronti a occupare il palinsesto, nel marasma di serie che vivono su attese pompate a forza nei polmoni del pubblico. La complessità delle sceneggiature, la tenuta degli episodi a fronte di visioni ripetute, il flusso magmatico di umorismo scemo e citazioni dotte (quali altri programmi tv hanno avuto tra gli ospiti Robert Pinsky, Dudley Herschbach, Art Spiegelman, John Updike, Thomas Pynchon e Maya Angelou?) hanno reso I Simpson un oggetto culturale esaminato fino allo stremo. Dopo trentuno (!) stagioni, è oggi svuotato del fascino originale, ma è il prezzo da pagare per essere diventata la serie tv più longeva di sempre.
Come scrivono Alan Sepinwall e Matt Zoller Seitz nel libro TV (The Book), I Simpson “ha smesso di essere un prodotto tv ed è diventata un’entità più simile a un’istituzione: una cosa che abbiamo, che usiamo, che diamo per scontata”. Hanno avuto un’influenza enorme sulla televisione, hanno ispirato tutti i cartoni da prima serata venuti dopo (King of the Hill, I Griffin, South Park, Futurama) e varie sitcom, hanno cambiato la lingua (coniando vari neologismi) e intere biblioteche si sono riempite di saggi e tesi di laurea declinanti la serie su ogni sapere (I Simpson e la matematica, la politica, la religione, la filosofia, la comicità, il linguaggio, il giornalismo, internet). La voce dei Simpson è omnicomprensiva: ribelle e confortevole, classica, intellettualoide, iconoclasta eppure intertestuale, stupida e celebrativa, dentro a I Simpson puoi vedere tutto ciò che vuoi, sono una cosa e l’opposto. Sono enciclopedici.
Paternità
Difficile, in un prodotto tendenzialmente collaborativo, indicare con certezza la paternità di certe scelte. “Leggo libri su Star Trek in cui Roddenberry non è per forza la mente di tutto, oppure su Il padrino in cui c’è Coppola e un gruppo di altre persone. È una grande collaborazione”, dice Jay Kogen in The Simpsons. La vera storia della famiglia più importante del mondo. “Ma è una versione difficile da raccontare alla stampa. A loro piace trasformare le persone in celebrità, e così prendono un tipo e dicono: ‘Questo è il tizio che l’ha fatto’ e alla fine hanno una bella storia”. È però indubbio che, all’inizio di tutto, ci siano tre uomini: Matt Groening, Sam Simon e James L. Brooks. Furono loro a sviluppare la serie quando 20th Century Fox decise di trasformare i piccoli corti di Groening che stavano nel Tracey Ullman Show in un cartone di mezz’ora, il primo trasmesso di sera dopo Aspettando il ritorno di papà – 17 anni prima.
Groening era un fumettaro underground diventato famoso per Life in Hell, striscia piena di desolazione, nichilismo, ma anche amore, dal peso narrativo pari a zero; Simon era un televisivo noto per Taxi, Cin Cin e It’s Garry Shandling’s Show, si intendeva di animazione e aveva un caratteraccio. E poi c’era Brooks, all’epoca re Mida di Hollywood, capace di passare senza sforzi dalla tv al cinema con incredibili successi in entrambi i campi (Mary Tyler Moore, i tre Oscar per Voglia di tenerezza). Con questi tre padri I Simpson sviluppò una formula che andrà perfezionandosi negli anni: scena underground da una parte, centro del mondo dall’altra, in mezzo uno spirito arguto che sapeva prendere il meglio dei due universi, dando un po’ di struttura e di cuore all’energia ribelle di Groening, e togliendo la patina azzimata allo stile narrativo di Brooks. I Simpson arrivò in un panorama tv dove, a parte le eccezioni di Cin Cin e Pappa e ciccia (“anomalie in un mondo altrimenti squallido e cupo”, scrive John Ortved), la cifra stilistica era l’umorismo conservatore de I Robinson, Genitori in blue jeans e Casa Keaton e dove essere autori televisivi era considerato la cosa più distante dal prestigio che si potesse immaginare tra gli scrittori dell’industria dello spettacolo, figurarsi essere autori televisivi di cartoni animati.
I Simpson sviluppò una formula che andrà perfezionandosi negli anni: scena underground da una parte, centro del mondo dall’altra, in mezzo uno spirito arguto che sapeva prendere il meglio dei due universi, dando un po’ di struttura e di cuore all’energia ribelle di Matt Groening.
Fu Jim Downey, head writer del Saturday Night Live negli anni Ottanta e poi del Late Show di David Letterman, a iniziare ad assumere talenti della Ivy League, il nome sotto cui si riuniscono le università più prestigiose. Sam Simon ne seguì l’esempio e chiamò laureati ad Harvard che scrivevano sull’Harvard Lampoon, la rivista umoristica dell’università. Trovò George Meyer – autore comico che stava scrivendo una sceneggiatura per un film che avrebbe dovuto interpretare David Letterman – leggendo Army Man, una fanzine autoprodotta che lui aveva fatto circolare tra amici e colleghi e in cui scrivevano Jon Vitti e John Swartzwelder. Simon finirà per assoldare gran parte delle firme di Army Man, tanto che David Owen, sul New Yorker, scriverà: “quella rivista è la vera madre della serie”. Anche Groening provò a chiamare a raccolta le sue conoscenze fumettistiche, ma, apparentemente, la sola ad accettare fu Mimi Pond. L’autrice finì per scrivere il pilota involontario Un Natale da cani e rimase a lungo una delle poche sceneggiatrici del gruppo. Non le venne mai chiesto di far parte della writers’ room. Le cose cambieranno, ma almeno agli inizi la voce preminente era quella del maschio bianco. Lo staff che tenne a battesimo la serie si componeva di Sam Simon, Al Jean, Mike Reiss, Jace Richdale, Jon Vitti, George Meyer, John Swartzwelder, Jay Kogen, Wallace Wolodarsky, Jeff Martin e Matt Groening (“in un certo modo”, per i maligni, riferendosi al contributo esiguo del fumettista). Meyer e Swartzwelder si distinsero nelle gag e battute. Ma se Swartzwelder era un tipo solitario, un Clark Gable con i baffi a ferro di cavallo, dalle sceneggiature robuste, Meyer divenne il grande livellatore, alzando la qualità media nelle sue riscritture.
Prima stagione
Come succede spesso, la prima stagione de I Simpson è molto diversa dal resto della serie. Ma è anche molto diversa dalle prime stagioni in generale. Negli episodi che si raccolgono attorno al pilota vanno introdotti i personaggi, sviluppate le personalità e presentate le dinamiche, insomma c’è tanto lavoro sporco da fare per trovare – magari alla seconda o terza stagione – la propria voce. Qui un vero pilota non c’è, perché la serie prosegue dai corti del Tracy Ullmann Show, tanto che il primo episodio trasmesso, Un Natale da cani, non è il primo a essere stato realizzato (quello è Sola, senza amore, mandato in onda per ultimo per problemi in fase di animazione). Nei tredici episodi, le situazioni erano realistiche: Homer vive nel terrore di perdere il posto di lavoro, la famiglia è in ristrettezze economiche, Marge è una madre frustrata, Lisa un animo intelligente ma incompreso, Bart un monello annoiato da un mondo che gira troppo lento. Le risate ci sono ma sono sempre ricondotte a dinamiche concrete, serie. Brooks introdusse il sentimento nella serie, spingendo più storie possibili su Marge e Lisa, più difficili da scrivere – anche per mancanza di un punto di vista femminile. Quelli con Marge, in particolare, erano i copioni più complicati da risolvere, proprio per la distanza rispetto al vissuto degli autori, che potevano al massimo pescare nelle esperienze di seconda mano delle loro madri, sorelle, mogli, ma anche perché Marge è il pilastro che tiene in piedi la famiglia. Quando funzionano, gli episodi Marge-centrici sono di solito i più emotivi, sia in presenza (Marge non essere orgogliosa, storia di un furto natalizio che mette in discussione il rapporto con Bart) sia in assenza (Homer da solo, in cui la permanenza di Marge in un centro relax mette le responsabilità famigliari sulle sole spalle di Homer).

Nei primi episodi de I Simpson il vero protagonista è Bart. Il primogenito della famiglia divenne popolarissimo tra gli spettatori più giovani, nonché onnipresente nell’oggettistica prodotta a getto continuo. Saccente, sfrontato, furbo, spiritoso, ribelle e allergico a qualsiasi forma di autorità (scuola, famiglia, religione), diceva ciò che ognuno avrebbe voluto dire, era sovversivo ma con cuore. Anche se rubava la dentiera del nonno non era cattivo. La sua preghiera prima di cena si riassumeva in un “Signore Iddio, abbiamo pagato noi per tutta questa roba perciò grazie di niente”, una frase piena di sdegno verso la reverenza religiosa e un ribaltamento di valori famigliari, riti e tradizioni. Già da questo solo prelievo si capisce come I Simpson rappresentasse la famiglia nei suoi aspetti imperfetti e ruvidi, rifiutando le visioni pulite e concilianti degli altri show in onda. A partire dalla terza stagione, le attenzioni di Simon e soci si spostarono su Homer. Esistevano un numero finito di ricordi e aneddoti d’infanzia a cui gli autori potevano attingere, e Bart era una figura molto rigida in cui far convivere ipotetiche dinamiche. Storie di scuola, storie di crescita, storie di amicizia, altre storie di scuola. Le situazioni si esauriscono in fretta e il ruolo di protagonista passa a Homer, più flessibile e cangiante, con cui era possibile raccontare vicende matrimoniali, storie di lavori folli, avventure in giro per il mondo.
Scrollandosi di dosso l’aura malinconica e la voce guardinga che il doppiatore Dan Castellaneta aveva ricalcato da Walter Matthau, il capofamiglia si trasformò nell’attore principale. Coinvolgere Homer significava anche ampliare il cast. Springfield divenne la tavolozza bianca su cui dipingere di tutto – il perbenismo del vicinato (Ned Flanders), l’ipocrisia della religione (reverendo Lovejoy, più varie sette), l’incompetenza delle forze pubbliche (Winchester), della sanità (Nick Riviera), la desolante mancanza di fondi, mezzi e motivazione della scuola pubblica (direttore Skinner, Edna Caprapall), l’opacità del giornalismo (Kent Brockman), la celebrità che rende vanesi, sciocchi o dipendenti da qualsiasi vizio (Krusty, Rainer Wolfcastle). Springfield è una qualsiasi periferia in grado di dotarsi alla bisogna di un porto, di una catena montuosa da scalare, ha una rivalità campagnola con Shelbyville ed è distante ma non troppo dalla metropoli – Capital City. E quando manca un pezzo del discorso lo si introduce (per arrivare a caratteri molto specifici come Lindsey Naegle, simbolo delle sclerotizzazioni del mondo del marketing, o l’immobiliarista furente Cookie Kwan) o si prende in prestito una celebrità-simulacro. Così facendo, I Simpson arrivò a raccontare l’intera esperienza umana.
Dall’assurdo al normale e ritorno
È anche questo il motivo per cui la serie, dal punto di vista del sentire comune, si è normalizzata. In America si creò il contesto, dopo Reagan e Bush, di un mondo in cui tutto andava bene e gli spettatori si sentivano a loro agio con il cinismo. Le istituzioni che li criticavano iniziarono ad abbracciarli. I Simpson erano ora convenzionali e appropriati, comodi e familiari. Homer rappresentava lo spettatore medio, guidato dagli istinti (gola, accidia, lussuria), non-distruttivo, che vuole essere lasciato in pace e ama la sua famiglia, è alla mercé di lavoro e pressioni esterne. A spingere la serie su territori assurdi, fatti di non sequitur e divagazioni, fu (anche, soprattutto) Conan O’Brien, arrivato nel 1991 dopo l’esperienza come autore al Saturday Night Live. O’Brien forse più di tutti coniuga il senso enciclopedico de I Simpson: laureato ad Harvard con una tesi sui romanzi di William Faulkner e Flannery O’Connor, era un ragazzo allampanato, con un ciuffo color rame che pareva progettato da Frank Gehry, e una passione per la comicità bizzarra, fisica e allo stesso tempo concettuale. La sua permanenza nella serie sarà breve perché dopo un paio di anni verrà chiamato – a sorpresa – per condurre il Late Show che era stato di David Letterman. Tuttavia, il suo contributo cambiò il tono del cartone in maniera drastica.
Svilupperà con rapporto di sintonia con Bill Oakley e Josh Weinstein, anch’essi subentrati nel 1991 come innesti al gruppo di scrittura originale. I tre dimostrarono una passione per tutto ciò che era squisitamente demodé. Dalla loro passione comune per l’inglese antiquato emerse una nuova caratterizzazione del signor Burns – non a caso il personaggio preferito di O’Brien – che lo farà diventare un nugolo di riferimenti ottocenteschi. Ecco perché, quando risponde al telefono, il miliardario esclama “ahoy, ahoy!” (da noi tradotto con “olà-olà!”), il saluto che aveva proposto Alexander Graham Bell prima che prendesse piede l’“hello” di Thomas Edison. Fu Conan a proporre – e poi sceneggiare – Marge contro la monorotaia, un’idea che gli showrunner Mike Reiss e al Jean ritenevano troppo azzardata (un imbonitore di folle truffa la città convincendola a costruire una monorotaia che si rivelerà un abominio urbanistico nonché una minaccia per l’incolumità degli springfieldiani – dentro ci sono canzoni da musical, giravolte narrative e la comparsata di Leonard Nimoy). Era un’idea talmente fuori dai canoni che, al primo ritrovo collettivo a cui partecipò Conan, Jean gli aveva consigliato di tenerla come ultima. Il risultato, frutto come al solito della mente collettiva della writers’ room, convincerà gli autori ad adottare uno stile più surreale. Quell’equilibrio perfetto tra surrealismo e realismo, fantasia e pragmatismo, è ciò che anima la quarta stagione e che sarà ripreso dal seguente head writer, David Mirkin, nelle successive due stagioni (e poi da I Griffin, con l’aggiunta dello shock value).
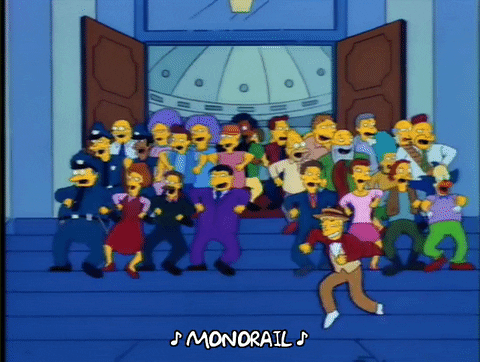
In questo periodo i personaggi arrivarono al massimo livello di complessità psicologica e sfaccettatura. La satira si fece acuminata e gli autori presero a levigare le sceneggiature con la cura di intagliatore, rifinendo ogni linea di dialogo, che doveva contenere prima una gag, poi due, facendo nascere l’ammonizione “Una battuta alla volta, per favore”. I Simpson sono anche una comicità intertestuale applicata alla tv, che si fonda su conoscenze pregresse per indurre il riso. La parodia, il pastiche, il metatesto, le citazioni erano un modo economico per veicolare informazioni e sentimenti, ricreare un’atmosfera – replicando anche lo stile visivo, nel caso di una citazione filmica. Gli omaggi specifici, a volte oscuri, si distinguevano dal piattume generico degli altri programmi, incapaci di andare oltre al titolo del giornale di ieri. Si sentiva, dietro a quel rimando, che chi l’aveva scritto era appassionato della materia. Aaron Sorkin raccontava che in West Wing si era tenuto lontano da tutti i riferimenti culturali, preferendo citare al massimo Gilbert e Sullivan, “perché se cominci a citare fatti della contemporaneità la gente comincia a pensare a quale momento storico si inserisce questo presidente fittizio che stiamo raccontando e si perde la magia”. Sorkin sapeva che la realtà avrebbe soffocato la finzione della serie, perché troppo ingombrante. I Simpson sono più grandi, hanno avuto la forza di tuffarsi nella contemporaneità, rischiando di cavalcare mode effimere, ma riuscendo quasi sempre a trovare una quadra. Anche se il riferimento invecchia, la battuta regge. Questo succede meno nelle stagioni recenti, dove la corsa a stare sul pezzo è diventata un esercizio di pigrizia per scrivere la punch line più scontata. Un buon esempio è l’episodio finale della quarta stagione, Lo show di Krusty viene cancellato, che frulla talmente tanti richiami (raffinate prese in giro delle mode hollywoodiane, mitragliata di guest star, parodie dei cartoni est-europei, citazioni ai programmi televisivi storici – tra cui l’episodio in cui Ed Sullivan chiese ai Doors di edulcorare un verso di Light My Fire) che anche quando svaniscono nella memoria degli spettatori futuri sono comunque supportati da un contesto che rende la scena godibile.
La forza dell’animazione
Essere un cartone animato ha fondamentalmente plasmato quello che la serie poteva raccontare. Se all’inizio le trame sono tutto sommato mondane e a misura di live action, nelle stagioni d’oro la serie prende confidenza con la sua identità e capisce che non deve per forza costringere i personaggi tra le mura di casa. I Simpson viaggiano, vivono avventure in luoghi fuori budget per ogni altra produzione. Si punta sulla comicità visiva, sui modi buffi in cui un’azione è animata o disegnata. E poi sono permesse concessioni uniche, come personaggi che tentano il suicidio, la rappresentazione disinvolta delle armi da fuoco, dei vizi, delle dipendenze, che in un disegno animato passano come parte del flusso. Inoltre, l’assenza delle risate registrate ha permesso, da una parte, più gag e, dall’altra, momenti intimi, assurdi, in cui non doveva scattare la risata. George Meyer parlava della “tirannia del pubblico presente in studio”: se un personaggio fa un’osservazione carica e gentile, la frase non provoca nessuna risata e quindi è tagliata, perché “agli spettatori non piace dover capire se una cosa è divertente o meno”.
Cercando di rifuggire la sciatteria e mettere nelle animazioni la stessa cura che mettevano nei testi, Brooks aveva chiamato Brad Bird a supervisionare i registi. Bird era uno spirito intransigente che aveva abbandonato la Disney per conflitti creativi, cercando di concretizzare i suoi progetti folli (come l’adattamento animato del fumetto The Spirit di Will Eisner). Non aveva riscosso grande successo, se si eccettua la chiamata di Steven Spielberg sulla serie antologica Amazing Stories: Bird aveva prodotto il corto animato Qua la zampa Doggie, il cui stile cinematografico aveva convinto Brooks e Simon a ingaggiarlo come consulente visivo per il salto della serie dai cortometraggi alle puntate di mezz’ora. “In pratica dirigevo i registi”, spiegò Bird. Fornendo correzioni e alternative agli storyboard, portò un vocabolario sofisticato che stava al passo con le sceneggiature erudite della serie. “Consideravo gli episodi film in miniatura e spingevo affinché gli storyboardisti si facessero influenzare da Kubrick e da Welles invece che disegnare la prima cosa che gli veniva in mente per rispettare le scadenze”. “Nel dubbio, abbassa la linea dell’orizzonte” diventò una delle frasi ricorrenti delle sue note, tanto che uno dei registi aveva appeso nel suo ufficio una caricatura di Bird mentre spinge una linea verso il basso.
Per una sorta di affinità elettiva con gli sceneggiatori, Bird stava adottando lo stesso approccio di Simon e soci: trattare la materia con la dignità che merita ogni buon lavoro, preferendo la precisione dei riferimenti e il respiro delle immagini cinematografiche all’approssimazione tipica della televisione.
Momenti trascurabili diventano piccole lezioni di comicità. Telespalla Bob che ne Il promontorio della paura rimane bloccato in un campo di rastrelli non è una gag, è una torta a strati: c’è la copertura, golosa e appariscente, che è il grado zero dell’umorismo, la gag fisica (su cui I Simpson avranno modo di ragionare ancora – vedete com’è quando si parla de I Simpson: ogni discorso meriterebbe un carotaggio ulteriore). Sotto le onde voluttuose, c’è un altro strato, più delicato, costituito dal fatto che Bob non fa altro che inciampare nei rastrelli in maniera assurda: il lamento gutturale dell’uomo sottintende disgusto verso se stesso ed esasperazione per le continue rastrellate in faccia, che rappresentano i fallimenti nel tentativo di portare a termine i suoi piani e uccidere Bart. Sarà diventato un criminale intellettualoide, un galeotto distinto, ma quei rastrelli stanno lì a ricordargli che, in fondo, Bob è ancora il clown seviziato da Krusty nel suo show. Bob è ostinato, stanco e disilluso, ma continua a camminare per raggiungere il suo scopo, pur sapendo che al prossimo passo ci sarà con molta probabilità un’altra rastrellata. C’è tutto un personaggio in una gag. Poi, alla fine, c’è una bagna che lascia un sentore lieve: la scenetta è un esempio di umorismo concettuale. Si espande per un lasso di tempo esagerato che fa andare a noia la battuta e poi la spinge ancora finché non torna a essere divertente.

Iper-ironia
C’è poi spesso l’uso di quella che Carl Matheson, in un intervento ne I Simpson e la filosofia, definisce “iper-ironia”. Una battuta su un argomento che sfrutta i pregiudizi e i bias dello spettatore e poi la rigira, diventando una frecciata a quest’ultimo: quando Homer dice “se avessi voluto vedere un giapponese sarei andato allo zoo” sta sfruttando preconcetti e vecchi stereotipi per farci pensare male; la successiva specificazione che allo zoo lavora un suo amico asiatico dà vita all’iper-ironia, a quello scombussolare le intenzioni per confondere lo spettatore tipico della post-ironia (di cui I Simpson, spiegava Francesco Pacifico, sono un esempio altrettanto valido). La spregiudicatezza nel motteggiare le tare dello spettatore ha portato a critiche sulla presunta natura discriminatoria della serie. Nel 2017 il comico di origini indiane Hari Kondabolu ha diretto The Problem with Apu, documentario-invettiva in cui criticava la rappresentazione degli indiani ne I Simpson. Suo obiettivo principale era Apu Nahasapeemapetilon, il gestore del Kwik-E-Mart (Jet Market da noi), attraverso cui gli autori della serie animata avrebbero promosso un’immagine stereotipata della cultura indiana, per molto tempo la sola visibile dal pubblico generalista. Kondabolu glissa sull’evidenza che Apu è stato spesso usato per parlare di immigrazione, pregiudizio, veganesimo o per rappresentare la cultura indiana in maniera, seppur approssimativa, priva delle molte esagerazioni che si sono viste altrove (uno per tutti, The Big Bang Theory). Non che non ci siano problemi di rappresentazione, specie nella caratterizzazione delle nazioni straniere come Brasile, Giappone e Italia, ma tutti i personaggi di contorno de I Simpson sono stereotipi: il poliziotto incapace, il sindaco intrallazzatore, la celebrità dissoluta, il vicino di casa perfetto, l’uomo d’affari senza scrupoli, che diventano trampolini per parlare di corruzione, divario sociale, immigrazione e religione.
I Simpson sapevano essere assurdi, eppure ricondurre quell’assurdità in dinamiche realistiche. Quando Homer ingaggiava una guerra con Barney sul miglior spazzaneve, gli autori stavano in realtà parlando della tediosità del lavoro, delle ambizioni personali. Lisa che diventa reginetta di bellezza è in realtà un racconto sull’alienazione dell’infanzia, i mali del consumismo e di una società estetizzante. Radio Bart affronta argomenti tetri come lo sfruttamento di tragedie locali o la facile retorica dei media: quando Bart inscena la caduta di un bambino in un pozzo Homer dichiara il bimbo un eroe, adducendo come motivo il fatto che sia caduto in un pozzo e non riesca a uscirne. Non erano i commenti tipici di un cartone animato, o di una serie televisiva comica.
Springfield è una qualsiasi periferia in grado di dotarsi alla bisogna di un porto, di una catena montuosa da scalare, ha una rivalità campagnola con Shelbyville ed è distante ma non troppo dalla metropoli – Capital City. E quando manca un pezzo del discorso lo si introduce o si prende in prestito una celebrità-simulacro. Così facendo, I Simpson arrivò a raccontare l’intera esperienza umana.
Se all’inizio Homer era il muro contro cui sbatte Bart, il reagente a cui reagire, il padre burbero e ingessato, ora diventava capace di finire in qualsiasi esageratissima avventura. Era stupido alla follia, ma amava anche alla follia. La continua discesa nella spirale di idiozia porta a uno degli episodi più radicali, Il nemico di Homer. La puntata mette i Simpson nella realtà e mostra allo spettatore cosa succederebbe se uno di noi avesse a che fare con Homer. Punto di ingresso è Frank Grimes, un personaggio nuovo che ha lottato per ogni cosa ottenuta nella vita: abbandonato dai genitori, da bambino ha lavorato come fattorino, per poi laurearsi in fisica nucleare per corrispondenza. Il signor Burns, commosso da un servizio che il tg ha dedicato a Grimes, lo assume alla centrale. Solerte, rigoroso e preciso, Grimes si scontra con il lassismo di Homer e lo prende subito in antipatia. Homer cerca di rimediare invitandolo a cena, ma Grimes si inacidisce ancora di più di fronte alle gioie e alle fortune che il collega sfoggia con noncuranza (una bella casa, una famiglia amorevole, una vita piena e avventurosa fatta di viaggi nello spazio e vittorie ai Grammy). Tentando di mettere alla berlina la dabbenaggine di Homer con gli altri impiegati della centrale, che non hanno la minima reazione, avendo ormai preso in amicizia Homer ed essendosi abituati al suo comportamento, Grimes lo iscrive a un concorso per bambini. Quando Homer non solo vince il concorso ma è persino applaudito dall’intera centrale, Grimes impazzisce e inizia a comportarsi come lui, ingurgitando ciambelle ed evitando le basilari norme di sicurezza. Ma proprio toccando dei cavi scoperti resta fulminato e muore. “L’errore imperdonabile di Grimes fu di sottolineare tutto ciò che era sbagliato e stupido di quel mondo”, disse George Meyer. “E le persone che fan così tendono a diventare martiri. Abbiamo provato una gioia un po’ sadica nel vederlo crollare”.

Grimes palesa al pubblico come il capofamiglia Simpson sia incompetente, menefreghista, distruttivo, ma benedetto dalla buona sorte. Eppure, come spiegano i colleghi di Homer, non c’è nulla di malizioso in quello che fa, perché ogni sua azione parte da un bisogno primario certo rozzo, e che andrebbe irretito da un’intelligenza vacante, ma fondamentalmente innocuo, perfino buono. Quando infatti Marge prova a motivarlo a fare di più, a comportarsi professionalmente, per sdebitarsi delle fortune che ha avuto, Homer si impegna in tal senso, finendo per sbagliare un’altra volta. Il nemico di Homer fu molto voluto dagli allora showrunner Bill Oakley e Josh Weinstein. Oakley e Weinstein erano stati i primi aggiunti al gruppo originale di autori, subito prima di O’Brien. E spinsero per famiglia, commenti meta sulla serie, come Il nemico di Homer o Lo show di Grattachecca e Fichetto e Pucci, una puntata in cui l’arrivo di un nuovo personaggio nel cartone preferito di Bart e Lisa offre lo spunto per ragionare su come si mantiene viva e vitale una serie di lungo corso. La sitcom era, in un certo senso, molto personale. A ispirare le storie non c’erano (solo) i ricordi d’infanzia o i problemi da adulti, ma anche le problematiche riflessive di lavorare a una serie che stava per compiere dieci anni.
Lenta discesa
Quasi prevedendo che insistere sull’assurdità delle situazioni avrebbe potuto condurre la serie verso una dimensione gratuita, scollata da qualsiasi credibilità, Oakley e Weinstein hanno stimolato un ritorno alle storie familiari e a episodi con un forte nucleo emotivo, pur giocando con le forme narrative (come in 22 cortometraggi di Springfield o La bacheca della serie dalla serie “I Simpson”), grazie all’assunzione di autori con inclinazioni più strutturali, come Ken Keeler, David X. Cohen e altri laureati in chimica, legge o matematica. I due si scontrarono però con il vuoto che nessun personaggio ex-novo avrebbe potuto colmare: lo spaesamento adolescenziale e post-adolescenziale, che Bart e Lisa non potevano raccontare, nonostante Oakley e Weinstein abbiano provato a stiracchiare i loro caratteri per far toccare loro anche tematiche da giovani adulti (in episodi come L’appuntamento di Lisa col teppistello, La guerra segreta di Lisa Simpson, Bart si vende l’anima, Lisa la vegetariana o Un mare di amici).
È con l’arrivo di Al Jean nella dodicesima stagione che si assiste al tramonto della serie, almeno rispetto agli altissimi livelli iniziali. Quando si parla del periodo d’oro (o perlomeno buono) de I Simpson, i più generosi si fermano infatti alla prima stagione della gestione Jean. Difficile trovare qualcuno che si spinga oltre. Dalla tredicesima in poi, le cose buone che si possono dire de I Simpson si limitano a qualche episodio sporadico, o al massimo al film. Al Jean arrivò dopo tre annate in cui Mike Scully aveva spinto troppo oltre la pazzia della serie e aveva ceduto alla pigrizia di episodi più preoccupati delle gag che della storia. Episodi come Missionario impossibile o Guai da un trilione di dollari non sono assurdi e credibili, ma soltanto assurdi. La miscela non era più calibrata. Gli argomenti non erano più trattati di sponda, ma affrontati di petto, in maniera un po’ goffa e con la mano pesante. Non c’erano più personaggi o maschere che incarnavano una serie di ideologie, ma direttamente quelle ideologie.
Sembrava – e sembrerà – che ci si limitasse ad animare la prima bozza delle sceneggiature. La sensazione è confermata dai resoconti che descrivono l’atmosfera più da industria che da bottega della gestione Jean. Si sfornano episodi a ciclo continuo e ogni tanto ne esce uno buono. Si è venuta a creare un’atmosfera più industriale, meno artigianale. Il fatto stesso che la serie vada in onda da trent’anni è certamente una concausa del declino qualitativo (e I Simpson non hanno la flessibilità narrativa di altre produzioni seriali ben più longeve come i fumetti di supereroi o le soap opera). Sono diventati un cartone non abbastanza inclusivo, non abbastanza femminista, un prodotto che andava bene per tempi più semplici e meno suscettibili. Ed ecco che allora però vale davvero la pena parlare de I Simpson, per ricordarci che non sono sempre stati un fenomeno dai numeri altisonanti (i quasi settecento episodi! le trenta e passa stagioni!) ma un’opera profondissima, scandagliabile in lungo e in largo, buffa e seria, da adulti e per bambini, buona per una risata o per una tesi di laurea.
Andrea Fiamma
Scrive (soprattutto) di fumetti, cinema e tv su Fumettologica, Rivista Studio e The Comics Journal.
Vedi tutti gli articoli di Andrea Fiamma


