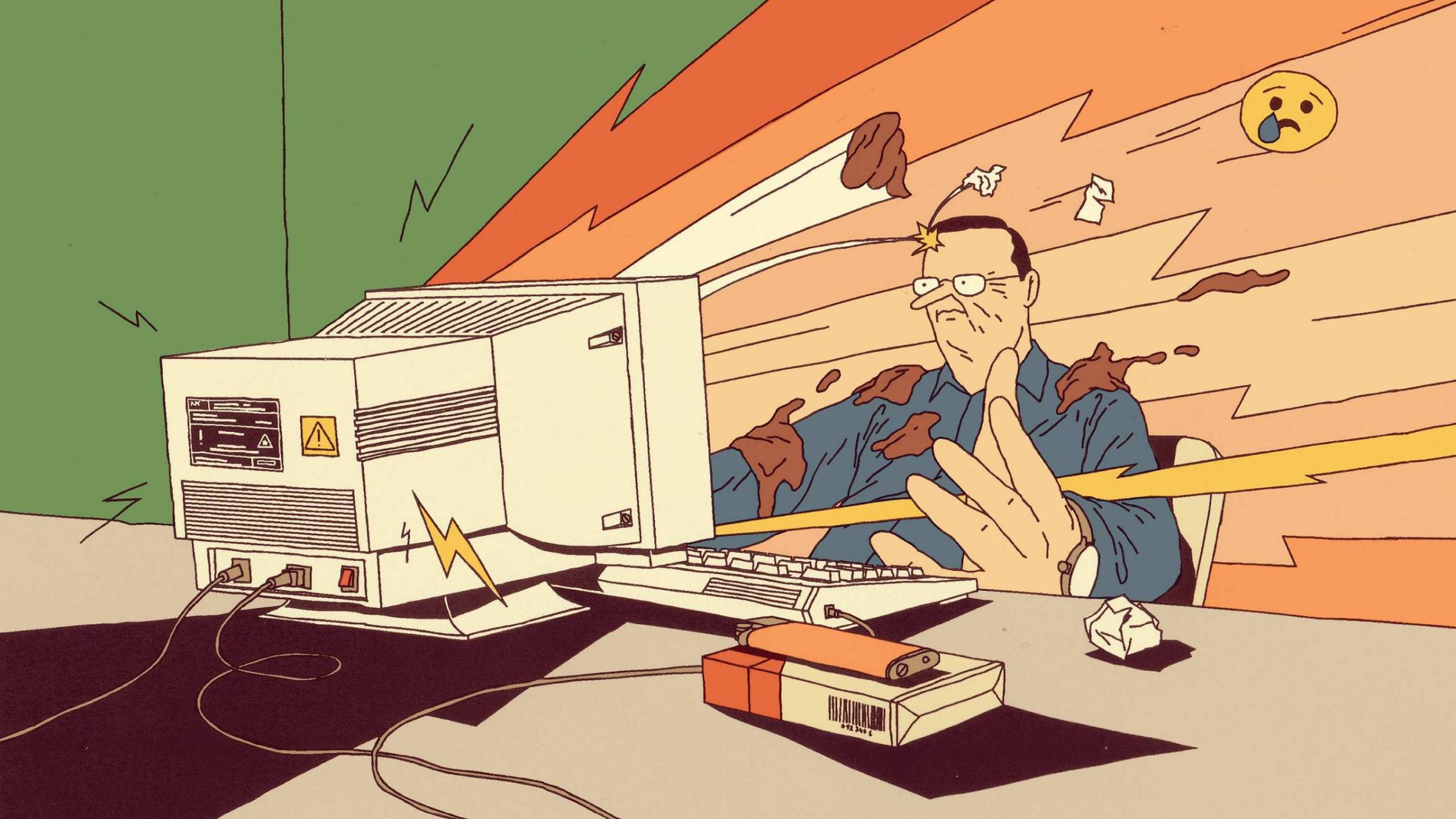
Gli spazi del web e dei social sono spesso attraversati da ondate polemiche, rabbie improvvise e virali. A guardare più da vicino, ci sono elementi ricorrenti, tutt’altro che casuali. E ci caschiamo tutti.
Nell’ambito del dibattito sui linciaggi online, si tende a dire che le cause d’indignazione siano preesistenti a internet e ai social media e che questi abbiano solo accelerato il processo, dando un palco e una platea a chi prima doveva accontentarsi di inviare un fax. Ma finora pochi giornalisti e scrittori hanno indagato in cosa consista tale accelerazione, che in realtà è studiata molto più approfonditamente nel social media marketing: si tratta in effetti di capire in che modo alcuni messaggi possono diventare virali rispetto ad altri e così influenzare le masse di utenti che li ricevono. Un ruolo centrale è giocato dai trigger, quegli elementi che appunto contribuiscono alla viralità di un contenuto online ma che portano anche, in particolari condizioni, alla formazione di shitstorm.
Alle origini del trigger
Bisogna ricordare che fenomeni non del tutto chiari muovono le nostre azioni su internet e sui social media; ne prendiamo coscienza solo quando qualcuno li decodifica e gli dà un nome che diventa di uso comune. Trigger è una di quelle parole già diffuse e usate nelle community online ma non è ancora ben chiaro a tutti cosa significhi davvero, infatti molto spesso è usata in maniera impropria. Il sostantivo arriva dall’inglese e significa “grilletto, innesco”, perlopiù usato in ambiti specifici come quello medico per indicare “un punto anatomico ipereccitabile” o in psicologia dove è “qualcosa che evoca il ricordo di un evento traumatico o negativo”. Su internet l’uso del termine risale al 1996, quando su siti web e community femministe vennero introdotti i “trigger warning”, da inserire in thread che trattavano argomenti come stupri e abusi, che potevano essere potenzialmente “triggering”, rievocare brutti ricordi a utenti segnati da quelle esperienze. Lo scopo era creare dei safe space, come era già successo nei campus delle università americane. C’è chi ha da subito considerato i “trigger warning” come eccessivi e contrari alla libertà d’espressione, un concetto che a quel tempo (e in larga parte ancora oggi) era considerato sacro e da difendere a ogni costo, mentre i “triggerati” erano criticati in quanto utenti che rispondevano a un input in maniera eccessiva.
In ogni caso, questo spiega solo in parte cosa sia un trigger e cosa voglia dire essere triggerati. Intanto, tutti gli utenti sono soggetti a trigger e a tutti è capitato in un modo o nell’altro di essere stati triggerati. Mentre siamo distesi sul divano, quando ci prendiamo una pausa a lavoro, in attesa dell’autobus e in tutti quei tempi morti che la pandemia ci ha regalato in abbondanza, prendiamo lo smartphone e iniziamo a scrollare velocemente i nostri feed con una soglia dell’attenzione molto bassa, alla ricerca di content (il post di un amico che racconta i fatti suoi, il video di una ricetta, un meme) che ci intrattengano per qualche secondo, per poi passare a quello successivo. Quando la nostra attenzione si posa su un contenuto che ci ha colpito abbastanza, reagiamo con un’interazione (nella maggioranza dei casi con un like, talvolta con un commento o uno share). Vuol dire che in quel content c’era un trigger, che non solo ha catturato la nostra attenzione ma ha innescato una reazione. Gli algoritmi dei vari social premiano, cioè danno più reach (ossia più pubblico), a post del genere. Lo fanno con una logica del tutto neutrale che è quella della matematica: dove vedono che c’è maggiore attenzione, intervengono aumentando la possibilità che quel post (tweet, video…) sia visto su più feed, aumentando a sua volta le possibilità di interazioni. Da questo punto di vista, il trigger non è necessariamente negativo: infatti, può benissimo essere qualcosa che ci piace e apprezziamo come una musica accattivante, un testo ben scritto, la foto di una pizza, di un gatto o di una bella ragazza.
Quando la nostra attenzione si posa su un contenuto che ci ha colpito abbastanza, reagiamo con un’interazione (nella maggioranza dei casi con un like, talvolta con un commento o uno share). Vuol dire che in quel content c’era un trigger, che non solo ha catturato la nostra attenzione ma ha innescato una reazione. Gli algoritmi dei vari social premiano, cioè danno più pubblico, a post del genere.
Ma i trigger, un po’ come le particelle degli atomi, possono essere sia positivi che negativi. I primi causano reazioni innescate da emozioni come gioia, divertimento, senso di appagamento; i secondi causano reazioni innescate da emozioni come rabbia, stizza, disgusto, indignazione. Chi lavora nel marketing cerca ovviamente di creare contenuti con trigger positivi. Ciononostante, sui social media sono i trigger negativi che attraggono maggiormente l’attenzione degli utenti (una cosa che i giornalisti nel loro ambito sanno da sempre: le cattive notizie catturano di più l’attenzione rispetto a quelle buone). Il trigger però è materiale instabile: si dà per scontato che un contenuto generi automaticamente un tipo di reazione. Non è sempre così: l’effetto può variare a seconda di chi lo riceve. Lo stesso trigger può fare due effetti diversi a diverse community che lo ricevono: una può essere triggerata positivamente, un’altra negativamente, e in mezzo ci possono essere persone che rimangono totalmente indifferenti. Se un contenuto ha dei trigger che contemporaneamente creano un alto tasso di interazioni con sentiment sia positivo che negativo, siamo di fronte a un contenuto che polarizza. E dove c’è polarizzazione, c’è viralità; dove c’è viralità, c’è fraintendimento tra community; dove c’è fraintendimento ci sono le shitstorm.
Teoria e pratica del trigger online
Spiegare cos’è un trigger online non è una cosa semplice: è un fenomeno nuovo che tra l’altro richiede un abbondante utilizzo di termini dal marketing (che già di loro triggerano e non in senso positivo). E questo probabilmente è il motivo per cui sui social media “trigger” è usato in maniera errata, pensandolo nella sua accezione medico-psichiatrica, cioè come qualcosa che può portare a galla ricordi traumatici. Molte community ormai hanno interiorizzato l’idea che i trigger andrebbero cancellati per risolvere tutti i conflitti online, motivo per cui si usano i “trigger warning”. Forse qualcuno avrà già visto post, soprattutto su Twitter e TikTok, contenenti in apertura la seguente nomenclatura:
tw // cibo
cw // cibo
Sono codici che si trovano all’interno di autoregolamentazioni che si sono date alcune community (perlopiù standom frequentate da giovanissimi) ma che stanno prendendo piede anche al di fuori. “tw” sta proprio per trigger warning, mentre “cw” è un content warning: il primo è ritenuto più grave, nel senso che la persona che lo vede può essere portata a “farsi male fisicamente”, mentre un content warning può solo urtare, far stizzire e arrabbiare. Le parole-trigger più usate di solito si riferiscono a: stupro, cibo, DCA (disturbo del comportamento alimentare), bulimia, anoressia, pedofilia, transfobia. Gli spazi presenti nella nomenclatura hanno un senso: danno il tempo alla persona di “prepararsi”, prima di leggere la parola che triggera. Inoltre, alcuni social network permettono di escludere delle parole chiave, per cui se non si vogliono vedere determinati argomenti o parole, si inserisce ad esempio “tw // cibo” e tutti i post con questa dicitura sono automaticamente oscurati. Questa nomenclatura però fa confusione tra “trigger” e “content”. Inoltre, il significato stesso di trigger è frainteso perché ricondotto all’accezione medica, senza tener conto che i social media ne hanno modificato il senso, creando dal nulla un fenomeno che prima non esisteva, o meglio esisteva ma in forma abbozzata e larvale.
I trigger toccano corde che neanche sapevamo di avere, per niente razionali, capaci di sollevare ondate di indignazione e linciaggi su questioni apparentemente ridicole, mentre rimaniamo del tutto indifferenti su altre questioni che veramente dovrebbero indignarci ma che ci vengono raccontate in un modo che “non triggera”. Il problema è che l’elenco dei trigger è soggettivo e potenzialmente infinito, non solo se lo consideriamo da un punto di vista individuale ma anche da un punto di vista collettivo. Inoltre, sui social media i trigger si combinano tra di loro in maniera casuale e non logica: se la strada è quella di disinnescarli cancellandoli, allora si fa prima a spegnere direttamente internet. Guardando a una breve lista di shitstorm di questi ultimi anni (che viene da un database molto più ampio) ci si può fare un’idea di cosa siano i trigger e del perché è praticamente impossibile disinnescare alcunché.
| Anno | Brand | Trigger 1 | Trigger 2 |
| 2013 | Barilla | Cibo | LGBTQI+ |
| 2015 | Melegatti | Cibo | LGBTQI+ |
| 2018 | Uliveto | Cibo | Razzismo e sessismo |
| 2020 | Pasta Molisana | Cibo | Fascismo |
| 2017 | Pandora | Fashion | Sessismo |
| 2018 | H&M | Fashion | Razzismo |
| 2018 | Prada | Fashion | Razzismo |
| 2018 | D&G | Fashion | Razzismo |
Come si può notare, una categoria di trigger risponde effettivamente a quello per cui i trigger warning sono nati: argomenti da dibattito politico, estremamente importanti e complessi, quali il razzismo, il sessismo, le discriminazioni religiose e di genere, l’antisemitismo ma anche i problemi legati alla salute mentale come i disordini alimentari. Ma attenzione perché questi temi da soli non sono dei trigger capaci di generare shitstorm: ci sono associazioni che si occupano solo di questo, fanno articoli continuamente, ne parlano in maniera seria, puntuale, professionale. È molto probabile che questi temi in contesti del genere siano perlopiù seguiti dalle nicchie a cui interessa, percepiti dall’utente medio che scorre con scarsa attenzione il suo feed, un po’ noiosi (benché importanti).
I trigger toccano corde che neanche sapevamo di avere, per niente razionali, capaci di sollevare ondate di indignazione e linciaggi su questioni apparentemente ridicole, mentre rimaniamo indifferenti su altre questioni che veramente dovrebbero indignarci.
Spesso ci si domanda: perché si scatena un’indignazione esagerata per una scritta sul retro di un pacco di pasta (il caso Molisana) mentre per una news su un naufragio di migranti non si indigna nessuno? Perché i casi di cronaca di morti sul lavoro non suscitano la stessa mole di reazioni infuocate di Fedez al Concertone? A queste domande di solito c’è una controparte che risponde: “così si fa del benaltrismo” o “chi è che decide che deve esserci una classifica per cosa dobbiamo indignarci?”. Di nuovo, la risposta è ben più complicata e molto più algoritmica di come la si pensa di solito. Se il “content” contiene un certo numero di trigger particolarmente instabili ma funzionali, e poi è propagato online da influencer e media in modo che raggiunga più utenti e quindi “bolle” possibili (aumentando esponenzialmente la possibilità di fraintendimento e polarizzazione), solo in questo caso la shitstorm ha possibilità di verificarsi. Altrimenti non succede niente.
Indignazione professionale
La novità è questa. Un fenomeno online, che una logica novecentesca fatica a decifrare, può essere tradotto in una formula piuttosto semplice, quasi fosse un fenomeno naturale che segue una legge della fisica: (Trigger1 + Trigger2 + Trigger3) * Propagazione = Shitstorm.
Il linciaggio online nei confronti di D&G del 2018 rende molto chiara questa formula. In quel caso il content era lo spot con una modella cinese (trigger1) che mangiava una pizza (trigger2). Perché una modella è un trigger? Perché in generale le donne, soprattutto se di bell’aspetto, aumentano l’attenzione verso un contenuto. Lo stesso dicasi per la pizza, e in generale per il cibo. Anzi la pizza è universalmente riconosciuta come uno di quei contenuti che “vince su internet”. Ovviamente è amatissima anche nella realtà (così come le ragazze di bell’aspetto): ma sui social media diventa un elemento, fortemente simbolico, in grado di aumentare il successo di un contenuto, qualunque sia questo contenuto. Non è un caso se la teoria complottistica che ha avuto più successo su internet, su cui poi è stato fondato Qanon, si chiama proprio Pizzagate: è buffo se si ragiona con una logica novecentesca; è del tutto normale se si ragiona secondo le logiche degli algoritmi. Tornando al caso D&G, un altro trigger si rintraccia nella figura di Stefano Gabbana. Ci sono personalità online che a prescindere da quello che facciano o dicano hanno il potere di polarizzare le masse. Nomi ricorrenti online che basta citare per scatenare il putiferio: Chiara Ferragni, Andrea Scanzi, Fabio Volo, Laura Boldrini, Burioni, Marchionne (e tutti quei nomi che in generale si ritrovano nelle teorie dei complotti), Wanda Nara e Diletta Leotta, tra i politici ovviamente Matteo Renzi e Matteo Salvini.
Si potrebbe andare ad indagare perché ognuno di loro è diventato un trigger umano, ma generalizzando alcuni lo sono per dono divino (Ferragni) e altri per duro lavoro (Salvini, Fedez). Comunque, anche Stefano Gabbana è una di quelle figure che, per una serie di motivi, polarizza e quindi triggera. Per quanto riguarda il fattore P, cioè la propagazione, nel caso D&G tutto è partito dal famoso account Diet Prada, uno di quei profili (possono essere anche pagine Facebook, account su Twitter) che giornalmente suggeriscono su cosa dovremmo indignarci, soprattutto nell’ambito della moda. In Italia ne esistono anche di altri, per esempio Trash Italiano, da cui è scaturito il linciaggio nei confronti della trasmissione Detto fatto, la pagina del “Signor Distruggere” o “Io, professione mitomane” (ora chiusa): tutti luoghi virtuali frequentatissimi da utenti che attendono con impazienza che qualcosa li triggeri.
Sono account che alimentano uno stato di paranoia perenne, di disgusto preventivo verso dei potenziali idioti che potrebbero dire o fare qualcosa che non andrebbe detta o fatta. La reazione indignata è un modo per scaricare questo stato di paranoia perenne: trovando il modo di sottolineare l’errore (o la fregatura), fare la battuta sapida o lo status indignato, prendersela con il social media manager di turno. Ovviamente, la propagazione della shitstorm aumenta esponenzialmente se il tutto parte da account che già hanno un gran numero di follower, da influencer e vip già in vista, con una copertura che va i oltre i social e diventa crossmediale, coinvolgendo i media tradizionali. Ma il contenuto di partenza può anche provenire da account con pochi follower o da utenti sconosciuti: la shitstorm avviene solo se c’è anche un account-influencer che si fa carico di propagarla. Per chiudere con il caso D&G, bisogna ricordare che un altro trigger era effettivamente “il razzismo” (nella fattispecie nei confronti degli asiatici). Lo stesso tipo di esercizio si può fare con altre shitstorm e di volta in volta scoprire trigger più o meno curiosi, che ci passano davanti ogni giorno senza che neanche li percepiamo come tali mentre fanno il loro lavoro.
Tutto questo dovrebbe far capire quanto sia facile manipolare gli utenti online, conquistare la loro attenzione e il loro tempo, senza che questi ne siano veramente coscienti. È una cosa che l’industria degli influencer fa sistematicamente. Intendiamoci: intrattenerci è il loro lavoro, così come noi seguiamo gli influencer per farci intrattenere. Dovremmo essere più coscienti del fatto che l’umanità nella sua quasi interezza, da qualche decennio, vive contemporaneamente due vite parallele: una nella realtà e un’altra sui social. Li amiamo, altrimenti non ci staremmo tutto quel tempo, perché ci danno un appagamento morboso, soddisfano il bisogno di avere un palcoscenico, di poter dire comunque la nostra con il piacere di essere ascoltati e ricevere like. Li odiamo, e lo diciamo continuamente, perché ci fanno perdere tempo, sentire sopraffatti e dipendenti da incomprensibili algoritmi. Un piccolo fatto che nella realtà è trascurabile e insignificante, online può scatenare una guerra di opinioni polarizzate. I social vivono in rapporto simbiotico con la realtà, distorcendola, accelerandola, restituendola in una forma del tutto inedita, talvolta eccitante, a volte incomprensibile, altre volte con ripercussioni gravi per chi ci finisce in mezzo.
Laura Fontana
Lavora da più di dieci anni come esperta di comunicazione digitale per brand nazionali e internazionali. Si occupa di società digitale e analisi del web. Scrive di internet e pop culture, influencer e creator economy su Rivista Studio e altri magazine.
Vedi tutti gli articoli di Laura FontanaLeggi anche

Celebrità digitale
Essere Royal Family ai tempi dei social media

Social media
Beauty inferno, belle impossibili

