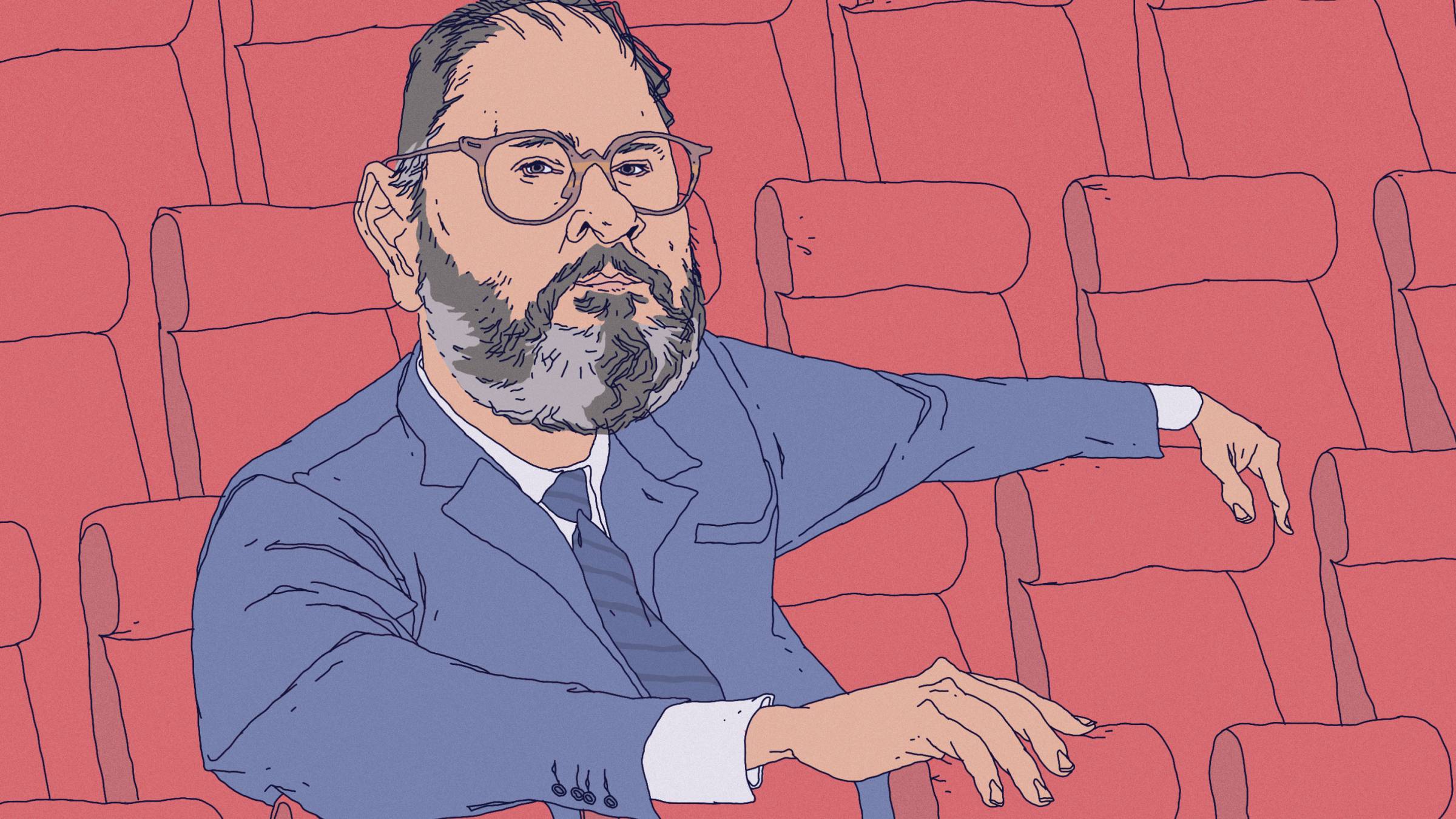
Tra i trionfatori italiani agli ultimi Oscar c’è un distributore italiano, I Wonder, e il professionista che ha dato vita al progetto. Che qui ci offre un punto di vista originale sugli sviluppi del cinema oggi.
Andrea Romeo, classe ’74, oltre che ex critico e giornalista, è una di quelle persone la cui presenza, pur dietro le quinte, è più pervasiva di quanto si pensa. Probabilmente molti titoli cinematografici che avete amato in questi anni – e per cui avete fatto il tifo agli Oscar – sono distribuiti dalla sua I Wonder Pictures. Dopo avere fondato il primo festival italiano dedicato all’animazione, il Future Film Festival, ha poi creato il pregevole Biografilm e dal 2013 porta nelle sale italiane, con I Wonder, un mix equilibrato tra cinema impegnato e di intrattenimento o, meglio ancora, un cinema d’essai accessibile e un cinema commerciale dignitoso, ossia ciò che il buon cinema dovrebbe essere. Dai genocidi raccontati da Joshua Oppenheimer al simpatico divertissement di Palm Springs, passando per lo strano – in senso buono – Frank a perle documentaristiche come Sugar Man e a Lo and Behold del maestro Werner Herzog. Dopo la pioggia di Oscar vinti con Everything Everywhere All At Once (EEAAO) e The Whale, I Wonder distribuirà Beau ha paura di Ari Aster (regista di Midsommar), con Joaquin Phoenix. Ho raggiunto telefonicamente Romeo per sapere il futuro di I Wonder, cosa si nasconde nel suo metodo di selezione e perché non si parla mai di chi lavora nel mondo dell’industria cinematografica.
Un tempo nella moda il demiurgo era lo stilista, poi è stata l’epoca delle top model e infine delle fashion blogger. Sta cambiando il paradigma anche nel cinema? Saranno i distributori a dettare le mode?
Secondo me è il pubblico a dettare le mode e noi dobbiamo intercettare, più che le mode, i trend, gli elementi di curiosità e interesse. Il nostro lavoro non è quello di promuovere o proporre, ma di riuscire a intercettare gli artisti che riescono a capire ciò che il pubblico vuole in questo momento.
E com’è possibile, dato che il pubblico è ormai frammentato, e questa divisione si è accentuata nell’on demand?
Sappiamo che riusciamo a trovare gli artisti giusti e sentiamo che è così quando il pubblico risponde alle nostre proposte. Riusciamo a cogliere i trend continuando a essere curiosi e appassionati della nostra materia, che è il cinema, e cercando di essere aperti al nuovo e alla qualità. In qualche modo, il resto viene da sé. Noi non abbiamo preso i film che pensavamo avrebbero vinto gli Oscar, abbiamo preso i film che ci interessavano e che pensavamo di poter esprimere al meglio con il nostro lavoro; poi questi hanno avuto la fortuna di vincere, ma l’importante, per me, non è inseguire il risultato ma capire che cosa oggi aiuta lo spettatore a vivere e a comprendere meglio il mondo che vive e lo spirito del tempo.
La politica editoriale di I Wonder sembra prendere diverse fasce di pubblico in modo trasversale, dalla generazione X alla Z, un equilibrio tra intrattenimento e cinema d’essai. C’è il rischio, crescendo, di perdere questi criteri di selezione?
Il rischio c’è sempre e dobbiamo partire – o almeno cerchiamo di tenerlo come punto centrale – da ciò che vogliamo vedere come spettatori, da cosa ci interessa come operatori di settore senza cessare di fare scaffale: cercare di trovare cose davvero originali. Ogni film dice una parola che in qualche modo compone una frase, un pensiero di quello vogliamo esprimere noi.
Perché in Italia non c’è una copertura sufficiente per quanto riguarda l’industry?
Perché in qualche modo l’industry resta sempre misteriosa, si pensa che ci sia qualcosa di un po’ magico ed esoterico nel nostro lavoro che in realtà semplicemente somiglia a tante altre industry. Raccontare questo settore è interessante, l’industry potrebbe e dovrebbe essere raccontata come parte del processo creativo. Siamo arrivati a capire che dovevamo partire dalla nostra identità e definirci come ci sentiamo, ossia editori cinematografici, qualcosa di più completo e figurativo rispetto a dire distributori.
Come per l’ultimo film di Olivier Assayas, adattando il titolo: Non fiction in originale, qui Il gioco delle coppie.
Quell’aspetto, avere la fiducia di un autore come Olivier Assayas, e del distributore internazionale, ci ha fatto fare tante cose pazzesche, oltre cambiare il titolo e l’identità del poster e del trailer abbiamo capito che quello era un titolo che poteva attirare un grande pubblico a Natale (due settimane prima dell’uscita in Francia). Ed è un aspetto affascinante, e una responsabilità, del lavoro di editori cinematografici.
“L’industry potrebbe e dovrebbe essere raccontata come parte del processo creativo. Siamo arrivati a capire che dovevamo partire dalla nostra identità e definirci come ci sentiamo, ossia editori cinematografici, qualcosa di più completo e figurativo rispetto a dire distributori”.
A volte si tende a maltrattare il pubblico, e chi frequenta i festival sa che solo una piccolissima percentuale sarà distribuita in sala (e in modo poco capillare). Mancano i distributori coraggiosi o mancano i fondi?
Sicuramente è giusto supportare le aziende editoriali che vogliono dare al pubblico prodotti difficili commercialmente, ed è per questo che cerchiamo, proteggiamo e valorizziamo la distribuzione di film europei, d’essai, per dare un supporto ai distributori indipendenti che ci sono, con punti di vista diversi e interessanti. Al contempo, non bisogna neanche farsi ossessionare dall’idea che tutti i film debbano raggiungere tutto il pubblico. Non tutti i film possono esprimersi oltre i circuiti festivalieri. In fondo il festival ha anche la funzione di intercettare il pubblico potenziale di una determinata opera. Per questo è importante che ci siano tanti festival, in modo che questi film abbiano la maggior visibilità possibile.
Cos’è cambiato nel cinema in questi vent’anni?
Credo che in questo secolo il punto di vista sia diventato fondamentale, e quindi un punto di vista personale che spesso diventa biografico – ma non necessariamente diventa un genere – può essere uno sguardo tra i tanti possibili nei confronti di un’epoca, un periodo o un avvenimento. Questo approccio coinvolge di più lo spettatore rispetto al racconto oggettivo di quest’epoca, quell’avvenimento o un dato periodo. Forse è questa la modalità con cui la narrazione del nuovo millennio affronta il racconto: con uno sguardo personale e con un punto di vista sulle cose.
Quali sono i progetti o le nuove sfide di I Wonder dopo la pioggia di Oscar?
Per citare Chiara Ferragni, direi “pensati libera”. Vogliamo, a maggior ragione perché abbiamo fatto due film che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone, rimettere tutto in discussione e capire cosa oggi merita la nostra attenzione e quali sono le storie che vale la pena raccontare.
EAAO sembra un film pensato per la generazione TikTok, ma come The Whale è una riflessione sulla condizione umana o, perlomeno, tasta il polso di un pubblico isolato nel pieno di una grande depressione di cui non è neanche consapevole di soffrire. È un caso che questi due film siano stati tra i più amati della stagione 2022-2023?
Non è un caso, perché sono due film che hanno la grande capacità di smuovere lo spettatore, di andare in profondità nella riflessione intima che durante il tempo della visione ognuno, consapevolmente o meno, mette in atto rispetto a se stesso come spettatore e come persona. Anche questo è un elemento che ha toccato l’attenzione dei professionisti che hanno celebrato questi film portandoli agli Academy.
“Non bisogna neanche farsi ossessionare dall’idea che tutti i film debbano raggiungere tutto il pubblico. Non tutti i film possono esprimersi oltre i circuiti festivalieri. In fondo il festival ha anche la funzione di intercettare il pubblico potenziale di una determinata opera. Per questo è importante che ci siano tanti festival, in modo che questi film abbiano la maggior visibilità possibile”.
Impressionante che queste due opere siano riuscite a colpire le nuove generazioni con una soglia di attenzione bassissima.
Le nuove generazioni hanno in realtà, per me e per come posso leggerle, una capacità di focalizzazione, di concentrazione, di sapere tutto quello che gli interessa superiore a quelle precedenti. Quindi c’è un atteggiamento che possiamo considerare onnivoro o eccessivo rispetto alla quantità di stimoli che arrivano dallo scorrere continuamente al cellulare.
Con un pubblico sempre più frammentato, il cinema fa sentire meno soli? I film sono i nostri migliori amici?
Avere bisogno di un film è un elemento importante, cioè sentire che di un film c’è bisogno, che il film dice una cosa importante. Mi è successo a Berlino, alla Berlinale, con un film che si chiama 20.000 specie di api, che ha vinto l’Orso d’argento per la migliore interpretazione. Sono entrato con curiosità senza immaginare che stavo incontrando un film importante e che quell’opera mi dava accesso a un punto di vista sulla contemporaneità che avrei voluto portare con me e fare mio, acquisendolo e distribuendolo poi l’anno prossimo da noi in Italia. Quindi sì, i film come diceva Fassbinder cambiano la testa, liberano la testa… perché un tempo qualcuno che andava a vedere il Nido del cuculo aveva della pazzia e della gestione sociale della pazzia un’idea, e al termine del film questa era totalmente cambiata. Il pubblico immenso che ha visto Philadelphia aveva una idea dell’Hiv e della sieropositività che grazie all’esperienza del film è cambiata… sì, i film sono i nostri migliori amici per cambiare il nostro modo di pensare.
Maria Eleonora C. Mollard
Nata in Argentina arriva in Italia nel 1990 per subire e assorbire tutta la cultura pop di un grande decennio. A quattro anni vede Freaks ed è subito epifania col cinema. Passa l’adolescenza a disegnare fumetti, guardare film e serie tv. Viaggia col padre, divora musica durante le traversate nel Mediterraneo sviluppando così un atteggiamento ossessivo-compulsivo verso le sue passioni. Affronta la guerra civile del precariato scrivendo articoli, girando cortometraggi e fantasticando sulla generazione in declino di cui fa parte.
Vedi tutti gli articoli di Maria Eleonora C. Mollard


