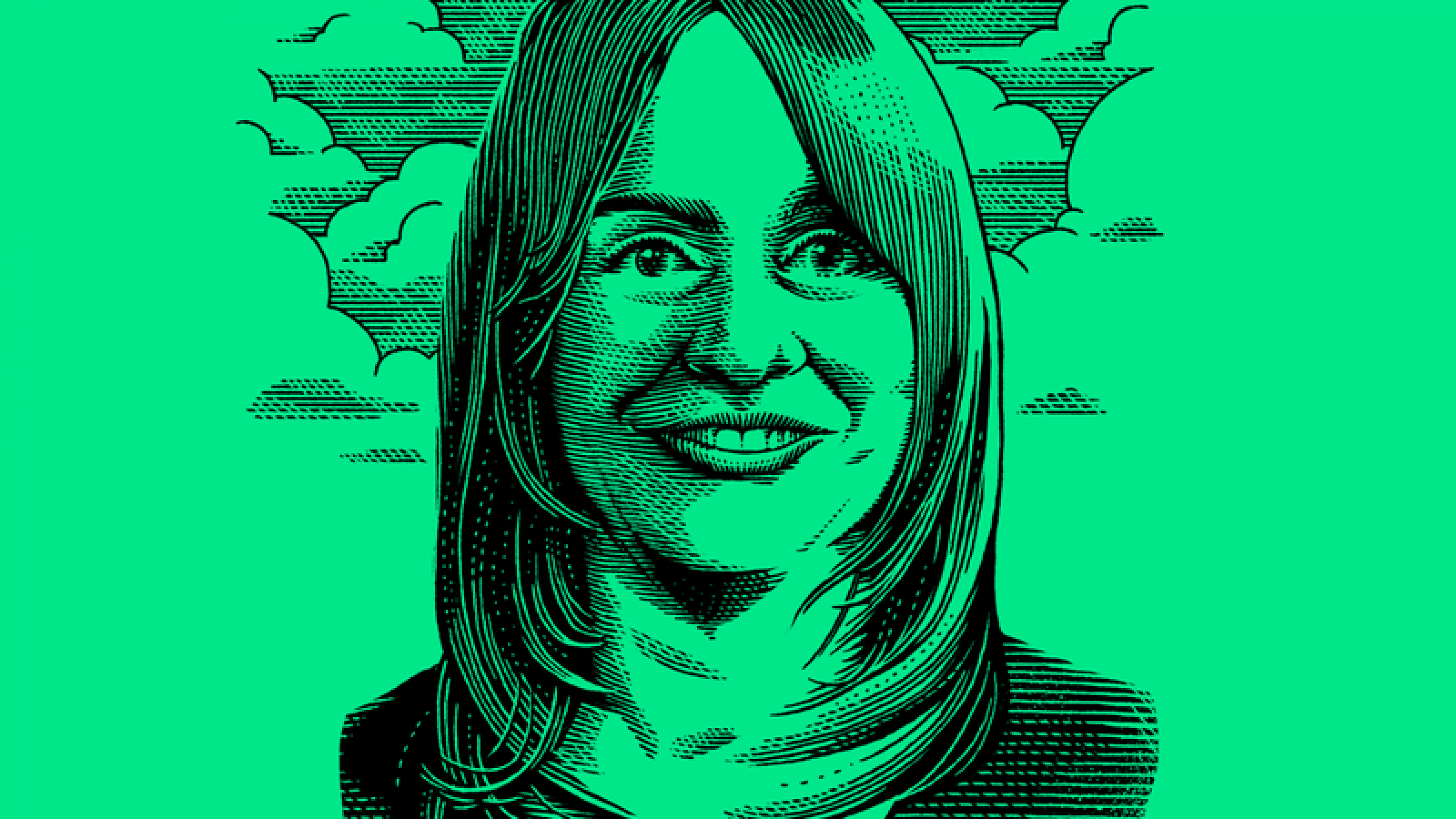
Taodue, Romanzo criminale, fino a Suburra per Netflix. Una chiacchierata con una sceneggiatrice che ha lasciato un’impronta sulla fiction di oggi.

Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 23 - Autori Seriali del 25 giugno 2018
Tra tutti gli sceneggiatori che abbiamo intervistato, Barbara Petronio è quella più agguerrita nel sostenere l’idea che gli scrittori debbano essere considerati i veri autori della serie. Il concetto è semplice: in quanto creatori dei personaggi e della narrazione che li contiene, devono anche essere i garanti ultimi della coerenza del mondo immaginato. Petronio ha mosso i primi passi in Taodue al fianco di Daniele Cesarano, e con lui ha costruito pezzi importanti dell’immaginario seriale italiano, prima con Romanzo criminale per Sky e poi con Suburra per Netflix. Le donne volitive non mancano nel mondo della fiction nazionale, e Barbara Petronio è senza dubbio una di loro.
Stiamo mettendo in piedi un’indagine per capire chi è depositario unico di una serie, il suo autore. Perché dovrebbe essere proprio lo sceneggiatore?
Il creatore della serie non può che essere chi ha avuto l’idea della serie, chi ne detiene la visione. E di solito lo è più lo scrittore del produttore. Mi è capitato spesso di lavorare con produttori che dicono “voglio fare una serie sulla polizia corrotta”, ma poi a parte questo non contribuiscono alla creazione. L’autore è invece chi questa idea la trasforma in un prodotto dal senso narrativo compiuto. Nessuno si domanda chi è l’autore di un romanzo.
L’esempio del romanzo lo capisco, ma calza fino a un certo punto, perché lì lo scrittore è davvero da solo nella stanza a scrivere la sua opera. Lo scrittore seriale si deve confrontare con il produttore, il regista, con questo e con quell’altro.
Ci sono tante figure che possono cambiare il corso della storia, ma tendenzialmente attribuisco la creazione di un’opera a chi ha l’idea e la rende materia da girare. Quindi, nel caso in cui abbia avuto lui l’idea, è senza dubbio lo sceneggiatore. Solo chi l’ha pensata può avere la visione, dare l’andamento giusto ai modelli narrativi e a quello che poi deve fare il regista: il tono di una serie, la parte visiva, lo stile. Un autore che crea un mondo narrativo ha una visione che spalma non solo sulla carta ma anche sugli altri reparti. Ovviamente, parlo di un mondo che in Italia ancora esiste solo sporadicamente. Però, se si analizzano le migliori serie nel mondo, spesso, o sempre, il ruolo più importante è attribuito allo scrittore. Se consideriamo l’Italia, posso dirti che su Romanzo criminale ritengo autori della serie sia gli scrittori sia il regista, perché lì si creò una bella sinergia tra quello che avevamo messo sulla carta e quello che poi Stefano Sollima è stato in grado di percepire e trasformare.
Ci vuoi raccontare un po’ quell’esperienza?
Nacque in modo molto spontaneo. Io, Daniele Cesarano e Leonardo Valenti volevamo adattare il romanzo di De Cataldo e proponemmo questo lavoro a Cattleya, che lo apprezzò e ci diede praticamente carta bianca, ma molto poco tempo per sviluppare il soggetto: una sorta di concept allargato, più o meno l’andamento delle puntate e quant’altro. Stefano all’epoca non era il Sollima che poi è diventato, ma un regista che voleva dimostrare di poter fare fiction di qualità superiore rispetto a quella che andava in onda. Onestamente, anche Sky all’epoca non aveva una linea editoriale definita. Non si sapeva quante serie avrebbe prodotto, se ne avrebbe prodotte altre, era tutto molto artigianale, ma anche genuino e forte.
Quindi in quel caso Sky intervenne poco?
Quasi per niente. Ma anche Sollima. Ci ritrovammo tutti a condividere questa idea che evidentemente funzionava, quella di mostrare un lato più approfondito e tridimensionale del gangster. Raccontare nella serie quello che nel film o nel romanzo potevi avere intravisto ma senza conoscerlo davvero, quegli spazi narrativi che la serialità rende possibili e praticabili.
Anche De Cataldo non è intervenuto?
Ci siamo confrontati spesso, perché volevamo avere non solo la sua opinione in quanto autore del libro, ma anche quegli insight che nel libro o nella cronaca non trovavamo. La sua conoscenza di quel mondo è così ampia e dettagliata che sentivamo la necessità di avere il suo punto di vista su molti temi. Mi ricordo che una volta gli dicemmo che volevamo dare al Libanese una mamma, che nel romanzo e nel film non ha, e lui ci disse senza problemi: “va bene, mi sembra interessante”. Insomma, anche in questo caso si creò una sinergia che poi raramente mi è capitato di ritrovare.
Nel lavoro come vi organizzavate?
Lavoravamo insieme, discutevamo, ognuno veniva con le sue idee e poi si trovava una sintesi, ma anche lì è stato molto facile, fluido. Non ci sono stati intoppi creativi o produttivi. Quando fai gli esperimenti, quando scopri una nuova strada, il percorso è sempre in discesa, almeno da quello che ho visto io. Nella fase di ideazione ci vedevamo tutti i giorni. Poi quando siamo arrivati a scrivere le puntate, ognuno stava più tempo rintanato per conto suo.

Questa esperienza si colloca a metà del tuo percorso professionale, che ci interessa molto perché hai lavorato con le reti generaliste, appunto con Sky, e ora con Netflix. Ci puoi dire allora com’è cambiato il tuo ruolo da autrice?
Ho cominciato molto giovane, avevo 27 anni e ho lavorato per Taodue e per la generalista su Distretto di polizia, su Ris e altri titoli simili. In quella situazione lavorativa lo scrittore ha una discreta importanza, ma è ovviamente il produttore che decide, non solo gli aspetti di carattere produttivo ma anche quelli di carattere narrativo. Lì come scrittore sei più al servizio. Anche se poi è vero che buona parte della mia esperienza l’ho fatta dentro Taodue, perché in modo del tutto non previsto, artigianale quasi, andavo anche al montaggio e spesso sul set. Ho fatto un’esperienza a 360 gradi sul prodotto, davvero rara. Se non avessi avuto questa possibilità, molto probabilmente non avrei fatto il percorso successivo. Quindi, in maniera non professionalmente attribuita, il ruolo che si può chiamare di showrunner, non so come definirlo, uno sceneggiatore multifunzione che va anche a parlare con gli attori, il regista, il montatore, l’ho potuto vedere da vicino ai tempi di Taodue. Sono situazioni che in Italia non sono codificate come negli Stati Uniti, ma possono accadere. E lo scrittore può essere allora chiamato a esprimere un ruolo, un parere, non solo sulla parte scritta.
Vedi la generalista come una realtà dove è il produttore che tiene le fila?
Fino a ora è stato il produttore, parlando della mia esperienza. Percepisco però che tutto questo sta cambiando e che anche lì lo scrittore comincia ad avere un ruolo più importante, e di conseguenza il produttore torna a essere un po’ più produttore, come dovrebbe essere. Il modello del produttore al centro del sistema secondo me segna un po’ il passo. Mi ricorda una cosa che funzionava negli Stati Uniti negli anni Novanta, quel produttore che faceva un sacco di serie…
Aaron Spelling.
Aaron Spelling, esatto! Lui aveva una linea, ha fatto successi mondiali mostruosi, ma poi quel modello è rimasto indietro, perché non puoi pensare che una mente da sola riesca a tenere in piedi un network per più di dieci anni.
E invece nel mondo di Netflix in cui stai lavorando in questo momento?
Netflix è una tv che non va in televisione, quindi ha un approccio del tutto diverso. Quando scrivi per la generalista, o anche per Sky, ti rifai più o meno a modelli narrativi consolidati. Invece con Netflix ci è stato detto: “sentitevi liberi di raccontare la storia come volete raccontarla”, senza pensare alle pause pubblicitarie, ai ganci eccetera. Questa libertà narrativa non corrisponde a una mancanza di interesse verso il lavoro, al contrario sono molto presenti nella parte editoriale. Ci siamo confrontati con il responsabile che segue le serie americane, che magari aveva un po’ di difficoltà a capire determinate…
Espressioni in romanesco.
Sì, ma alla fine capiva quello che serve, faceva note sempre gestibili, nel senso che non cambiavano mai la visione della puntata o della serie. Più che altro ci spingevano ad andare più a fondo nei personaggi. Devo dire che rispetto ai reparti editoriali della generalista e di Sky, si percepisce che gli americani hanno alle spalle una storia di serialità molto importante.
Puoi raccontarci qualche altro esempio?
Netflix pone un’attenzione pragmatica alle cose che però non travalica mai il confine del punto di vista artistico, della visione dell’universo narrativo e delle sue regole interne, cosa che invece mi è capitata spesso in una generalista: “questo tema non lo voglio toccare”, “lo devi toccare così”, o “stiamo attenti”. Netflix ti dice: “raccontiamo tutto, purché in maniera avvincente”. C’è sempre la necessità di soddisfare il pubblico più ampio possibile perché comunque, anche se Netflix in Italia è una realtà piccola, è una piattaforma che ha in nuce alcune caratteristiche generaliste. Offre più prodotto possibile, mentre la generalista cerca di prendere più pubblico possibile e quindi ibrida il prodotto: deve essere un crime, ma per famiglie…
Deve prendere più pubblico possibile in quel passaggio. Ha la pistola puntata alla testa.
Esatto! Invece per questi avere più pubblico possibile significa più abbonati possibile.
Per Suburra tu sei head writer, giusto?
Sì.
E che cosa fa l’head writer di Suburra?
Devo fare una precisazione, perché Netflix lavora in modo diverso da Paese in Paese. In Italia hanno commissionato la serie a Cattleya, che teorizza la supremazia e la visione del produttore come marchio di fabbrica. Quindi l’head writer coordina la scrittura, la gestione narrativa degli eventi e delle puntate, anche la marea di note che arrivano dal produttore e da Netflix. Poi c’è tutta una parte che riguarda il reparto editoriale Cattleya, che va dalle note del produttore delegato e finisce con le prestazioni dell’attore. Si tratta di un lavoro di omogeneizzazione del materiale, ma allo sceneggiatore non è attribuito alcun potere decisionale.
Perché Cattleya ha questo approccio.
Perché Cattleya ritiene di doversi distinguere così nel mercato. Questo non significa che noi come sceneggiatori non possiamo dire la nostra…
Chi ha avuto l’idea dell’adattamento di Suburra?
Adesso ti spiego dove sta, a mio parere, il problema rispetto a questa teoria di Cattleya, che non condivido. La domanda che mi fai ha una risposta precisa: non Cattleya, ma un gruppo di scrittori, che ha avuto un’idea che poi Cattleya ha apprezzato. Questo è quello che è successo anche per Romanzo criminale. Solo che nel frattempo c’è stato il grande successo di Gomorra, una serie su cui non ho lavorato, ma che da quanto ho capito ha avuto una gestazione molto complessa, il cui successo finale è arrivato anche grazie alle modalità con cui il produttore si è approcciato alla materia. Ma di questo non ho esperienza diretta. Quello che posso dire è che il sistema in cui sei nominato head writer, che è un ruolo importante ma non a 360 gradi, quando invece sei quello che ha avuto l’idea seriale, è secondo me sbagliato. Lo scrittore, nel caso di Suburra più di uno, che ha creato l’universo narrativo della serie dovrebbe essere considerato in maniera diversa, con una responsabilità che non è solo quella della pagina scritta ma anche delle diverse fasi di lavorazione, cosa che Cattleya vuole limitare il più possibile. Tra l’altro, non sono il tipo di persona che pensa che lo showrunner debba essere l’imperatore della serie, quello che decide sopra ogni testa. Per me le serie migliori sono quelle frutto di sinergie. Se uno sceneggiatore non va d’accordo con il regista non viene fuori un bel film, se invece è la storia che vince fra l’ego dello sceneggiatore e quello del regista o del produttore, se la storia è la cosa più forte, allora hai davvero un titolo di successo e una gestazione più facile.
Quando siete andati a proporre a Cattleya questa idea di serializzazione del titolo cinematografico…
No, aspetta, non mi sono espressa bene. Cattleya ci ha chiamato dicendo: “vogliamo fare la serie da Suburra, perché Netflix la vuole, presentateci delle idee”. Questa è un’altra cosa che andrebbe discussa, perché in Italia difficilmente il produttore va dall’autore e gli dice “raccontami una tua idea per una serie di successo”. Il produttore dovrebbe cercare le idee migliori, comprarle e poi realizzarle, ma questo in Italia non avviene. Di solito con me accade questo: “siccome hai scritto Romanzo criminale, presentaci un’idea per sviluppare Suburra”. Prima non c’era un’idea di Suburra, ma solo il film.
Quindi in Italia è raro che un autore butti giù l’idea di serie, la venda a un produttore e questo a una rete?
Che la butti giù non è raro, perché nei miei cassetti ho centomila cose. È impossibile però che tu da una tua idea riesca ad andare da un produttore, dire: “questa è la mia idea”, e che lui dica: “ci credo e la faccio”.

Sei a conoscenza di serie di una certa importanza che hanno avuto questo iter?
Ci sono degli esempi, ma penso che in Italia si contino sulla punta delle dita. Forse le serie di Cotroneo. In America fanno le pitch session in cui vai lì con le tue idee, passi di banchetto in banchetto, da un produttore a un altro, ma in Italia non funziona così. Ci arrivi per altri canali che magari ti crei grazie a relazioni professionali, conoscenze, opportunità, e anche ai successi che riesci a realizzare.
Ma secondo te questo aspetto si può cambiare?
Credo di sì.
In parte qualcosa sta già cambiando, altrimenti non saremmo qui a parlare. Come si evolve la figura dello sceneggiatore?
Secondo me si sta andando lentamente verso lo showrunner, un autore che è depositario della visione della serie. I titoli che sono figli di un punto di vista unico funzionano meglio, e la visione definita e precisa deriva o da diverse idee che si incontrano sulla strada o da una persona che ha le idee più chiare degli altri. Questo è il ruolo di una persona dotata di un talento artistico, sia esso un regista o uno sceneggiatore, ma non è una capacità che attribuisco a un produttore. Vent’anni fa c’era meno finezza narrativa. Adesso, l’apporto artistico a una visione è un fattore imprescindibile.
Quali sono le caratteristiche che uno sceneggiatore deve avere per incarnare questo ruolo?
Innanzitutto deve avere una buona idea, in cui crede. Per trasmetterla agli altri deve avere competenze visive, registiche, e non è un caso che nella serialità americana molte volte il creatore della serie fa anche la regia di alcuni episodi. Spesso il pilota, perché deve dare un imprinting agli altri registi, deve spiegare il look della serie. Non nascondo che mi piacerebbe e che mi sento pronta a fare la regia di un’idea che ho pensato e scritto. Non ho una formazione da regista, ma è un ruolo talmente “imbricato” con quello dello sceneggiatore che è naturale aspirarvi. Dipende dalla personalità di ciascuno: se uno se la sente di stare per due settimane a dirigere il pilota di una serie che ha ideato, perché no?
Deve avere anche capacità gestionali, suppongo.
Gestionali di sicuro, ma da quello che vedo in Italia il budget difficilmente sarà gestito da qualcuno diverso dal produttore. Chiaramente devi conoscere la produzione, devi capire i costi di un modello narrativo rispetto a un altro. Ma con un minimo di esperienza di scrittura, di set, di produzione te ne rendi conto. Chiaro che se pensi di avere un’idea low budget che si rivela high budget è un problema.
Ti faccio una domanda un po’ provocatoria: se non vai sul set, non ti capita mai di lavorare con il resto delle figure creative che ruotano attorno alla realizzazione del prodotto?
Sul set io a volte ci vado. Cattleya non ti dice di andare sul set tutti i giorni, mentre altre produzioni magari te lo dicono. L’incontro con i registi e con gli attori lo fai sulle pagine scritte, ci sono le letture in cui ci si confronta. È inevitabile. Sono convinta che lo sceneggiatore sarà sempre più necessario, e avendolo sempre a disposizione, tra l’altro, la produzione risparmia, non hai bisogno di richiamare altri scrittori per riscrivere, cambiare. La responsabilità che attribuisci a una figura poi a cascata ti porta dei vantaggi.
Quanto pesa il fatto che oggi ci sia un mercato globale della fiction più attivo anche nei confronti delle produzioni italiane?
Molto. Forse è il peso più importante nel cambiamento in corso. Un’attenzione internazionale significa che lo sceneggiatore assume più responsabilità: quando siamo stati ingaggiati da Cattleya, Netflix ha chiesto in particolare che gli head writer firmassero un tot di puntate. Netflix è un player che dice: “ok, questi sono gli scrittori che tu dici essere bravi, allora fai scrivere loro più puntate possibili”. Ed è una cosa che mi ha colpito, perché dà allo scrittore un potere molto più grande. Una cosa del genere in Italia non c’era mai stata. Non c’è stato mai nessuno a dirmi: “ti faccio scrivere questa serie ma tu almeno me ne scrivi cinque puntate”, o “scrivi la prima e l’ultima di sicuro, perché voglio così”, e questo fa la differenza. E si vede nei prodotti.
Secondo te, il fatto che si parli tanto degli showrunner incide sulla percezione esterna? Un appassionato di serie sa chi è lo showrunner, conosce Vince Gilligan o Howard Gordon. Trovi le loro interviste sul Corriere o su Repubblica. Pensi che questa narrazione pubblica incida anche sul cambiamento del mestiere dello sceneggiatore in Italia?
Credo proprio di sì. Chi è appassionato di serialità ha dimestichezza con questo ruolo, sa che il creatore della serie è appunto lo showrunner, un termine che sta entrando nel dizionario degli addetti ai lavori e dei fan. C’è un investimento emotivo da parte dell’appassionato su chi identifica per semplicità come vero artefice della serie. Per cui sì, arriva il regista ma ogni regista deve girare il nuovo episodio di Breaking Bad esattamente come lo vuole Vince Gilligan. Possono cambiare dieci registi in una stagione, nemmeno te ne accorgi. Ed è quasi sempre così, tranne esempi isolati come True Detective.
Quello è un caso un po’ strano.
Questa modalità registica sta prendendo piede. Ma nasce più in Europa, il regista per tutta la serie. In Italia è stato spesso così.
Come ti è sembrata The Young Pope?
The Young Pope è un discorso talmente a parte, talmente autoriale che solo Sorrentino poteva farlo. Lui è il creatore di quel prodotto e a tutti gli effetti l’unico showrunner. Trovo interessante l’esperimento di Hbo che affida a un regista non americano una serie del genere, scardinando tutte le regole. Poi nei risultati è come quando vedi un quadro d’arte contemporanea: ti possono arrivare tante sensazioni, ma non lo ritengo un titolo da grande pubblico. Non penso che Netflix potrebbe mai fare un’operazione simile. Per me la serialità ha comunque delle regole: l’affezione al prodotto, il desiderare di vederne il seguito. Con The Young Pope non è successo. Ma sono una persona di gusto medio, mi piacciono le cose di genere, a cui mi aggancio in modo facile. Diciamo che non mi è partito il binge watching.
I titoli che sono figli di un punto di vista unico funzionano meglio, e la visione definita e precisa deriva o da diverse idee che si incontrano sulla strada o da una persona che ha le idee più chiare degli altri. Questo è il ruolo di una persona dotata di un talento artistico, sia esso un regista o uno sceneggiatore. L’apporto artistico a una visione è un fattore imprescindibile.
Con Suburra, quando la scrivevate, vi capitava di pensare al binge watcher?
Eh, hai voglia, sempre!
Come ve lo figuravate?
Cerchi soluzioni che speri siano efficaci per agganciare il pubblico. E lavori molto su tutti i personaggi, perché alla fine il binge watching si innesca grazie alle emozioni che la serie riesce a farti provare. Ne vuoi di più. Ci siamo concentrati sull’empatia dei personaggi: il pubblico doveva amarli, voler stare a lungo in loro compagnia, preoccuparsi della loro sorte.
Fabio Guarnaccia
Direttore di Link. Idee per la televisione, Strategic Marketing Manager di RTI e condirettore della collana "SuperTele", pubblicata da minimum fax. Ha pubblicato racconti su riviste, oltre a diversi saggi su tv, cinema e fumetto. Ha scritto tre romanzi, Più leggero dell’aria (2010), Una specie di paradiso (2015) e Mentre tutto cambia (2021). Fa parte del comitato scientifico del corso Creare storie di Anica Academy.
Vedi tutti gli articoli di Fabio GuarnacciaLeggi anche

Stand by me
Intervista a Simona Ercolani

Mediamorfosi 3
Le tecnologie del metaverso e il loro significato

