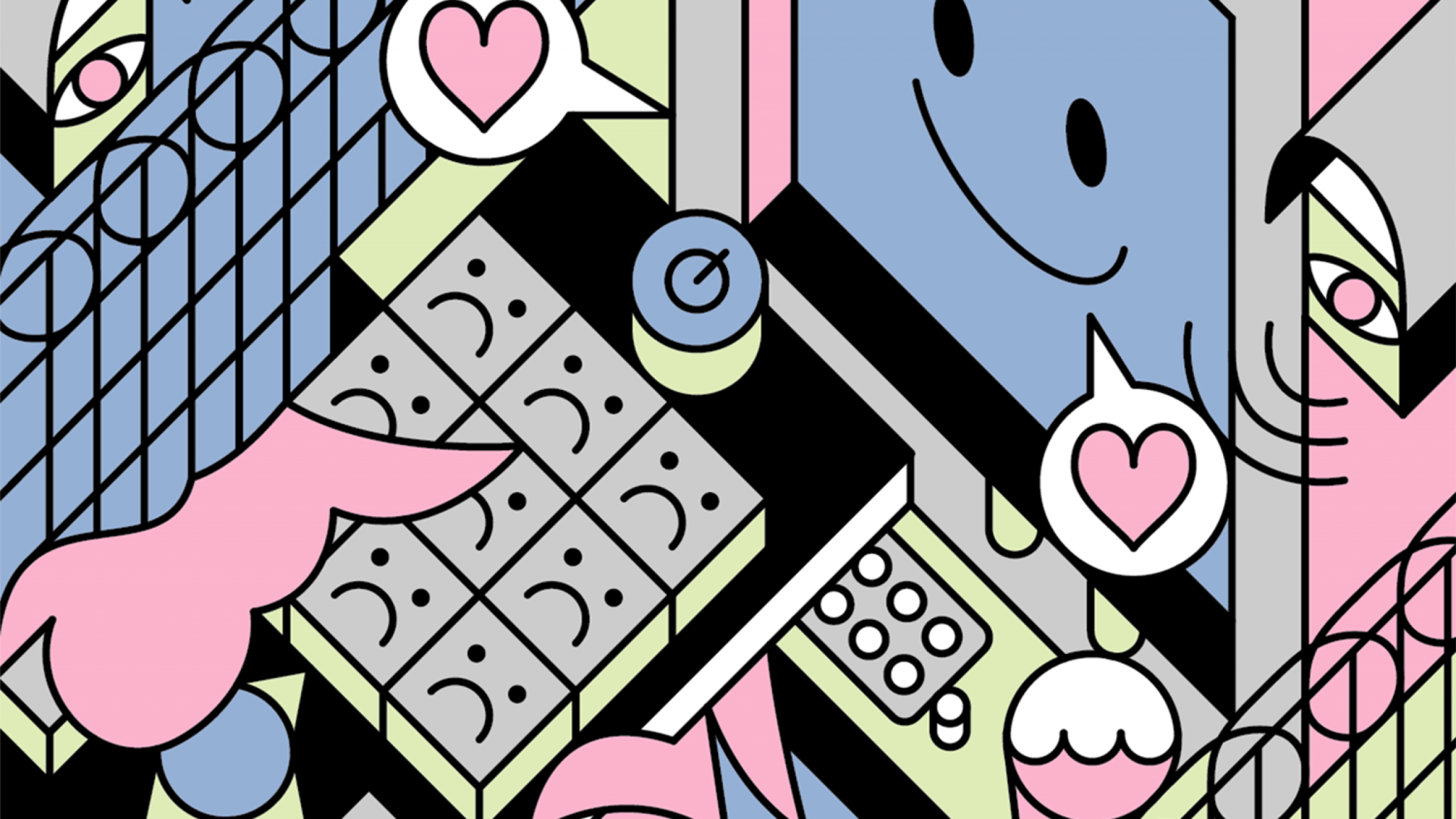
Distopia è una parola centrale della narrazione contemporanea, ormai anche in chiave seriale. Ma sono pochi i futuri che reggono il passo del presente.
“Questa storia non parla di censura, questa storia parla di come la televisione ci stia rincretinendo”. Sono le parole che Ray Bradbury in persona utilizzò per smorzare il coagulo di speculazioni che negli anni si erano accumulate attorno a Fahrenheit 451. Lette oggi aiutano a comprendere, più di ogni puntuta recensione, le ragioni per cui il riadattamento prodotto e trasmesso da Hbo in queste settimane si sia rivelato un sostanziale fallimento.
Quando nell’aprile 2017 cominciò a circolare la notizia che Ramin Bahrani, regista di apprezzate pellicole come Chop Shop e 99 homes, stava lavorando a una nuova trasposizione del romanzo di Bradbury, e che aveva tirato a bordo nomi del calibro di Michael Shannon e Michael B. Jordan, in molti hanno cominciato a fregarsi le mani. Per quanto efficace e indimenticabile, infatti, la versione di Truffaut risale al 1966. Nel frattempo il mondo ha cambiato volto. Nonostante questo, tuttavia, l’opera di Bradbury fornisce ben più di un appiglio per raccontare il presente. Bahrani aveva l’imbarazzo della scelta: l’anti-intellettualismo diffuso, l’interesse politico nel minare l’impalcatura culturale, il ruolo dei social media come agente isolante travestito da collante sociale, la necessità di orientarsi in una tempesta di informazioni in cui è sempre più difficile distinguere l’autentico dal fasullo, la progressiva incapacità di prestare attenzione che, per parafrasare ancora una volta Bradbury, “rende quasi impossibile per una persona, me compreso, sedersi a leggere un romanzo”.
Adattamenti che non funzionano
Qualcosa, però, è andato storto. Fahrenheit 451 di Ramin Bahrani è ambientato in un futuro imprecisato (ma non troppo lontano dal presente, a giudicare dalla sostanziale corrispondenza tecnologica con il mondo attuale), in cui gli Stati Uniti sono retti da una dittatura che ha praticato alla cittadinanza un lavaggio del cervello pressoché totale: la maggior parte delle persone è convinta che il corpo dei vigili del fuoco sia stato creato da Benjamin Franklin allo scopo di bruciare libri, che leggere provochi tristezza e patologie mentali, e che l’unica verità sia quella offerta da una sorta di “canale internet” ultracontrollato e ultrasemplificato chiamato “the 9”. La vita domestica delle persone è monitorata da smart speaker che ricordano da vicino dispositivi come Amazon Alexa e Google Home, mentre gli immancabili ribelli si servono di un sistema di codificazione genetica (ispirato a studi attuali) per immagazzinare tutto lo scibile in un supporto biologico. Ed è proprio questa commistione tra favola e realtà, l’indecisione formale tra la trasfigurazione simbolica e la proiezione speculativa, a rendere fin da subito respingente il mondo distopico di Bahrani.
Negli ultimi anni le distopie hanno registrato una vera e propria esplosione, in ambito letterario e cinematografico. Per contro, hanno impiegato molto più tempo ad attecchire nel mondo della serialità televisiva. “La cosa più difficile”, scrive Kindley, “è trovare un modo di raccontare una storia in maniera seriale in un mondo che alla lunga rischia di risultare depressivo, o peggio ancora didascalico”.
Prendiamo The Handmaid’s Tale di Bruce Miller. In questo caso la cesura con la realtà attuale è molto più marcata, ma l’assenza di legami diretti con la situazione politica e tecnologica attuale è controbilanciata da un’impalcatura narrativa coerente che, anche a trent’anni di distanza dal romanzo che ha ispirato la serie, fornisce una sponda allegorica per raccontare una diseguaglianza sempre meno sotterranea. Se l’intento di Bahrani era di creare una sponda allegorica per raccontare il presente, magari per trasfigurare l’America di Trump e delle fake news in un contesto distopico, l’esperimento non è riuscito.
Peccato, perché l’idea per cui i libri cartacei possano resistere alla censura digitale in quanto supporto fisico e non tracciabile era efficace; la prospettiva invece di un governo che si pone come primo obiettivo quello di convincere la gente che i libri siano malvagi, oggi, appare abbastanza ridicola. Innanzitutto perché le persone che leggono almeno un libro al mese sono in costante calo da almeno dieci anni. Non solo: un governo che si picca di ostacolare la diffusione del sapere e della cultura bruciando i libri risulta ancora meno plausibile in un mondo in cui il concetto di controllo si è fatto più subdolo e nascosto. Trasporre F451 nel mondo attuale avrebbe comportato affidare l’aspetto “dispotico” a un algoritmo, a una selezione di contenuti che fornisce una parvenza di libertà di scelta, calando il protagonista in un’illusione di controllo. Questo scenario è molto più difficile da comunicare a livello visivo e non stupisce che gli autori abbiano deciso di propendere per una distopia “aggiornata”, creando però una marcata cesura con il nostro mondo, e derapando nel campo dell’ucronia.
Distopie di un futuro passato
Negli ultimi anni le distopie hanno registrato una vera e propria esplosione, in ambito letterario e cinematografico. Per contro, hanno impiegato molto più tempo ad attecchire nel mondo della serialità televisiva. Sulle ragioni di questo ritardo, Evan Kindley ha una teoria interessante. “Le narrazioni distopiche tendono ad avere un tono piatto: la loro priorità e mostrare quanto le cose siano intollerabili, e questo impedisce una vera varietà scenica o l’utilizzo di intermezzi comici. Inoltre, è difficile che possano incardinarsi su un personaggio, dal momento che il tipico protagonista distopico (pensiamo a Winston Smith di 1984) è più che altro un testimone della sofferenza diffusa nel mondo narrato”.
Non stupisce, dunque, che ancora oggi si tenda a preferire trasposizioni non-serializzate. Ma anche in questo caso le distopie presentano problematiche difficili da aggirare. Operazioni come quella di Bahrani dimostrano come talvolta la distopia tenda ad appiattirsi su un canone stereotipico: governi dispotici, cittadini che si affidano a un solo canale di informazione (spesso televisivo), nuove droghe diffuse come farmaci da mutua, una rigida suddivisione in classi e libertà d’espressione soppressa senza troppe proteste da parte della popolazione. Il futuro proiettato è quasi sempre oscuro, terrificante, con esagerazioni che possono funzionare a livello concettuale e visivo ma risultano del tutto implausibili, soprattutto considerando che sono spesso proiettate sullo sfondo di una società quasi totalmente compiacente. Quando Bahrani mette in scena un mondo in cui la fruizione multimediale è tornata a essere univoca e verticale (il 9 è una sorta di trasfigurazione connessa di un palinsesto televisivo, che non consente unicamente di ricevere informazioni, senza poterne introdurre in circolo di nuove), cancella deliberatamene trent’anni di rivoluzione digitale, troncando alla base ogni possibile collegamento con la situazione presente.
“La cosa più difficile”, chiosa Kindley, “è trovare un modo di raccontare una storia in maniera seriale in un mondo che alla lunga rischia di risultare depressivo, o peggio ancora didascalico”. Per ovviare a questo problema, la soluzione più naturale sembrerebbe optare per il formato antologico; ma anche tale approccio può rivelarsi fallimentare. Basti pensare a Electric Dreams, in cui fior di registi e attori hanno unito le forze per dare nuovo smalto televisivo ai racconti di Philip K. Dick. Nonostante la qualità del materiale di partenza, il risultato ha scontentato persino i fan dell’autore. Il motivo è piuttosto semplice: gli autori hanno cucito un vestito moderno addosso alle storie di Dick senza preoccuparsi di adattarle alle problematiche e alle tendenze attuali. Il futuro di Electric Dreams, come quello del Fahrenheit di Bahrani, ha superato la data di scadenza.
Per fortuna, esistono anche segnali di controtendenza che lasciano intravedere un orizzonte florido per questo tipo di narrazioni speculative. L’esempio virtuoso è Black Mirror. Qui, la scelta antologica si è rivelata efficace. Charlie Brooker è riuscito a confezionare delle mini-pellicole autoconclusive, ognuna delle quali prende una tendenza ravvisabile nel presente (il cyberbullismo, il rapporto con la memoria, l’influenza dei social media sull’identità personale, la scomparsa della privacy, gli studi per la digitalizzazione delle coscienze) e la fa esplodere in un contesto narrativo realistico, lasciando da parte la macropolitica per esplorare la dimensione esistenziale del singolo.
E un’altra operazione riuscita è quella di Westworld: Jonathan Nolan ha avuto l’intelligenza di costruire un mondo fittizio a partire da un recinto chiuso e dunque separato dal presente della narrazione, per allargare via via il campo di indagine. Il risultato è una serie che riesce a esplorare le nuove potenziali frontiere dell’intelligenza artificiale, tracciando nel contempo una riflessione esistenziale e trasversale sul concetto di “umanità”.
E allora ecco futuri piagati da lotte di classe, pandemie apocalittiche, condizioni climatiche invivibili e governi ossessionati dal controllo digitale, in cui però, assurdamente, sono scomparse le discriminazioni di genere, razza e orientamento sessuale.
Una proiezione incompleta
Ci sono anche distopie che si piccano di indagare il presente a livello macroscopico, superando l’aspetto esistenziale e privilegiando la dimensione sociale. Alcune hanno riscosso un grande successo di pubblico sul grande schermo, con saghe young adult come Hunger Games, Maze Runner e Divergent. Ma anche in questo caso, la proiezione risulta falsata. Spesso le distopie per ragazzi tendono a portare oltre il punto di ebollizione alcune tendenze della società contemporanea, per ignorarne altre altrettanto importanti. E allora ecco futuri piagati da lotte di classe, pandemie apocalittiche, condizioni climatiche invivibili e governi ossessionati dal controllo digitale, in cui però, assurdamente, sono scomparse le discriminazioni di genere, razza e orientamento sessuale. “Se gli Stati Uniti dovessero davvero trasformarsi in uno stato totalitario, o subire una catastrofe ambientale”, scrisse Imran Siddiquee sulle pagine dell’Atlantic, in occasione dell’uscita di Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, “è ragionevole ipotizzare che le più profonde disparità sociali non sparirebbero per magia da un giorno all’altro”.
È anche per via di questa lacuna tematica che una storia come Il racconto dell’ancella è riuscita a intercettare un pubblico inaspettatamente affamato di distopia; ed è per lo stesso motivo che, con ogni probabilità, e se il livello di scrittura sarà altrettanto buono, Black America otterrà un’attenzione simile. Ideata da Will Packer e Aron MacGruder e prodotta da Amazon, Black America racconta una storia ambientata in un presente alternativo in cui, alla fine della guerra civile, gli stati di Louisiana, Mississippi e Alabama sono stati concessi agli schiavi liberati come forma di riparazione. La scelta di affrontare tematiche razziali in chiave fantascientifica non è nuova, basti pensare a pellicole recenti come Black Panther, ma il cosiddetto “afrofuturismo” ha finora trovato poco spazio nel panorama delle serie tv.
È interessante inoltre notare come l’annuncio della produzione di Black America sia arrivato a ridosso della polemica nata attorno a quello di Confederate, la serie che David Benioff e D.B. Weiss avrebbero dovuto creare per HBO e che attualmente è in fase di stallo. L’idea dei suoi creatori era quella di creare un’ucronia in cui la Guerra Civile Americana si fosse conclusa con una separazione tra Stati Uniti e Stati Confederati: al di sopra della linea Mason-Dixon ci sarebbe stato un paese simile agli attuali Stati Uniti, al di sotto uno in cui lo schiavismo non è mai stato abolito e ha continuato a fungere da pilastro economico della società. Se l’annuncio ha scatenato un vespaio non è solo perché molti hanno letto nel soggetto una sorta di avveramento dei sogni più estremi dei suprematisti bianchi, ma perché presentava in forma fantascientifica una prospettiva che, nei fatti, non è poi così lontana dalla realtà, dimostrando di conoscere ben poco della condizione di netta disparità (a livello di diritti, opportunità, stipendio e salute) dell’attuale popolazione afroamericana. Sempre sulle pagine dell’Atlantic, l’autore di Tra me e il mondo Ta-Nehisi Coates, riassume così il problema di fondo: “Gli afroamericani non hanno bisogno di sentirsi dire dalla fantascienza – o da qualunque tipo di narrativa fittizia – che ‘questa storia è ancora parte del nostro Paese’”. Insomma, la distopia ideata da Benioff e Weiss non funzionava per un motivo molto semplice: andava di fatto a obliterare una condizione distopica reale, e presente.
Considerando quanto sia precaria l’attuale situazione economica, ambientale e sociale globale, è lecito aspettarsi che il numero di distopie (o narrazioni post-apocalittiche) non sia destinato a diminuire; anzi, ora che è stato dimostrato come il genere possa funzionare anche con un’impostazione seriale, è probabile che l’età dell’oro della distopia televisiva debba ancora entrare nel vivo. La speranza è che autori e produttori decidano di abbandonare i vecchi stilemi per esplorare nuovi approcci alla narrazione speculativa, che si sforzino di proiettare le ombre del presente invece di quelle del passato.
Fabio Deotto
Laureato in biotecnologie, è scrittore, traduttore e giornalista. Scrive di scienza e cultura per diverse testate. Ha pubblicato due romanzi con Einaudi, Condominio R39 e Un attimo prima. Nel 2021 ha scritto il saggio L' altro mondo. La vita in un pianeta che cambia.
Vedi tutti gli articoli di Fabio Deotto


