
Alcune tendenze musicali degli ultimi anni sembravano già prefigurare un cambio di rotta, dalla sprezzatura al ritorno del video. E ora, senza concerti ma con TikTok, dove andranno le mode e le industrie che si appoggiano su pop e dintorni?
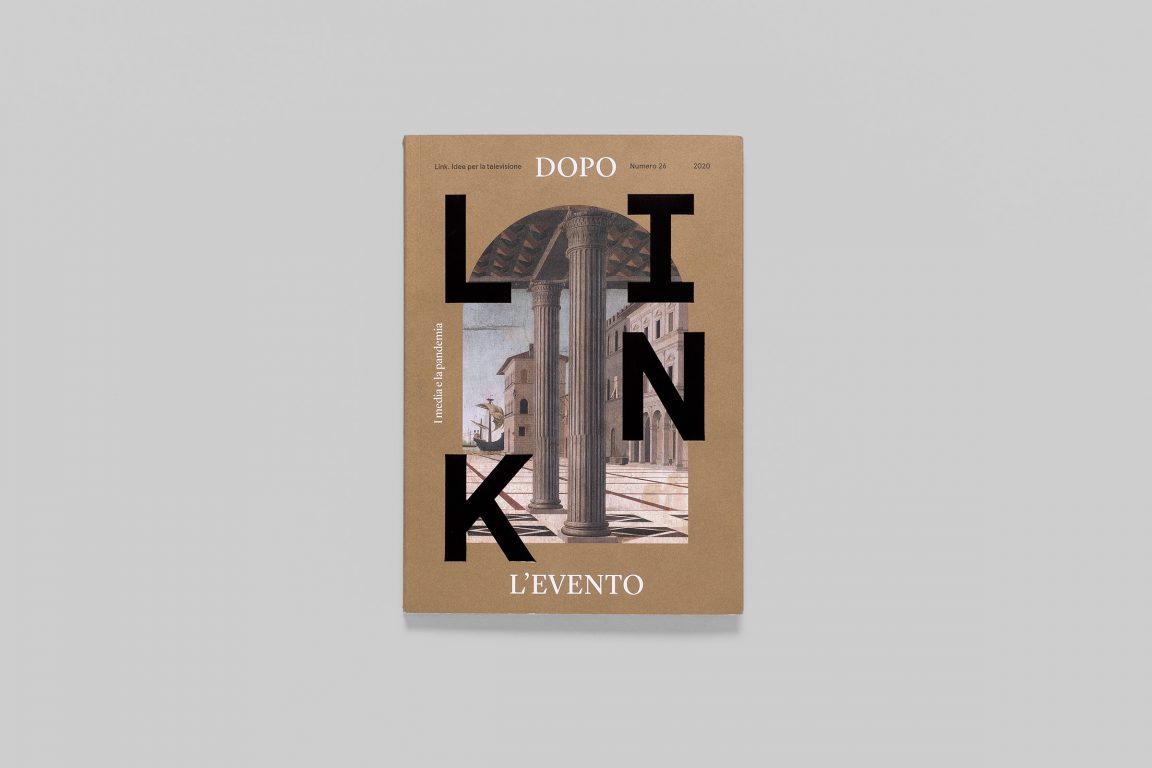
Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 26 - Dopo l'evento. I media e la pandemia del 09 novembre 2020
“Quando lavori nella musica da un po’ di anni, sai che arrivano con una certa regolarità nuove ondate, che si alzano alte e portano a riva tanta roba nuova. Anche se a qualcuno piace pensarlo, non spazzano via tutto quello che c’era prima: sappiamo che molti artisti e generi possono sopravvivere senza problemi dopo che la loro ondata è passata. Però forse sul lungo periodo ogni tanto c’è un’onda anomala, magari originata da cause eccezionali. Può darsi che sia presto per parlarne, ma sotto sotto la sensazione che il 2020 sia l’anno di un’onda anomala, ce l’ho”.
(Riccardo Vitanza, direttore dell’ufficio stampa Parole & Dintorni e docente del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica, Milano)
Il Covid-19 sta cambiando il pianeta in un bel po’ di modi. E da più parti si è ragionato sui cambiamenti che toccheranno al mondo della musica: da quelli più evidenti, ovvero le prospettive drammatiche per il comparto dei concerti, a quelli più sottili, ovvero la piccola ma documentata rivincita dei suoni acustici e vintage rispetto a quelli elettronici quando il pubblico si è ritrovato ad ascoltare musica tra le pareti di casa invece che in cuffia, in metropolitana, e soprattutto quando l’appetito insaziabile delle giovani generazioni per musica di pronto consumo si è scontrato con il rallentamento nella produzione industriale di hip-hop e pop. Ma c’è un’altra componente che potrebbe risentire di mutamenti importanti, ed è l’immagine dei musicisti. Da anni l’equilibrio tra musica e “fattore X” ha visto il secondo prendere il sopravvento, e nella popolarità di un artista quella che chiamiamo abitualmente coolness (se poi siete veramente cool, da qualche anno la chiamate swag) viene prima di qualunque altra cosa.
E prima che qualcuno scuota la testa indignato: no, non è sempre stato così. Non nella stessa proporzione. Banalmente: la sera in cui Elvis Presley divenne un fenomeno, la sua prima canzone era stata semplicemente trasmessa per radio, e la gente aveva iniziato a subissare la stazione di telefonate. Nessuno lo aveva visto. Certo, poi lo videro e fu altrettanto importante, nessuno lo nega. Ma in un’epoca in cui i brand sono un riferimento essenziale per la musica, sia per interessata filantropia sia per riferimento aspirazionale, non vorremmo perdere troppo tempo a cavillare: è legittimo chiedersi se cambierà il modo di – come dire? – tirarsela. Se la musica è diventata, come decretano nel film Almost famous i critici-star Cameron Crowe e Lester Bangs, “l’industria di ciò che è figo” (in originale, appunto, “industry of cool”), può essere interessante fare delle ipotesi sul futuro. Prima però, come sempre, partiamo dal passato. Perché, per citare un altro film, “ti pareva che prima non c’era il documentario” (Prendi i soldi e scappa).
Birth of cool(ness)
Ai musicisti del passato remoto, l’idea di far parte dell’industria di ciò che è figo sarebbe risultata del tutto improbabile. Né i musicisti né i compositori più in voga erano considerati fighi. A spanne, potremmo dire che, con tutto il rispetto per Orfeo (che era un mito – ma per l’appunto, è un mito), la faccenda inizia con il Romanticismo. Fino a quel momento anche i più apprezzati, quelli che oggi consideriamo tra i giganti della musica classica, non erano visti come star ma come importanti artigiani in cerca di ingaggi: se andava bene diventavano dipendenti di un principe e gli impreziosivano la vita, come i cuochi o i decoratori. Se andava benone e non c’erano guerre, si guadagnavano un certo apprezzamento in quella nobile bolla. Ma dal Romanticismo in poi il musicista inizia a proiettare un’immagine di sapiente superiorità, di stile e carisma, a risaltare come una figura necessariamente più avanti degli altri. Le Muse che lo ispirano gli suggeriscono in anticipo la strada che tutti gli altri stanno per prendere – anzi, tra i suoi compiti c’è proprio quello di essere tra i primi a mostrarla, assumendosi anche il merito di averla esplorata quando nessuno ci credeva.
Però, altrove, la coolness esisteva già. Ovviamente non si chiamava così: l’utilizzo dell’aggettivo cool per indicare chi era più consapevolmente elegante degli altri è fatto risalire agli anni Trenta del secolo scorso, all’interno delle comunità afroamericane. Ma forse c’era coolness anche in Petronio, probabile autore del Satyricon: già duemila anni fa mal tollerava l’ineleganza dei suoi concittadini più agiati ed era indicato da Tacito come arbiter elegantiae. E l’espressione che Leonardo Da Vinci dipinse sul volto di Mona Lisa è considerata un esempio di sprezzatura, l’aristocratico distacco che si sostanzia in un mezzo sorriso di compatimento. Cinquecento anni dopo la morte dell’artista italiano, Beyoncé e Jay-Z hanno affittato il Louvre per girare il video della loro canzone Apeshit. Una composizione che, malgrado l’adorazione dei tanti adoratori della coppia, risultava imbolsita già 500 secondi dopo il primo ascolto – però il video, al contrario, conteneva diverse intuizioni sul rapporto tra arte occidentale e cultura afroamericana. E programmaticamente, iniziava e finiva con i coniugi Carter inquadrati (sprezzanti) davanti alla Gioconda.
Da anni l’equilibrio tra musica e “fattore X” ha visto il secondo prendere il sopravvento, e nella popolarità di un artista quella che chiamiamo abitualmente coolness (se poi siete veramente cool, da qualche anno la chiamate swag) viene prima di qualunque altra cosa.
La blackness si intreccia volentieri con la coolness. Secondo lo storico dell’arte R.F. Thompson (non nero, non precisamente giovane), il legame va ricercato nell’atteggiamento spirituale che le etnie africane Yoruba e Igbo condensano nella parola itutu, e che portava a uno sguardo di ostentata superiorità di molti prigionieri davanti ai loro schiavisti, come risposta alla sottomissione e all’umiliazione. Secondo gli storici del jazz, invece, a portare la parola cool nella musica è stato, per verdetto quasi unanime, il sassofonista Lester Young negli anni Quaranta. Nel libro The Birth (and Death) of the Cool, il critico californiano Dana Gioia ha portato testimonianze di come Young soleva usare il termine per suggerire ai suoi musicisti come dovevano suonare. Finché a un certo punto quello destinato a essere il jazzman più cool di tutti ebbe un’intuizione.
Accadde nel 1957, quando Miles Davis intitolò uno dei suoi dischi decisivi Birth of the Cool. Era il manifesto di un jazz più misurato, contrapposto a quello della tradizione ma anche al bebop nervoso, umorale, esplosivo e veloce. In quel momento l’aggettivo cool era ancora legato alla bassa temperatura, rivendicata rispetto alle impennate hot che erano il minimo sindacale nella musica di quel periodo, dal jazz al rock’n’roll. Con l’adesione al cool jazz di vari altri musicisti, specialmente bianchi si scatenò una sorta di diatriba. A qualcuno piace caldo, ricordava Billy Wilder in un film (del 1959) i cui protagonisti suonavano e vivevano con intensità rocambolesca. I due concetti contrapposti iniziarono ad attecchire a livello linguistico, finendo per creare una giustapposizione come tra Yin e Yang: ancor oggi la donna irresistibile è hot, l’uomo che sa il fatto suo è cool. Peraltro, si può dire che la coolness è una strategia soprattutto maschile, almeno nella musica. Bisogna pensare un po’ più a lungo per farsi venire in mente esempi femminili di elegante distacco misto a sprezzante insofferenza: tra le dive, più che la già citata Beyoncé – lei è queen, che non è proprio la stessa cosa – sembrano candidarsi Rihanna e, con la tipica affettazione da torch singer vecchio stile, Lana Del Rey. Ma alla fine del decennio fatalmente si è imposta all’attenzione una nuova star globale che forse è persino più interessante come esercizio di coolness femminile (e generazionale) che come musicista.
A suo modo, Billie Eilish è una reazione alle divas spettacolari dell’ondata precedente, da Lady Gaga a Katy Perry. È la rivolta contro la perfezione pop di Taylor Swift e Ariana Grande. Con sguardo implacabilmente annoiato, le tute sformate e la voce così sprezzante da diventare apertamente un rantolo, all’interno di un’estetica da cameretta (memorabile il numero live del letto che inizia letteralmente a fluttuare sul palco quando canta I Love You), forse già nel 2019 stava indicando quello che ci aspettava nel nuovo decennio. D’altra parte, potrebbe essere stato altrettanto preveggente il giovane rapper italiano che ha fatto il botto in autunno ed è tuttora in top ten quasi un anno dopo con il suo primo album: ThaSupreme, si dice, esce raramente di casa. E non si fa vedere in pubblico se non come ologramma o cartoon.
Un concetto fluido
“Speranza è sia entertainment sia real. È ignorante ma non è fake”.
(Gué Pequeno sceglie gli aggettivi durante un’intervista a Rolling Stone, giugno 2020)
Che la coolness conosca notevoli variazioni a seconda del contesto non è ovvio come sembra, perché si è portati a considerare delle costanti. Per esempio, da anni la gioventù ci pare un accessorio inevitabile, ma ai tempi di Frank Sinatra era importantissimo sembrare adulti. Possibilmente, adulti ricchi ed eleganti: i ragazzi non avevano soldi, non avevano voce in capitolo su nulla, e in generale a rimorchiare erano quelli (e quelle) con l’aria più navigata ed esperta. O, ai tempi del punk rock, al di là delle creste e dell’attitudine, un requisito decisivo era la velocità. Persino i Police di Sting si presentavano con canzoni lanciate a cento all’ora come Fallout o No Time This Time, il cui incedere forsennato è completamente estraneo ai bpm odierni, incluso il relativo declino della techno. Poiché i duri non ballano, come ammoniva Norman Mailer, il rap, pur essendo nato da una costola della disco come genere da ballo, è ormai tendenzialmente imballabile, e lascia volentieri tale attività al genere latino (a cui, in previsione dei problemi futuri nel ballo strusciato, facciamo tanti auguri). La lentezza è talmente in auge che il Rap God Eminem, che di recente ha superato il suo record nel brano Godzilla (10,65 sillabe al secondo), è guardato da molti giovani come un cinquantenne che fa il fenomeno. Questo anche perché, in un genere che un tempo rispettava i maestri e imponeva la conoscenza della history, la trap ha creato la fatidica rottura: per i nuovi ascoltatori, conoscere i grandi della old school non è più necessario. E un’altra cosa che non è necessaria è il bagno di folla per decretare chi è la Greatest Rock’n’Roll Band In The World, o il Boss, o il Komandante. Non è più un requisito, è una cosa per boomer. I tour più visti degli ultimi dieci anni sono quasi tutti di vecchie rockstar (anche in Italia, dove Vasco Rossi resta il re incontrastato), a ribadire che il carisma della vecchia scuola è diverso da quello dei big attuali, soprattutto quelli del rap: mediamente un concerto di Kanye West o Post Malone si svolge davanti a 15.000 persone. Il rap non è mai stato un genere da stadio, non ha mai voluto esserlo, e c’è sempre stato un tipo diverso di rapporto (più individualista, meno collettivista) con il pubblico. Per i fan delle nuove generazioni (che seguano il rap o quel che rimane del pop) gli spettatori paganti contano meno dei numeri su Spotify e YouTube, e alla star non è necessaria l’uscita dal pianeta in cui vivono da monarchi assoluti, mostrato nei video o su Instagram. Ma cosa accade se l’intero pianeta, quello in cui vivono tutti, vede cambiare i suoi punti di riferimento?
Nel lockdown della primavera 2020, chi aveva un’immagine di tipo tradizionale non ha necessariamente sofferto: negli Stati Uniti il country ha confermato di essere la vera alternativa al rap, anche in un mercato in cui lo streaming prevale in modo schiacciante sul cd. Mostrarsi intenti a cantare dal ranch o accanto al caminetto (Neil Young, vecchia lenza, ha fatto entrambe le cose) è stato del tutto naturale per le star del genere e per il loro pubblico. Al contrario Madonna, per più decenni trendsetter del pop, ha fornito performance casalinghe quanto meno sconcertanti. E le esibizioni da casa di Lady Gaga, Rita Ora, Charlie Puth, Lizzo, John Legend hanno reso l’evento One World: Together At Home quasi inquietante – non a caso, nessun rapper ha voluto partecipare, intuendo l’altissimo rischio di non risultare fighissimi nemmeno esibendosi dalle proprie Lamborghini ostentando Rolex e capi di Gucci verso le webcam. Non ci hanno nemmeno provato: forse i manager li hanno sconsigliati di scendere di un gradino, e non hanno saputo consigliare alternative.
C’è allora da chiedersi se, accanto al contraccolpo per i musicisti della old school, non se ne possa verificare un altro per le star del decennio appena concluso, costrette a reinventare una narrazione del proprio glamouroso successo che era diventata così centrale da favorire anche chi la contraddiceva nel modo più vistoso: outsider come Ed Sheeran, Adele, Lewis Capaldi, la già citata Billie Eilish – e per certi aspetti, da noi, Ultimo, Coez e tutti gli indie più stropicciati (i Pinguini Tattici Nucleari, a sei mesi da Sanremo, sono gli unici a lungo nella top ten completamente rappizzata degli album più ascoltati in Italia). Nel clima di incertezza, la maggior parte dei nomi consolidati ha preferito non fare dischi. Qualcuno non ha avuto paura ma forse vista la débâcle nelle vendite avrebbe dovuto averne (Drake, Lady Gaga, Justin Bieber). In Italia, solo con l’estate sono usciti allo scoperto alcuni grossi nomi, ma pochi con album (Gué Pequeno, premiato dal pubblico): la maggior parte ha scelto di buttare un singolo nella malsana palude dei tormentoni estivi. Interessante notare come negli Stati Uniti, gli album rap che hanno continuato a battere cassa accanto agli immancabili giri d’onore (postumi) per i rapper morti anzitempo (Pop Smoke, Juice Wrld) sono quelli usciti al massimo ad aprile, prima che la situazione degenerasse. A fare qualcosa di nuovo in piena quarantena è stato Travis Scott, appoggiatosi a un alter ego virtuale per dare un breve concerto all’interno del videogame Fortnite. In breve: l’esatto contrario di un’esibizione su Zoom. È un avvertimento ai colleghi? È lui l’artista d’avanguardia che indica la strada da prendere? Bisogna investire sul digitale più che sul reale?
Dibattito!
Secondo Luca Fantacone, international marketing director di Sony Music Entertainment, “il fattore decisivo per l’operazione di Travis Scott, che ha subito impattato in modo significativo anche sui suoi ascolti in streaming, è stato attirare il pubblico in un’esperienza visiva e sonora nuova, quasi psichedelica, diversa da giocatore a giocatore. Tutti quelli che hanno assistito hanno detto che non avevano mai visto qualcosa del genere, e io stesso che in trent’anni ho visto migliaia di concerti mi sono sentito come al concerto degli U2 dello Zoo Tv Tour”. Tuttavia, non è un’opzione consigliabile a tutti. “Ogni artista ha un suo rapporto con il pubblico, basato su un equilibrio tra ciò che si vuole far vedere e ciò che non si ritiene di comunicare, tra accessibilità e mistero. È ovvio che nella prima fase del lockdown c’era curiosità per l’accorciamento delle distanze, nel vedere il musicista su Zoom in salotto o sul balcone. Ma è difficile pensare che la cosa possa durare. Nel caso, in Italia sarebbe un problema per molti, sia artisti sia ascoltatori, perché siamo un Paese dove la presenza fisica e le attività promozionali sono piuttosto importanti, tant’è che gli instore tour erano una parte importante del mercato. Ora l’hype, l’eccitazione nei confronti dei cantanti, potrebbe spostarsi a favore di altri canali, penso a TikTok. Che decisamente non è per tutti”.
“Credo che nella musica si andrà giocoforza verso un maggiore livello di entertainment. E naturalmente, con la riduzione delle possibilità di monetizzare il lavoro musicale, avremo sempre più canzoni scritte pensando a Puma, Adidas, Nike o Gucci. Per le vecchie generazioni magari sarà un trauma, almeno quanto il ridimensionamento dei concerti o la loro completa assenza, ma per le nuove non credo”.
Già, TikTok. Come suggerisce il nome, era una specie di bomba a orologeria già prima della clausura. Ora, Trump permettendo, sembra minacciare le star di Spotify sulla falsariga di quello che i Buggles prevedevano quarant’anni fa in Video Killed the Radio Star. Con i suoi brani brevissimi e i suoi balletti scattosi popolarissimi tra i giovanissimi (una fascia tra gli 8 e i 14 anni), ha lanciato “dal basso” la hit mondiale Old Town Road dell’esordiente Lil Nas X (diciannove settimane al numero uno negli Stati Uniti. Ripetiamo: diciannove, più di un terzo del calendario). Ma anche da noi quest’anno ha permesso un’impresa che era quasi impensabile nel 2019: ha portato per la prima volta una rapper femmina al numero uno in Italia (Anna Pepe, con il singolo Bando). Per Riccardo Vitanza, il social cinese sta dando un’ulteriore spinta verso la suddivisione del pubblico in fasce di età. “Lo streaming per i ragazzini di 10 anni è già vecchio, i loro miti verranno da TikTok. Ma così come con i social, le nuove star possiedono di default tutte le caratteristiche per piacere a chi usa un nuovo mezzo, io per esempio lavoro con Random, Riki e Jamil e so che essendo nativi dei social più recenti non hanno bisogno che qualcuno insegni loro a usarli. Ma in generale credo che ogni mezzo avrà un suo target generazionale, da quelli più nuovi fino agli ultimi lettori di giornali, e ognuno avrà un appeal connaturato a quel mezzo”. Ma ci saranno ancora personaggi transgenerazionali? “Qualcuno riuscirà a proporsi al livello superiore, anche grazie alle meccaniche dei media: già ora media tradizionali prendono la star dei nuovi media, ne registrano l’affermazione, poi lo consacrano verso una notorietà più ampia, gli portano co-branding e sponsorizzazioni, possibilità di featuring con altri o un ruolo di giudice a X Factor. Anche per questo vedremo sempre più vie di mezzo tra artisti e influencer”.
Uno che si muove tra media digitali e tradizionali è Pino Gagliardi, direttore editoriale di TimMusic e media director di ArtMediaMix, azienda che opera su promozione musicale ed eventi. “Credo che nella musica si andrà giocoforza verso un maggiore livello di entertainment. E naturalmente, con la riduzione delle possibilità di monetizzare il lavoro musicale, avremo sempre più canzoni scritte pensando a Puma, Adidas, Nike o Gucci. Per le vecchie generazioni magari sarà un trauma, almeno quanto il ridimensionamento dei concerti o la loro completa assenza, ma per le nuove non credo, del resto la comunicazione e il marketing sono già impliciti nella narrazione delle nuove star. Anche i concetti di sold-out e dischi d’oro sono da tempo un fatto di comunicazione, un messaggio ai fan ma soprattutto a sponsor o giornalisti, che nel bombardamento di input non si prendono nemmeno la briga di verificare. Però non mi meraviglierei se alcuni degli artisti più popolari tra gli adulti riuscissero a reinventarsi di nuovo. In fondo, è già capitato che i grandi rincorressero i piccoli, quindici anni fa nessuno avrebbe pensato a Renato Zero o Francesco De Gregori che facevano gli instore tour, o che Morandi e Mannoia imparassero a usare i social. Quando emergono nuove modalità, una parte di quelli che arrivavano al pubblico prima, impara presto ad arrivarci comunque”.
Caspita, è proprio come dicono quelli che ne capiscono: il messaggio si adegua al mezzo, ma soprattutto al mercato. Ma se sugli aspetti pratici qualcuno si sbilancia, sul lato dello stile è già più difficile. Interpellata in merito, la redattrice di un periodico che sulla coolness ha costruito una reputazione planetaria preferisce non compromettersi. “Ci ho pensato parecchio e non mi viene in mente niente di sensato da dire al riguardo, non credo di essere in grado di fare previsioni, nel senso che sia la strada dell’understatement sia quella della stardom sono entrambe possibili, non mi sento di escluderne una e non ho granché di interessante da dire”. Ok. È una posizione legittima ma un po’ deludente, no? Non vi sembri strano se non facciamo nomi. Ma va detto che la prestigiosa rivista francese (musicale e non solo) Les Inrockuptibles, che ogni settimana si chiede “Où est le cool?”, ultimamente dà risposte che sembrano quasi parodistiche: dal maggio 2020 ci è stato detto di volta in volta che il cool è nel metal, in una cucina pop e politicamente consapevole, nello stile post-sovietico, nell’autorappresentazione spontanea (e ironica) del performer Adam Ray Okay su TikTok, nell’intimità destrutturata della stilista Hélène Mastrandréas. Non dev’essere un lavoro facile.
Azzarda qualche ipotesi più tangibile Claudio Ferrante, fondatore e presidente della società Artist First, che distribuisce musica e ha scoperto prima delle major le potenzialità di Salmo, Ermal Meta e TheGiornalisti – ed è in classifica da 90 settimane con l’album di Gazzelle. “Una cosa già si è espressa con i social come con TikTok, e proseguirà se il Covid continuerà a selezionare nuove modalità di interazione con i musicisti. Ed è che la gente ama scoprire gli artisti e innamorarsene, applicare loro la sua narrazione, non farsela imporre. Li vuole scoprire, ed è pronta a seguirli in modo più intenso. I social contribuiscono a far sentire più vicino e più vero chi non arriva dai media tradizionali. E anche (speriamo) senza un altro lockdown, la componente social nella musica è destinata ad aumentare. Probabilmente il concetto di coolness cambierà di conseguenza, sia nella musica che nell’immagine, perché si è concretamente interrotta la percezione dell’urban style come riflesso della velocità e fascino delle città. In Italia Milano aveva definito una sua coolness, e Roma un’altra: la coolness di Milano era stata fatta propria dal rap, con un rapporto di dialogo continuo con la città che corre e procede in avanti, offre cose da fare ogni sera, insegue ciò che è figo e lo rinnova di continuo, insomma la Milano che non si ferma come ha tentato di ribadire lo sfortunato slogan di qualche tempo fa. A Roma aveva invece preso piede una coolness rilassata che si era specchiata perfettamente nell’indie pop. In entrambi i casi la limitazione delle possibilità, la mancanza di compenetrazione tra musica e tessuto urbano – niente concerti, niente discoteche – può portare due opzioni, forse anche simultanee: qualcuno continuerà a non uscire di casa, qualcuno lo farà più di prima. Ma è altamente possibile che l’impatto si senta, e la coolness troverà un altro percorso, molto probabilmente sarà ridimensionata. Durante il lockdown di primavera c’era abbondanza di musica sui social e si è innalzato il valore dell’engagement dell’artista su Instagram. Sono aumentate le dirette e hanno coperto la voglia di ascoltare l’artista; hanno avvicinato tantissimo l’artista al fan, alcuni hanno avuto la possibilità di interagire con il cantante davanti a tutti. Questo tipo di esperienza può funzionare per gli artisti portati all’interazione, ma può essere disastrosa per altri, che dovranno ricorrere al distacco, all’irraggiungibilità – sperando che funzioni ancora: non è detto. Il codice estetico ha ricevuto uno scossone: i video casalinghi hanno riportato al valore delle idee”.
Idee?
“Il momento che stiamo attraversando è turbolento ma ci offre la possibilità unica di aggiustare quello che non va, di togliere il superfluo, di ritrovare una dimensione più umana. Questa crisi è anche un’opportunità per ridare valore all’autenticità: basta con la moda come gioco di comunicazione. Basta con le idee blande e con gli sprechi di denaro per gli show, sono solo pennellate di smalto poste sopra il nulla”.
(Giorgio Armani, 14 aprile 2020)
Qui potrebbe essere utile ricordarsi (per chi c’era) di come Mtv, inaugurata programmaticamente dalla canzone Video Killed the Radio Star, già citata, abbia cambiato nella sua ormai lontana epoca d’oro alcuni canoni del rock e del pop, indubbiamente ricalibrando l’estetica e favorendo le carriere di alcuni nomi nuovi (Madonna, Duran Duran, Depeche Mode), ma non per questo estinguendo i veterani – anzi, favorendo sorpassi insospettabili. Sullo schermo tv Aerosmith e ZZ Top (altre vecchie lenze) funzionavano meglio non solo dei Rolling Stones, ma pure di David Bowie, da sempre attento alla propria performance visuale e mediale; il reduce del prog-rock Peter Gabriel aveva le stesse richieste di un idolo teen, “nativo videomusicale”, come George Michael. In definitiva, se il video è destinato a dettare (di nuovo) legge, potrebbe esserci una nuova corsa ad attirare l’attenzione degli spettatori, nei tempi ridottissimi di un video su TikTok o in dirette social già pensate per essere frazionate in meme o gif da condividere. Dai telegenici passeremo agli zoomgenici o ai memegenici, e la nuova coolness sarà dei più predisposti.
Ma tornando alla Francia, dove (malgrado il termine anglofono) alla questione della coolness sono molto interessati, il saggio di Isabelle Barth e Renaud Muller La Coolitude comme nouvelle attitude de consommation decreta che il cool contemporaneo è comunque inseparabile dalla società dei consumi. Nessun produttore, malgrado i proclami che invitano a essere originali e distinguersi, guadagna realmente da una massa in cui tutti si distinguono. Uno dei risultati è che i musicisti sembrano sempre più gli spocchiosi interpreti di spot pubblicitari tutti uguali (e sempre più spesso, del resto, lo sono). Per paradosso, un’attitudine nata per difendere la propria individualità approda a un iper-conformismo, mascherato dalla chiave ironica ormai immancabile e studiata a tavolino, per dissimulare meglio che tutto è artefatto. “Oggi anche questo fa parte dei meccanismi della coolness, così ovvi che chiunque è in grado di riprodurli”. Ma la coolness, dicono anche, non è un elemento primario, non è un’esigenza viscerale. Il rock’n’roll, come prima di lui il jazz e dopo di lui il rap, nasce come ballo, poi diventa esigenza espressiva, infine diventa stile e vira verso la coolness (per jazz e rock, lo stadio successivo è l’implosione. Per il rap, vedremo: ha più di quarant’anni e non sono pochi).
Mentre scriviamo, serpeggia la deprimente paura di un secondo lockdown. Per scaramanzia verrebbe da non dirne nulla (anche per fare bella figura se, come speriamo, non dovesse succedere). Ma per completare il ragionamento, se effettivamente la coolness è un bisogno secondario, allora nel momento in cui si ha a che fare con altre esigenze più pressanti può persino essere messa da parte. Uno show business senza coolness – ehi, questo sì che sarebbe uno spettacolo. In ogni caso, da tempo la coolness è diventata sempre più prevedibile. Forse ci sarebbe bisogno di un’onda anomala che ce ne liberasse. Ma sapremo veramente farne a meno?
Paolo Madeddu
È di Milano. Collabora con aMargine, Rolling Stone, HvsR e TRX Radio. Possiede una televisione.
Vedi tutti gli articoli di Paolo Madeddu


