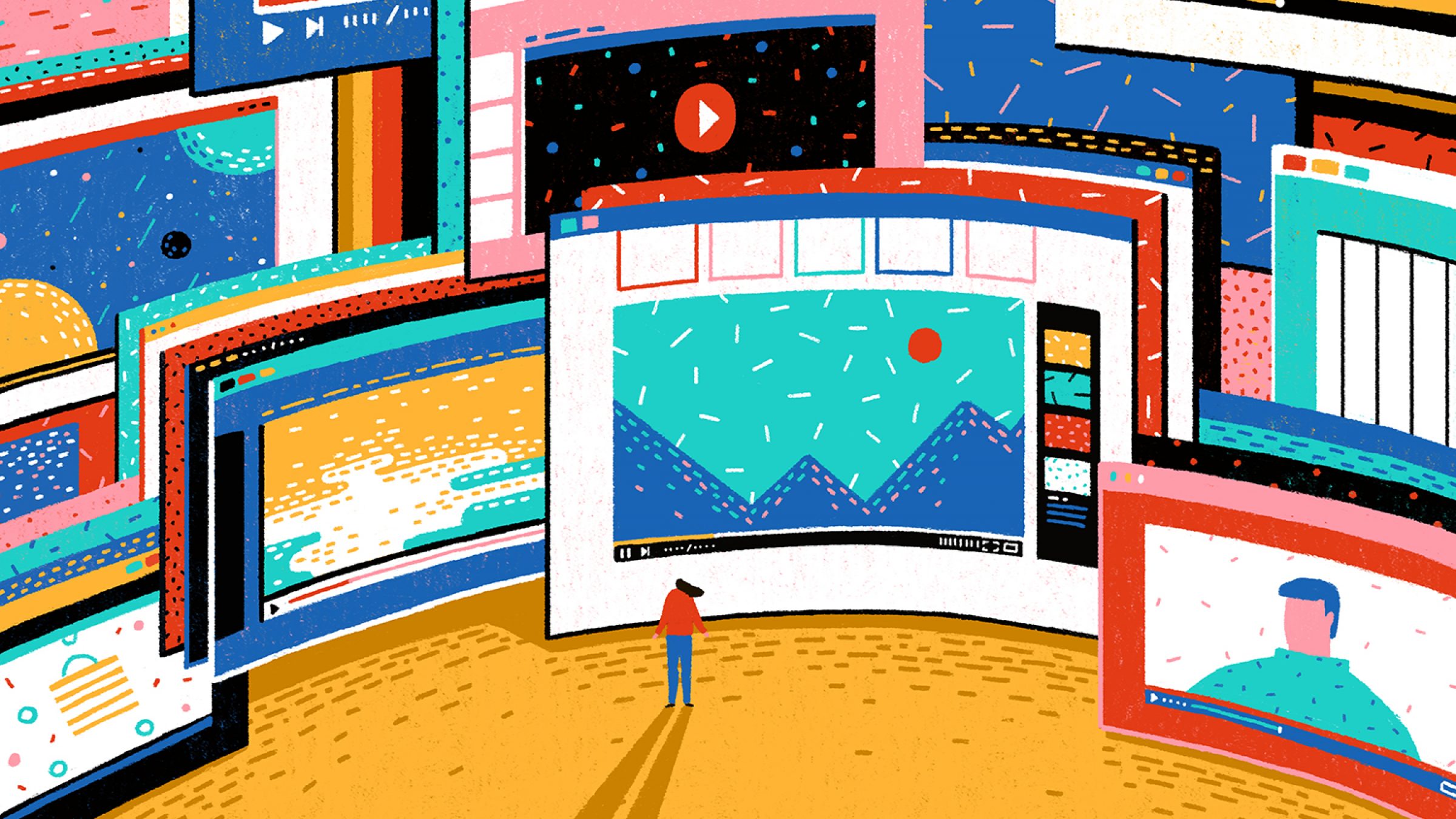
Ventennio dopo ventennio, la tv italiana è cambiata profondamente. E in questa dinamica un ruolo non secondario è svolto dalle abitudini. Che stanno cambiando, eccome.

Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 22 - Mediamorfosi 2. Industrie e immaginari dell'audiovisivo digitale del 11 dicembre 2017
Ci sono momenti nella storia in cui si aprono squarci, a volte immediatamente visibili, a volte impercettibili almeno al primo sguardo. Non solamente momenti di transizione ma di frattura, i quali permettono a chi li nota, e ne fa oggetto di riflessione, di guardare diversamente agli scenari futuri e di leggere diversamente il passato: perché, come un sisma che apre le montagne, fanno venire alla luce stratificazioni precedentemente nascoste. È quanto sta accadendo in uno dei campi del vivere umano insieme più cruciali e più difficili da mettere a fuoco: le abitudini, che spesso sfuggono all’attenzione proprio in ragione del loro essere date per scontate, del loro collocarsi sullo sfondo del vivere, del loro contare sugli automatismi più che sulla consapevolezza. A renderle poco visibili e spesso sfuggenti, insomma, sono proprio gli aspetti a cui devono il potere di confezionare i comportamenti. Dire che “le abitudini non sono più quelle di un tempo” può sembrare una battuta, ma contiene qualche verità non banale, che riguarda in modo molto significativo tutte le consuetudini di consumo, in particolare quello di comunicazione e di spettacolo.
Il cambiamento delle caratteristiche, e in parte della natura stessa, delle abitudini della quotidianità è in effetti un grande mutamento in corso, poco notato appunto perché ha luogo in quella parte dei nostri giorni che spesso viviamo in modo subliminale. Qui prenderò le mosse dagli indizi che segnalano la trasformazione in corso, e dal suo significato complessivo. Muoverò poi all’indietro, a una riflessione sul ruolo delle consuetudini in generale nel medium televisivo, ma anche e soprattutto sulle diverse forme assunte nel tempo dal mercato tv in relazione al loro mutare. Tornerò poi, alla fine, alla situazione attuale, e a chiedermi, da un lato, se non ci siano controtendenze a questo processo, e, dall’altro, che cosa possa significare per il futuro.
La forza dell’abitudine, vista da oggi
Non sono molti i filosofi e i teorici che si sono interrogati su questo aspetto del vivere umano, forse proprio per la sua apparente umiltà. È stato il pragmatismo americano, una scuola psicologico-filosofica a lungo marginalizzata dal prevalere del pensiero idealistico in Europa e di quello analitico nel mondo anglosassone, a osservarne con maggiore perspicacia la forza e le radici.
Fu prima di tutto William James, nei Principles of Psychology del 1890 e poi nel 1914, in un volume dal titolo appunto Habit, a osservare: “L’abitudine è il grande manubrio [oggi forse diremmo volante] che guida la società […] quanto maggiore è la parte dei nostri comportamenti che possiamo affidare alla cura pigra dei suoi automatismi, tanto più libereremo la nostra mente per dedicarsi a compiti più elevati”. Nel 1922, James Dewey, in The Public and Its Problems, riprende il pensiero di James, in parte articolandolo ulteriormente: “Per struttura organica l’uomo è fatalmente soggetto alla formazione di abitudini; infatti che lo si voglia o no, che se ne sia consapevoli o no, ogni atto determina un mutamento di atteggiamento e di tendenza, che condiziona la condotta futura. Le abitudini ci costringono ad agire in modo ordinato e stabile: le cose alle quali siamo abituati determinano infatti in noi un senso di tranquillità, ci danno una sensazione di controllo”. Per James, la forza dell’abitudine sta soprattutto nel risparmio, di tempo e di sforzo mentale, dovuto ai suoi automatismi. Dewey aggiunge un altro elemento: l’abitudine è un fattore ordinante, che contiene e contrasta l’instabilità implicita di un vivere in sé sempre mutevole; e per questo rasserena, anche in quanto dà a chi la segue l’impressione di essere “al volante” – appunto – della propria esistenza. Proviamo a tener conto di queste riflessioni per capire ciò che accade.
Che il ruolo delle abitudini e il loro peso si stia per certi versi modificando, e anche contraendo, è dimostrato da molti indizi. Uno è la caduta della cosiddetta “fidelizzazione” presso diverse istituzioni che per un lungo tempo avevano contato proprio sul carattere consuetudinario del loro rapporto con la clientela, a cominciare dalle banche; oggi in molte delle maggiori istituzioni finanziarie, non solo in Italia, vi è un crescente allarme per la volatilità dei comportamenti degli utenti. Analogamente il prevalere dell’effetto-novità sull’effetto-abitudine si nota nell’organizzazione del commercio, con il moltiplicarsi dei pop-up store al livello più elevato del mercato, e degli outlet temporanei a quello più economico, senza dimenticarsi del commercio online. E si nota anche in un campo più vicino a quello che ci interessa, nella radio, un tempo (e in parte ancora) il più abitudinario dei media: fruita a lungo soprattutto negli stessi luoghi a cominciare dall’auto, e sugli stessi canali, ora la radio è soggetta a una moltiplicazione di scelte anche per l’immensa offerta su internet, non solo e non tanto di web radio quanto di vie di accesso a tutte le possibili emittenti.
Anche in campo televisivo si notano segnali importanti nello stesso senso, da una decina-quindicina d’anni: il declinante potere degli appuntamenti regolari di palinsesto, in particolare nelle giovani generazioni, e l’affermarsi di forme di consumo “irregolari”, dal binge watching alla fruizione via YouTube di titoli non ancora distribuiti. Del resto molta della nuova offerta televisiva, dai canali a pagamento a Netflix, è basata sì su una programmazione, ma conta anche su forme di consumo meno abitudinario di quello tradizionale delle “grandi” emittenti.
A che cosa si deve un simile cambiamento? Prima di tutto ricordiamoci della notazione di William James: abitudine come risparmio. Possiamo parlare, in altri termini, di una sorta di economia delle consuetudini, tanto più necessarie quanto maggiore è il costo (in termini di sforzo, ma anche di tempo e di conoscenze) richiesto dai comportamenti che se ne distaccano. Un esempio particolarmente evidente è quello della radio che si richiamava prima: per molto tempo la pigrizia nel cambiare canale è stata legata, anche se non soprattutto, alla fatica richiesta dal ritrovarlo una volta “perso” sul sintonizzatore. Una delle caratteristiche del nuovo ambiente informazionale, a partire dal web, è proprio la riduzione dei costi di questo tipo, grazie alla facilità di accesso all’informazione e alla sua abbondanza. Così è diventato facile informarsi sulle offerte e sui servizi diversi da quelli della “nostra” banca tradizionale, e anche (sebbene un po’ meno) spostarsi a un’altra; e confrontare i prezzi tra negozi diversi magari tutti nella stessa zona, eccetera. E basta un tocco di dita per accedere a qualsiasi radio senza cercare il canale nella maniera tradizionale. O per trovare la nostra serie preferita, magari le puntate che abbiamo perso, senza aspettare le scadenze della programmazione, e organizzando il consumo diversamente da quello classico. Non a caso i modelli di offerta di molti canali stanno diventando sempre più simili a quelli del web. Anche per venire incontro a esigenze radicate soprattutto nei più giovani.
Un aspetto di rilievo del mutamento in corso riguarda in effetti la diversità di comportamento delle varie generazioni: sebbene manchi una ricerca approfondita e di largo raggio, l’impressione è che il peso delle attività consuetudinarie decresca in linea con il decrescere dell’età. Non tanto per una sorta di vocazione innata al nuovo, come vuole una stucchevole retorica, quanto perché un cambiamento di mentalità come questo, semplicemente, richiede un adattamento che si svolge nel tempo e che è tanto più facile per coloro che meno si sono irrigiditi nei costumi passati, che meno sentono (almeno a prima vista) il bisogno di quel fattore ordinante di cui parlava Dewey. Forse, si può andare anche oltre. Come hanno intuito Marshall McLuhan e sulla sua scia Joshua Meyrowitz, il processo di elettrificazione prima e la comunicazione elettronica poi (e naturalmente possiamo aggiungere il culmine del suo avvento, la digitalizzazione) hanno favorito una trasformazione apparentemente paradossale: da un modello “neolitico” centrato sulla coltivazione dell’informazione in spazi e tempi definiti secondo regole precise, a uno “paleolitico”. Siamo “like the most primitive Paleolithic man, once more global wanderers, but information gatherers rather than food gatherers”, scriveva appunto McLuhan. In un nuovo ambiente informazionale caratterizzato dall’abbondanza, dall’accessibilità, dalla mobilità, tutto ciò che era stabile e stabilizzante lascia spazio a comportamenti di adattamento più aperti non solo in quanto meno bisognosi di sforzo, ma soprattutto in quanto meglio adeguati alle nuove condizioni.
Un mercato di consuetudini
Se questo grande e poco visibile cambiamento tocca profondamente la televisione, comunque, non è solo perché, come si è visto, introduce nuovi modelli di consumo, ma anche per un motivo più profondo, che riguarda l’economia stessa del mezzo. Si è a lungo detto che le emittenti commerciali (o pubblico-commerciali come la Rai) vendono ai pubblicitari le “teste” degli spettatori, o il loro tempo di attenzione. In realtà, sia Google sia le emittenti televisive vendono “teste” e attenzione. Ma lo fanno in modo diversissimo. Non solo perché, come spiega qualsiasi esperto di marketing, il primo vende “profili” e le seconde statistiche, in altri termini il primo ci vende al dettaglio e le seconde all’ingrosso. Ma anche perché si agganciano a diversi tipi di comportamento.
Google (come del resto quasi tutti i giganti del web, da Facebook ad Amazon) si colloca lungo il percorso dei cacciatori e raccoglitori per intercettare le direzioni che prendono, un po’ come un casello autostradale collocato dove è più probabile che passino. Le emittenti tv commerciali registrano i dati sulle scelte effettuate oggi e sostanzialmente promettono che questi dati permettano di capire le scelte di domani. Entrambi, in certa misura, estrapolano l’attenzione futura degli utenti da quella passata, ma lo fanno in modi molto differenti. Google vende presunti “tipi” e personalità, nella convinzione e nella convenzione che in questo modo sia possibile predirne il comportamento; le emittenti commerciali vendono la presunta ripetitività delle scelte. Che il modello Google sia più scientifico e attendibile dell’altro è credenza diffusa, ma tutta da dimostrare. È vero piuttosto che il mercato della televisione commerciale è più “neolitico” dell’altro.
Così, la crisi attuale ci permette di leggere con maggiore chiarezza, proprio perché non possiamo più darlo per scontato, il peso che le abitudini hanno avuto nei decenni di storia della televisione, e del mercato che l’ha sorretta, e che possiamo sintetizzare in tre punti: 1. il radicamento del mezzo nella vita quotidiana e proprio nel luogo più quotidiano della vita di tutti i giorni, la casa; 2. la presunta passività dello spettatore, che porta con sé un forte automatismo dei comportamenti nel senso definito da William James; e 3. il carattere almeno in parte ritualizzato degli stessi comportamenti.
In sostanza, invece di parlare di una tv che vende “teste” dobbiamo parlare di un mercato delle abitudini, delle ricorrenze, delle pigrizie. Questo ci può fare pensare a un mercato stabile nel tempo, tendenzialmente immobile come appunto pensiamo siano le consuetudini. Ma sarebbe un errore: nessun aspetto della vita umana è realmente immobile, semplicemente i tempi del cambiamento variano, da processi di breve periodo ad altri di più lunga durata. Anche per questo ci serve riflettere sulla crisi in corso: perché ci fa capire che le abitudini possono cambiare, ci induce a chiederci se non abbiano subito altri momenti di passaggio, magari meno radicale, anche in passato. E se non si possa pensare la storia della televisione e del mercato televisivo italiano anche nei termini di una storia delle abitudini.
È questo che farò ora, dividendo la mia ricostruzione in tre ventenni, ciascuno attraversato dalle sue specifiche contraddizioni.
Le molte tonalità del grigio (1954-74)
“La televisione è capace di imporsi nella vita domestica con una forza stupefacente. Appena l’apparecchio viene collocato in casa e messo in funzione si nota l’azione di alcuni meccanismi di difesa, che non sono dovuti però a un rifiuto, ma solo a un effetto di choc che dev’essere in qualche modo superato. Comunque, quasi sempre, le difese vengono abbassate rapidamente, anzi fin troppo presto”. Mi ha sempre molto colpito l’osservazione di uno dei pionieri della televisione nella Germania degli anni Trenta, Kurt Wagenführ, perché descrive con precisione non solo quello che accadde al tempo, ma anche ciò che sarebbe accaduto con la penetrazione della tv in molte diverse culture, inclusa quella italiana. La televisione italiana nel suo primo ventennio, prima ancora che vendere abitudini, con i meccanismi peculiari di una istituzione pubblica e monopolistica, creò abitudini. Non lo fece da sola ovviamente, come vorrebbero molte rappresentazioni banalizzanti, ma lo ha fatto. Prendiamo il caso della lingua: contrariamente al diffuso luogo comune secondo cui la televisione avrebbe “insegnato” la lingua agli italiani, che serve anche a esaltare l’altro luogo comune della fase “pedagogica” del servizio pubblico, si attuò allora piuttosto un processo di acquisizione spesso inconsapevole dell’idioma nazionale. In questo processo, il ruolo della televisione fu decisivo ma indissociabile da quello delle migrazioni interne che in parte sradicarono i dialetti locali e in parte imposero la necessità di una lingua comune, da quello della radio e di una canzone sempre meno legata al vernacolo napoletano e sempre più in italiano (canzone del resto che il Festival di Sanremo rese televisiva essa stessa), e dal ruolo istituzionale e questo sì pedagogico dell’alfabetizzazione di massa e più tardi della scuola media unica. Un idioma nazionale in parte insegnato ma in parte assai maggiore acquisito, appunto come si acquisiscono le consuetudini.
Ancora più rilevante fu il ruolo della tv nell’organizzazione sociale del tempo, inclusa la ritualizzazione della pubblicità. Fin troppo è stato detto e scritto su Carosello, ma è indubbio che nel palinsesto della televisione pubblica, per quasi vent’anni, si trattò di una delle interpunzioni principali della giornata, alla pari con il (di poco precedente) segnale orario prima del telegiornale. Lo spalmarsi della pubblicità, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, anche in altri momenti della giornata non ne ridusse del resto, per diversi anni, il ruolo cruciale.
La rappresentazione di una televisione pubblica e in bianco e nero, con i suoi tempi rituali e massificati, rischia però di nascondere una tendenza che sembra a prima vista andare in direzione opposta. Gli anni Cinquanta e Sessanta sono stati il periodo della storia nazionale in cui le abitudini degli italiani sono cambiate di più. Non furono solo gli anni delle icone fin troppo celebrate, dalla Vespa alla Seicento (non pubblicizzate alla tv in quanto sembravano non aver bisogno di promuoversi), e della penetrazione del telefono, anche quello monopolistico e non pubblicizzato (del resto la domanda prevaleva ampiamente, comunque, sull’offerta). Furono gli anni del frigorifero e della lavatrice, delle calze di nylon e delle lamette usa e getta, delle bibite gassate e del confezionamento di cibi in precedenza venduti sfusi, a cominciare dal latte: e questi sulla pubblicità tv contarono, invece, per farsi accogliere e memorizzare, spesso puntando sull’accoglimento degli slogan nella conversazione quotidiana (“Chiaro? Limpido, Recoaro”, “Ullallà è una cuccagna”). Nuovi consumi e nuovi costumi, la cui diffusione coincise con la piena affermazione di un mercato di massa, avviato già negli anni del fascismo.
Mentre l’abitudine in generale, una volta affermata, sta sullo sfondo del vivere, il suo affermarsi e penetrare nel quotidiano, al contrario, è un processo assai complesso: richiede insieme la fascinazione del nuovo e l’accettazione dolce di ciò che diventerà quotidiano. La televisione si è rivelata un medium per molti aspetti ideale, da questo punto di vista: domestico e abitudinario ma ancora, all’epoca, carico di promesse, e incarnazione della novità esattamente come molti dei consumi che pubblicizzava. D’altra parte, a promuoversi in un mercato simile erano essenzialmente i maggiori protagonisti del crescente mercato di massa, quelle grandi aziende che potevano permettersi i costi imposti dalla Sipra (diretti e anche, com’è noto, indiretti, come le inserzioni obbligate in giornali di partito e simili), e che d’altra parte potevano puntare sulla tv per la penetrazione di usanze e oggetti in precedenza meno diffusi o del tutto sconosciuti: innovativi e massificati, anzi più innovativi proprio per l’universalità del loro imporsi.
La televisione italiana nel suo primo ventennio, prima ancora che vendere abitudini, con i meccanismi peculiari di una istituzione pubblica e monopolistica, creò abitudini. Non lo fece da sola ovviamente, ma lo ha fatto. Prendiamo il caso della lingua: contrariamente al diffuso luogo comune secondo cui la televisione avrebbe “insegnato” la lingua agli italiani, si attuò allora piuttosto un processo di acquisizione spesso inconsapevole dell’idioma nazionale.
Un ventennio a colori (1975-95)
La fine del monopolio ebbe luogo in un’Italia in parte diversa, quella degli anni Settanta. Da un lato il radicarsi dei consumi di massa (e il loro parziale mutare), dall’altro una retorica e una politica dell’austerità e della rinuncia: che tra l’altro incise anche sull’avvento della tv a colori, rimandato per anni proprio in nome della “serietà”. In realtà l’idea condivisa dai sindacati e da alcune forze di centro (fino al 1976), secondo cui il colore sarebbe stato un segnale inaccettabile di frivolezza, una “nuova abitudine” da scoraggiare, era l’altra faccia dell’apparentemente opposta caduta di barriere secolari, a cominciare da quelle relative alla pornografia. Così, mentre la Rai resisteva nelle sue sfumature di grigio, scavalcata nel colore dalle emittenti estere e dalle prime private, alcune tv si davano allo striptease di professioniste e dilettanti, e altre nelle ore notturne si spingevano fino all’hardcore.
A questo punto, la pubblicità poteva spalmarsi progressivamente su tutta la televisione, privata e man mano anche pubblica. L’ultima battaglia per contenerla fu quella che puntava a impedire l’inserimento di spot nei film, cara a una parte del mondo dello spettacolo (da Federico Fellini a Beppe Grillo), avviata nel 1989 e imperniata sullo slogan “Non s’interrompe un’emozione”. A un anno dalla vittoria di Forza Italia, il referendum del 1995, nel quale parte dell’allora Pds cercava una rivincita, fu perduto con il 55,7% di voti contrari. Era lo scontro tra due modelli culturali, uno centrato sulla superiorità dell’opera, l’altro sull’inevitabilità della pubblicità, evidentemente interiorizzata ormai dalla grande maggioranza degli italiani.
La storia delle abitudini, e del mercato televisivo, in questa fase può essere letta in due chiavi diverse e complementari. Da un lato, l’imporsi dal basso nel mezzo televisivo, a cominciare dalle emittenti locali, di consumi a basso costo, ma che comunque segnalavano cambiamenti di costumi e anche di mentalità in corso; dall’altro, lo stabilizzarsi dei modelli maggiormente standardizzati, con una nuova televisione nazionale molto simile per numerosi aspetti ma differente, a cominciare dal carattere apertamente privato e orgogliosamente commerciale, rispetto alla Rai.
Per quanto riguarda il primo aspetto, può essere interessante il caso, notissimo allora ma oggi quasi dimenticato, del mobilificio Aiazzone, che cominciò con un progetto nazionale a invadere le tv locali di tutte le regioni della sua pubblicità sul finire degli anni Settanta. Oggetto di molte ironie, come lo era del resto una nuova televisione vitale quanto in molti casi sgangherata, la sua ossessiva campagna dimostrò due cose importanti: da un lato, la potenza reale dell’advertising nel promuovere non solo marchi ma anche stili di acquisto in precedenza ignorati (le tante famiglie che andavano spesso per la prima volta a Biella, vivendo un weekend di consumo e viaggio insieme); dall’altro, il nuovo rapporto di molti italiani con le loro abitazioni, quel piacere di cambiare la propria casa, magari buttando via mobili di buona fattura per acquistarne di mediocri ma più moderni, o anche semplicemente più nuovi, che avrebbe successivamente fatto la fortuna di Ikea (ma non solo) nel nostro Paese.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, è interessante ascoltare il discorso di Silvio Berlusconi, all’inaugurazione nel 1978 di TeleMilano, due anni prima di Canale 5. L’imprenditore poco più che quarantenne, al suo debutto nella tv, chiariva senza mezzi termini di considerare la Rai il suo unico concorrente. La tv privata dei (anzi del) network parlava fin dalle origini all’Italia tutta, ma a un Paese in buona parte diverso da quella del ventennio precedente: preso tra l’assuefazione ormai a costumi che pochi anni prima erano del tutto nuovi e le scosse di altre trasformazioni ancora più profonde, legate alla secolarizzazione e alla caduta dei tabù. In questo contesto, l’“altra Rai”, che nel giro di tre anni assunse il controllo di tre canali, ebbe una funzione essenziale di mediazione, che si sarebbe ripercossa anche sulle fortune politiche del suo proprietario. In un libro pubblicato nel 1995 parlavo di un “carnevale moderato”, che conciliava la tensione liberatoria contro l’austerità, e in favore di un consumismo dichiarato e senza sensi di colpa, con l’attenzione ai possibili timori di gran parte della popolazione: verso gli “eccessi” dei comportamenti giovanili, come verso una caduta di valori consolidati tra i quali, radicatissimo nel nostro Paese, il risparmio.
La tv privata nazionale inoltre accompagnò, come è stato osservato, l’imporsi, al centro del sistema dei consumi, del brand, e al centro dell’estetica dei consumi, del packaging. La pubblicità tv non imponeva tanto nuove abitudini, quanto le accoglieva ed etichettava. Semmai, per molti aspetti, fu la progettazione dei prodotti ad adeguarsi alla televisione: cercando di imitarne i colori, e anche (appunto attraverso il packaging) la brillantezza fatta di plastiche colorate che davano anche il piacere infantile di romperle.
C’è ancora lo spazio per un medium abitudinario come la televisione in questo nuovo mercato? Gli annunci di morte si susseguono. Forse, dovremmo invece parlare: di una televisione che è sempre più parte dell’ambiente informativo d’insieme, con un rapporto tutt’altro che reciprocamente esclusivo nei confronti del web; e di una televisione che costituisce comunque, in quell’ambiente, una traccia, rassicurante e ordinante.
Abitudini e mercato alla svolta del millennio. E oltre
Fino agli anni Novanta inoltrati, nonostante tutte le differenze, le abitudini televisive (sia nel senso di quelle che la televisione “vende”, sia di come l’ascolto televisivo è strutturato) sono state comunque parte di un’unica epoca, quella della cultura di massa: dalle pratiche di consumo al funzionamento di gran parte delle attività produttive, basate sull’interiorizzazione minuziosa di una routine, fino alla divisione lavoro/tempo libero. Seppure sempre meno centrato sulla ritualità religiosa, il tempo di non lavoro manteneva comunque un ritmo condiviso, in particolare nel nostro Paese: le vacanze d’agosto come la domenica calcistica. L’avvento della tv ha in parte segnalato l’inizio di un cambiamento, con la quotidianizzazione dello spettacolo, con l’estensione di modelli “festivi” anche in altri momenti della vita (come annunciava lo slogan “con pasta Barilla è sempre domenica”), ma il palinsesto della tv italiana continuava comunque a confermare un ritmo relativamente tradizionale, in cui il giorno del Signore aveva un posto distinto, dal “domenica è sempre domenica” che concludeva il popolarissimo Musichiere, alla Domenica sportiva, senza dimenticare il rito per definizione, la Messa mattutina. Una delle novità che si sono imposte alla svolta del millennio è stata la progressiva frantumazione del tempo libero, non solo desacralizzato, ma a questo punto moltiplicato. A questo hanno contribuito gli orari e giorni di lavoro sempre meno regolari, in particolare per le giovani generazioni, ma anche un ambiente comunicativo sempre più mobile e più incline a favorire comportamenti, come si diceva, di “caccia e raccolta”. Se il tempo della cultura di massa è rimasto comunque legato alle pratiche del “nuovo e sempre uguale”, radicato nel sistema dei generi della fiction quanto nelle forme dell’informazione giornalistica, negli ultimi vent’anni si è venuta imponendo, in parte in contrasto con quella tradizione, un’estetica dell’esperienza, strettamente intrecciata al decrescere del peso delle abitudini.
Uno dei segnali di questa fase, naturalmente, è stato non solo il moltiplicarsi dell’offerta tv ma anche la diversificazione dei modi di accesso e di fruizione. E dei generi stessi, dal reality alla nuova serialità, fino alle trasmissioni di cucina: tutti in vario modo offrono non solo spettacolo ma modi di partecipazione, in un mezzo che si presenta come luogo di vita oltre che come magic box. L’estetica dell’esperienza ha portato con sé una soggettivizzazione esplicita e spesso aggressiva dei consumi, in cerca di antidoti contro la noia: chiede alla rete, ma anche alla televisione vecchia e nuova, non tanto illustrazioni e descrizioni (per esempio delle possibili mete turistiche), quanto indicazioni di percorso, ancora una volta per una caccia e raccolta da continuare individualmente, anche se spesso tale individualizzazione nasconde pratiche non meno ripetitive che in passato, e spesso conformistiche.
C’è ancora lo spazio per un medium abitudinario come la televisione in questo nuovo mercato? Gli annunci di morte si susseguono: per la tv, come del resto per i giornali e per la radio, per il libro e per le forme tradizionali di istruzione. Forse, dovremmo invece parlare: di una televisione che è sempre più parte dell’ambiente informativo d’insieme, con un rapporto tutt’altro che reciprocamente esclusivo nei confronti del web; e di una televisione che costituisce comunque, in quell’ambiente, una traccia, rassicurante e ordinante come diceva Dewey.
In effetti, il potere decrescente dell’abitudine non implica la fine del bisogno di quello che l’abitudine comunque psicologicamente rappresenta, in termini di risparmio di sforzo e di stabilità-rassicurazione. Per comprenderlo, ricorriamo a un paragone. Una delle forme di comunicazione in crescita più rapida negli ultimi vent’anni è una delle più antiche e “neolitiche”, il museo. Questo ha visto, nonostante tutto, aumentare la sua attrattiva grazie al suo potere legittimante, che deriva dalla forza della sua tradizione e in parte proprio della sua apparente obsolescenza, dal suo presentarsi come controtendenza rispetto al dilagare di un universo di informazioni vastissimo, dispersivo ed effimero. Forse, l’ancoraggio apparentemente obsoleto ad alcune forme di consuetudine può essere tuttora anch’esso essenziale, e valorizzato proprio per la sua stabilità in un mondo in perenne movimento. Media come la radio e la tv possono, nel nuovo contesto, farsene mediatori: ripensando anche in questa chiave il loro mercato.
Peppino Ortoleva
Professore ordinario di Storia e teoria dei media all'Università di Torino, è direttore scientifico del Master in Giornalismo. Tra i suoi libri, Il secolo dei media (2009) e Dal sesso al gioco (2012). È inoltre curatore di musei e mostre.
Vedi tutti gli articoli di Peppino OrtolevaLeggi anche

Gente comune e società
Pubblico in scena

Scrittura tv
Una serie tv è Aristotele allo specchio

