
Anche la Francia decide di lasciare il segno nelle serie tv, e lo fa con Emmanuel Carrère, i Mogwai e personaggi che tornano dal passato. Ecco Les Revenants.
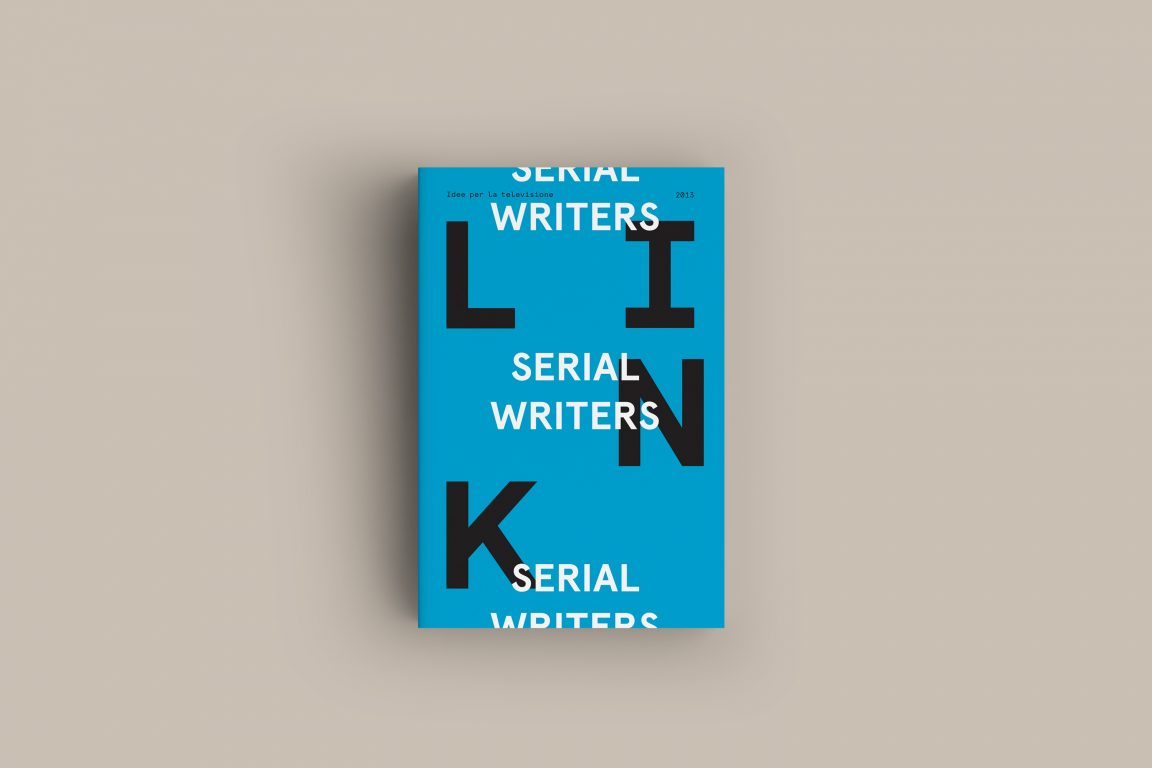
Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 15 - Serial writers del 01 ottobre 2013
Les Revenants, serie creata da Fabrice Gobert, è andata in onda a fine 2012 in Francia su Canal+. Ispirata a un omonimo film di qualche anno fa, ha suscitato molto discorso, dentro e fuori i confini esagonali. In patria qualcuno ha parlato di miracolo, anzi, per rimanere in tema, di “resurrezione” delle serie tv à la française. Gli inglesi di Channel 4 l’hanno trasmessa in originale, con discreti risultati d’audience. In Italia, è bastato che uscissero in rete i sottotitoli per scatenare visioni carbonare e stupori, malgrado nutrite sacche di resistenza anti-francofona. Abbiamo incontrato Fabrice Gobert per parlare di questo successo, di scrittura televisiva e altri demoni, ma anche dei Mogwai, Emmanuel Carrère, Gregory Crewdson, e di ciò che sta dietro quella che è stata definita “una serie francese che non sembra una serie francese”.
Lei è il creatore di Les Revenants, ma anche regista di alcuni episodi e sceneggiatore, assieme, tra gli altri, a Emmanuel Carrère. Un ruolo globale che qualcuno ha paragonato alla figura dello showrunner americano.
Sì, in un certo senso ci sono delle somiglianze, ma è vero che gli americani sono molto più strutturati di noi. Non a caso ci mettono la metà del tempo a produrre una stagione. Lo showrunner lavora con altri registi, con altri sceneggiatori, e controlla tutto il processo. In Francia spesso si ha la sensazione che gli episodi siano diversi a seconda del regista. Noi abbiamo sin da subito cercato una coerenza totale, volevamo che ogni sequenza appartenesse allo stesso insieme, e ciò ha avuto conseguenze anche a livello di organizzazione del lavoro. Per esempio, con il secondo regista, Frédéric Mermoud, era chiaro sin dall’inizio che avrei supervisionato il suo lavoro. Una cosa abbastanza inusuale qui da noi.
Lei viene dal cinema. Les Revenants è la prima serie che ha scritto. Come è andato il processo di apprendimento dello specifico televisivo?
Non finisce mai, in effetti. In questo momento siamo al lavoro sulla seconda stagione, e devo dire che è sempre difficile, specie quando hai a che fare con serie corali, con decine di personaggi. Ci sono molte regole da seguire. L’importante è sapere quali sono queste regole, fissarsele bene in testa e poi rispettarle. Per esempio l’equilibrio tra il realismo di fondo del nostro racconto e il sovrannaturale. All’inizio ci siamo posti in continuazione domande del tipo: “I personaggi agiscono in modo logico in una realtà come questa? È abbastanza avvincente quello che stiamo raccontando? Stiamo introducendo troppi misteri? Riusciremo a rispondere a tutto?”. Per prepararmi ho studiato a fondo le serie che mi piacevano di più. Ma una cosa è capire come funziona, un’altra scrivere una serie da zero.
In un’intervista ha dichiarato che, all’inizio del processo di scrittura, ha avuto la tendenza a scappare un po’ dai dialoghi, a utilizzare ellissi, per poi capire che la soluzione era l’opposta, ovvero l’esplorazione minuziosa di ogni situazione.
Quando si scrive una sceneggiatura, capita, senza volerlo, di deviare dalla strada principale, di non affrontare di petto le difficoltà. E così ti trovi a tagliare troppo presto delle scene, a cercare delle scorciatoie. Il mio primo vero problema è stato capire come rendere al meglio il momento in cui i morti ritornano. Prendiamo l’incontro tra Camille e sua madre Claire, che la crede morta da quattro anni. Nella prima stesura, Claire sveniva e poi, con un’ellissi, ci ritrovavamo mezz’ora dopo, con i personaggi già abituati alla nuova situazione. Con l’aiuto di Emmanuel Carrère ho capito che non funzionava. Lui è uno scrittore incredibile, capace come nessuno di sondare l’animo umano, di entrare fin dentro il cervello dei suoi personaggi. Quando ci siamo incontrati avevo già scritto i primi due episodi, mi ha detto che gli piaceva la direzione che avevo intrapreso, ma che tutto andava troppo veloce. Così abbiamo deciso di prenderci il tempo necessario per raccontare le reazioni dei personaggi, senza fretta, quasi in tempo reale.
La prima parte della stagione segue un ritmo abbastanza atipico. Ci sono dei piani sequenza molto lunghi; penso al funerale del signor Costa, con quasi tutti i personaggi che si muovono come in una coreografia. E poi ci sono scene molto corte, senza dialoghi, di pura atmosfera.
Sì, è vero. L’esigenza era di ottenere dei contrasti, per sorprendere lo spettatore e tenerne alta l’attenzione. Il principio di base prevede appunto di privilegiare i piani lunghi, per sondare le reazioni di tutti i personaggi. La scena al cimitero è molto importante, perché mostra allo spettatore che i personaggi sono tutti più o meno legati tra di loro. È il bello della mise en scène: far emergere cose che magari nella sceneggiatura sono solo accennate. Costruire un piano sequenza come quello è complicato perché obbliga a trovare un certo ritmo interno, quasi musicale, che non puoi avere con dei tagli successivi. E poi è un lavoro veramente collettivo: è necessario che il capo operatore, gli attori e tutti i tecnici comprendano le intenzioni del regista e che tutto si incateni per bene.
Ho letto che sul set usa l’espediente di far ascoltare parte della colonna sonora. In questo caso, i Mogwai.
Sì, loro avevano già composto alcuni temi prima del tournage, e spesso, durante le prove, o mentre giravamo, ascoltavamo la loro musica. Sul set a volte ci si annoia, o si ha la tendenza ad accelerare, e la musica può aiutare a tenere un certo ritmo di lavoro. Avevo già sperimentato una cosa del genere ai tempi del mio primo film, Simon Werner a disparu, assieme al capo-operatore, Agnès Godard. Credo sia un buon modo, per il regista, di comunicare efficacemente alla troupe quello che ha in mente. Ma anche uno strumento di dialogo con la rete. Per esempio, i primi rushes di Les Revenants avevano già la musica dei Mogwai in sottofondo, e questo ha rassicurato tutti, da subito, su quello che sarebbe stato il prodotto finale.
La musica ha un ruolo preponderante nella serie…
Quando ho contattato i Mogwai avevo già l’idea che la musica dovesse avere il peso di un personaggio, un po’ come la diga o il tunnel. Una specie di narratore che desse un punto di vista diverso alle varie scene, e che dicesse: “Attenzione, non tutto è come credete”. Così abbiamo deciso di aprire e chiudere gli episodi con i vari temi musicali, a seconda dei personaggi. La musica viene a cercare il pubblico e lo guida nella visione. Da spettatore, mi piace molto quando la musica riesce a portarmi in dimensioni emotive più profonde. Penso al film di Jean-Luc Godard Le Mépris, in cui la colonna sonora rende emozionanti scene che altrimenti potrebbero risultare banali.
L’episodio finale è stato motivo di dibattito in rete. C’è chi lo ha amato alla follia, c’è chi si è lamentato per l’assenza di risposte ai vari interrogativi. Personalmente trovo la questione delle “risposte non date” abbastanza sterile, ma è vero che parte del pubblico ha molto a cuore questo aspetto, vedi le reazioni al finale di Lost. Come ha reagito alle critiche?
Le serie che appartengono al genere fantastico di solito si basano su un parti pris di fondo, in questo caso i morti che ritornano. Nella prima stagione ci interessava raccontare l’irruzione dell’impossibile in uno scenario di normalità. Scrivendo gli ultimi episodi ci siamo resi conto che non c’era lo spazio per mostrare tutto ciò che avevamo in mente. Il canale aveva già ufficiosamente messo in cantiere la seconda stagione, per cui abbiamo scelto di puntare su un finale che fosse il più potente possibile sul piano emotivo e che lasciasse in secondo piano i misteri. Sapevo che ci sarebbe stata frustrazione, ma posso garantire che i nuovi episodi appagheranno le attese di tutti. Anche se, a dire il vero, trovo che le domande siano sempre più interessanti delle risposte, perlomeno quando sono ben dosate.
"Emmanuel Carrère è uno scrittore incredibile, capace come nessuno di sondare l’animo umano, di entrare fin dentro il cervello dei suoi personaggi. Abbiamo deciso di prenderci il tempo necessario per raccontare le reazioni dei personaggi, senza fretta, quasi in tempo reale".
Volendo sintetizzare, Les Revenants è una sorta di “inchiesta” che personaggi e spettatori conducono, fianco a fianco, alla ricerca di “verità”. Una dinamica simile è presente anche nel suo primo film. Cosa rappresenta per lei questo tema?
Credo che la fiction sia un buon terreno per porsi delle domande su ciò che non conosciamo, e su cui siamo obbligati a inventarci qualcosa. Ogni mezzo è buono per esplorare tutto ciò che ci sfugge, anche una storia sugli zombie. Un vero punto in comune tra il mio film e la serie è che i personaggi diventano essi stessi degli sceneggiatori, degli inventori di soluzioni, di verità.
In un’intervista ha dichiarato: “Quando si lavora a una serie come Les Revenants, non si può far finta che nessuno abbia mai pensato a resuscitare dei morti in una fiction. Abbiamo dunque cercato di inserirci in una filiazione ben precisa”. Religione, mitologia, immaginari: come ha fatto a orientarsi in questa massa sconfinata di riferimenti?
Mi sono immerso completamente, cercando di riflettere su tutto ciò che da sempre mi aveva ispirato questo tema. Ho ripreso in mano Il mondo incantato di Bruno Bettelheim, o certi testi di Philip K. Dick. Ho rivisto alcuni dei miei film preferiti, come lo svedese Lasciami entrare o il coreano The Host. Poi ho lasciato perdere tutto e mi sono messo a scrivere. Ma l’ispirazione si nutre anche di elementi di cui non conosciamo l’origine, almeno non sempre a livello cosciente. Recentemente mi hanno fatto notare la somiglianza di certe scene di Les Revenants con film di Carpenter o Kubrick, scene a cui non avevo minimamente pensato ma che evidentemente erano rimaste lì, da qualche parte. È un po’ come nel jazz, c’è un numero limitato di temi e ciascuno cerca di interpretarli alla propria maniera.
Anche il fotografo Gregory Crewdson è stato importante nella costruzione dell’universo visivo.
Ho sempre ammirato il suo modo di ritrarre delle situazioni apparentemente banali ma che permettono, a chi guarda le sue foto, di lasciar andare la fantasia, di immaginarsi altre storie. Crewdson riesce a riprodurre le periferie americane restituendo la sensazione che, da un momento all’altro, possano arrivare, perché no, anche gli extraterrestri. Esattamente quello che volevo per Les Revenants: filmare una cittadina francese e i suoi luoghi normali, predisponendo al tempo stesso lo spettatore a qualsiasi evento sovrannaturale.
In ogni articolo, critica o commento su Les Revenants a un certo punto sbucano fuori Twin Peaks e David Lynch. Eppure le serie hanno un assunto di base completamente diverso. Come lei e Carrère avete detto in varie occasioni, Les Revenants tratta una situazione irreale in modo estremamente realista e compatto, mentre Twin Peaks parte da un fatto umano, un omicidio, per procedere poi attraverso brusche rotture tra registri diversi.
Effettivamente non è un riferimento a cui mi sono ispirato in fase di lavorazione, anche perché se parti con l’idea di fare un Twin Peaks alla francese, rischi di fare davvero n’importe quoi. Se mi ha influenzato, è perché è qualcosa di ben radicato nell’immaginario collettivo, che ti condiziona tuo malgrado.
La comunità montana può aver facilitato i paralleli…
Può darsi, anche se a dire il vero l’idea di avere una città circondata da una montagna, o anche una diga con un ruolo così decisivo a fini narrativi, ci serviva per l’unità di luogo, che poi è un elemento determinante in moltissime serie, da Desperate Housewives a Deadwood. Se c’è una cosa che ho amato in Twin Peaks è certamente il mélange di generi. Ci sono personaggi estremamente tragici e altri più nel registro dell’ironia. Lo stesso mélange che ho cercato in alcuni momenti di applicare alla nostra serie.
Però, a differenza di Twin Peaks o di altri titoli più recenti come True Blood o In the Flesh, la sensazione è che abbiate preferito subordinare l’ironia, o certi riferimenti metatestuali, al principio generale della coerenza di racconto.
Ci siamo posti a lungo la questione della mise en perspective, anche perché i personaggi della serie hanno giocoforza visto i vari film sugli zombie e non potevamo fare finta di niente. Di conseguenza, abbiamo inserito dei momenti di leggerezza, di distanza, anche per compensare una certa angoscia generale, ma sempre evitando che la componente ironica prendesse il sopravvento. Il nostro obiettivo era innanzitutto l’identificazione del pubblico. Se avessimo dato l’impressione di un “universo che non esiste”, lo spettatore non si sarebbe più posto la domanda cruciale: “Come reagirei io al posto di questo o quel personaggio?”.
C’è grande attesa per la seconda stagione, prevista per la fine del 2014. È pronto per questa enorme responsabilità?
La prima stagione è andata bene, ma non era scontato, anzi. Adesso abbiamo la fortuna di non doverci rinnovare a tutti i costi, né di dover stravolgere quanto di buono fatto finora. In fin dei conti dobbiamo solo continuare a raccontare una storia che ci piace.
Nico Morabito
Palermitano e parigino. Coautore dei film La Dernière Séance (presentato alla Settimana della critica della Mostra di Venezia 2021 e vincitore del Queer Lion) e Fuori Tutto (Miglior documentario italiano al Torino Film Festival 2019). Ha collaborato alla scrittura del film Le Favolose (presentato alle Giornate degli autoridella Mostra di Venezia 2022). È professore a contratto all’Università di Paris Nanterre, dove tiene un corso di scrittura audiovisiva dal 2019.
Vedi tutti gli articoli di Nico MorabitoLeggi anche

Politica altrove
Due modelli nuovi nuovi per la politica in tv

Serialità
Cattivi senza attributi

