
Dal più importante critico televisivo italiano, una riflessione sulle radici, sugli strumenti e sugli obiettivi del valutare e raccontare il piccolo schermo ogni giorno.
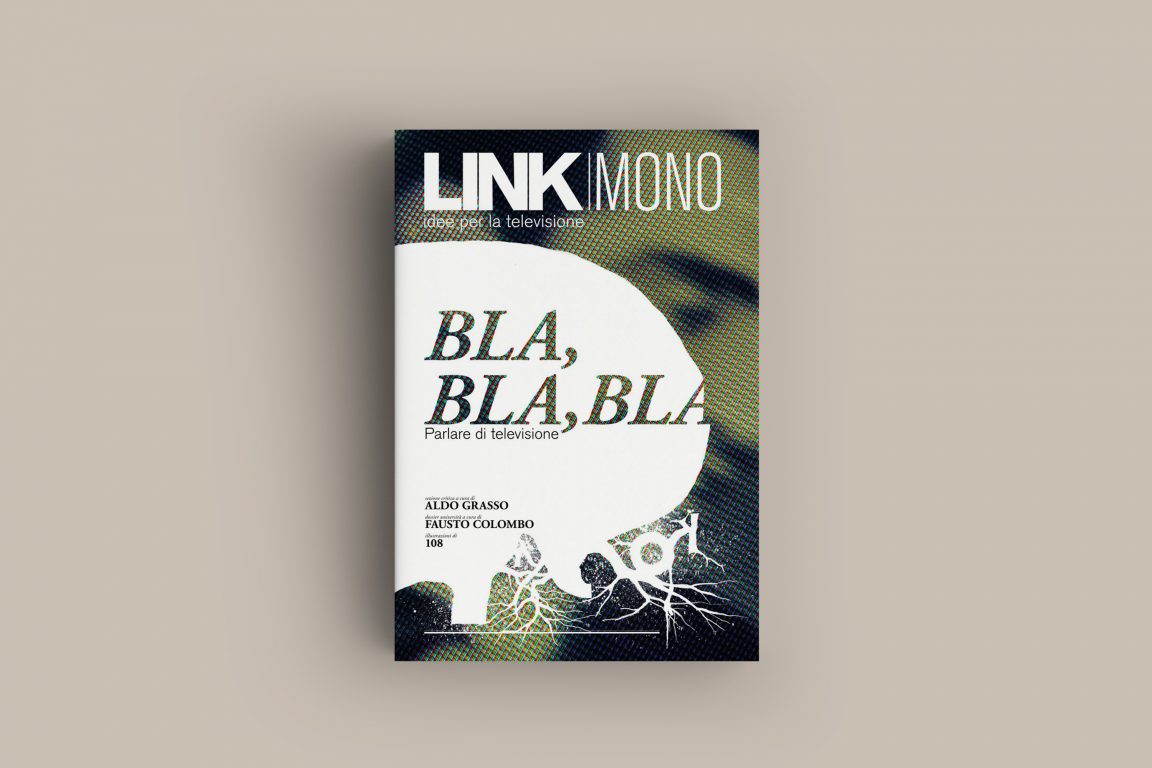
Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Link Mono - Bla, bla, bla. Parlare di televisione del 04 maggio 2009
Tempi duri per la critica televisiva; non passa giorno che la suscettibilità offesa di qualche personaggio dello schermo non si traduca in querela, intimidazione, ingiuria. Antiche amicizie che avevano superato ben altre temperie si sgretolano per un giudizio negativo su una valletta o su un pupazzo. Persino l’ultimo dei conduttori, quando viene giudicato, si sente in dovere di usare il video per svillaneggiare il critico. Non è cosa nuova: “Non so se la televisione dia alla testa a quelli che appaiono su teleschermi, o se si crei in costoro una specie di psicopatia o di ipersensibilità morbosa. Ormai è diventato un fatto consueto polemizzare dal video con giornalisti che si occupano di televisione, e addirittura servirsi della televisione per fatti personali”. Così, già negli anni Cinquanta, Achille Campanile stigmatizzava il brutto vizio, un vero e proprio abuso, di certi conduttori: usare la televisione per avversare chi è di diverso parere. Anche Sergio Saviane, quando è stato “allontanato” dal settimanale L’Espresso, ricordava malinconicamente insulti, maledizioni, querele, incomprensioni, scontri. Mestiere a rischio o funzione inevitabile della critica?
La migliore critica televisiva è quella che ha saputo inventarsi uno stile, una scrittura, a partire dalle immagini, che diventano talvolta puro pre-testo. È la critica di Achille Campanile, di Sergio Saviane, di Beniamino Placido. È la critica che si è acquistata autorevolezza.
La critica televisiva, da quando esiste la rilevazione degli ascolti, da quando a ogni inquadratura corrisponde un valore di share, appare come un rottame. Più del dovuto. Paradossalmente, però, la sua esistenza è garantita dalla profonda avversione che suscita, e legittimata dagli stessi personaggi televisivi. Che non si accontentano di sbancare l’audience. No, insieme pretendono anche il consenso della critica e se non l’ottengono si infuriano, reagiscono a male parole. Di critiche, ne ammettono una sola: “Io le accetto tutte, ma solo se costruttive” (anche se le critiche costruttive, per la verità, riguardano un altro settore dello showbiz: il consulente d’immagine).
Il grande cruccio della critica televisiva nasce da una difficoltà logica insolubile: il sostantivo si riferisce a un’attività che normalmente si esercita nel campo dell’estetica; l’aggettivo indica invece la presenza di un corpo, di una materia, che sembra aver perduto ogni connotazione estetica e che, anzi, viene assimilato alla “spazzatura” con sempre maggiore frequenza. Difficile stabilire su quali criteri si fondi. Difficile che le altre critiche, specie quella letteraria, le riconoscano dignità d’esistenza. L’aggettivo trascina nel gorgo il sostantivo.
“Per molti versi la professione del critico è facile: rischiamo molto poco, pur approfittando del grande potere che abbiamo su coloro che sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio. Prosperiamo grazie alle recensioni negative che sono uno spasso da scrivere e da leggere. Ma la triste realtà, cui ci dobbiamo rassegnare, è che, nel grande disegno delle cose, anche l’opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. Ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa rischia davvero. Per esempio, nello scoprire e difendere il nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni: al nuovo servono sostenitori!”.
Anton Ego, critico enogastronomico, Ratatouille, 2007.
La critica cambia progressivamente il suo status e la sua funzione. La televisione è forse l’esito estremo di quelle trasformazioni, figlie della “riproducibilità tecnica”, intraviste da Walter Benjamin negli anni Trenta: perdita dell’aura e caduta del valore cultuale dell’arte. Ai problemi estetici – che pure non spariscono del tutto – vengono a sostituirsi le questioni “comunicative” proprie del medium (industria editoriale, cinema, radio, televisione eccetera). Il nuovo prodotto, nato con l’industrializzazione della cultura, nelle parole di Edgar Morin, “è strettamente determinato dal suo carattere industriale, da una parte, e dal suo carattere di consumo quotidiano, dall’altra, senza potersi sollevare all’autonomia estetica. Non è raffinato, né filtrato, né strutturato dall’Arte, valore supremo della cultura degli uomini colti”.
Ma la posizione del critico televisivo è anche più complessa e problematica di quella dei critici teatrali, letterari, cinematografici o musicali nell’epoca della riproducibilità tecnica. Essi conservano una funzione di orientamento – o l’illusione di questa funzione –,non attribuibile invece al critico televisivo. Per quanto, a proposito di gusto del pubblico che frequenta i teatri, già Alfred Polgar scriveva: “Il pubblico di teatro, vale a dire: la massa disomogenea della gente di città che ogni sera viene spinta a teatro dalla noia, dalla curiosità o dal bisogno di sottrarsi all’insulsaggine della propria esistenza, non ha assolutamente gusto, nemmeno cattivo. È un contenitore universale. Il singolo ha nel sistema nervoso le sue specifiche zone affamate d’eccitazione dove prova particolare piacere a essere toccato, mentre alla massa è comune una sola cosa. La disponibilità a lasciarsi eccitare”. C’è grande differenza tra questo pubblico urbano e la sterminata audience televisiva?
Nel 1973, Umberto Eco – riprendendo uno schema di Franco Fortini – distingueva fra tre tipologie di “finalità culturali” in cui si può suddividere la critica Umberto Eco (a cura di), Criteri e funzioni della critica televisiva, Rai Eri, Torino 1973; Franco Fortini, Ventiquattro voci per un dizionario di lettere, Il Saggiatore, Milano 1968.: a) la critica normativa si prefigge di mettere a confronto “l’opera analizzata a un ideale di opera perfetta e si richiama a una tavola di regole auree per dire come si dovrebbe fare arte”. La “bellezza classica”, o una precisa visione religiosa o morale, sono il metro di paragone per ogni testo; b) la critica “fiancheggiatrice” o “militante” non si origina da un ideale universalistico, ma da una definita posizione di parte, a favore di una certa “poetica”: la singola opera è difesa in quanto appartenente a un “modello di modernità” (pensiamo alle critiche legate all’Avanguardia: critica ermetica, surrealista eccetera); c) la critica orientativa si pone invece al servizio del lettore, di cui il critico fa le veci: lo avverte del valore artistico dell’opera, lo aiuta nell’interpretazione, lo consiglia sull’“acquisto” di una determinata merce culturale. Come si è già detto, questa terza tipologia critica – quella orientativa – nasce e diventa predominante con l’emergere dell’industria culturale: dalle recensioni letterarie su I misteri di Parigi di Sue agli articoli sul film nelle sale, la critica orientativa ha un destinatario preciso, il lettore, cui intende dare consigli.
Ma la critica televisiva non può essere orientativa per diverse ragioni. Se un film recensito, di solito in anteprima, è disponibile a tutti nelle sale; se un disco è pronto per essere acquistato nel negozio sotto casa; se un best seller è presente in ogni libreria, il programma televisivo, quando viene recensito, è già stato consumato. È vero che nella televisione attuale dominano principi di forte serialità, e un programma è fatto secondo formule o format che si ripetono a ogni puntata; ma è altrettanto vero che ogni testo è un unicum, e spesso l’interessante in televisione sta proprio nelle deviazioni dalla norma. Senza contare che l’esperienza televisiva è soprattutto “esperienza del flusso”, continuum indistinguibile, e offre aree marginali alla più tradizionale “esperienza” di testi definiti e chiusi.
Vi è poi una ragione ulteriore che gioca contro ogni velleità orientativa: la televisione di oggi (ma anche la musica, il cinema, la letteratura) fa parte di un “mercato culturale” sempre più complesso e variegato. Nel momento in cui gli andamenti di questo mercato sono regolati dalla logica della misurazione dell’audience, la critica ha davvero poche speranze – se pure se le pone – di “incidere” o “spostare numeri”.
“La critica spesso non è una scienza; è un mestiere, dove occorre più salute che spirito, più lavoro che capacità, più abitudine che genio”.
Jean de La Bruyère, I caratteri, 1668.
Lo scrittore Achille Campanile ha insegnato che grande critico è colui che trasforma lo spettatore in palcoscenico e lo schermo in un incontro di humour, estro, invenzione. Dunque, la parodia (lo stile) sembra essere la condizione primaria di lettura. E l’ironia critica è l’unico interrogativo che attraversi la televisione. Di fronte al “pensiero unico televisivo”, la voce della critica è quella della dissonanza, non della complicità. Ma la televisione pare un mondo privo d’ironia. Preferisce la scomunica. Anatemi lanciati dagli stessi schermi televisivi, nella totale ignoranza di una legge del tutto ovvia, già teorizzata da Eco ai tempi della Fenomenologia di Mike Bongiorno: la distinzione fra “persona” e “personaggio”. Il critico ha continuamente a che fare con materiale “umano”: non critica le pagine di un libro o le immagini di un film – frutto di un autore, individuale o collettivo –, ma immagini impastate di personaggi “veri”. Un ulteriore guaio è costituito dal fatto che molti critici amano confondersi con il mondo di cui parlano. Come sostiene giustamente Stanislaw J. Lec, “il critico deve stare tutto o sulla scena o sulla platea, altrimenti il sipario gli cadrà sul collo come una ghigliottina”.
L’ironia critica è l’unico interrogativo che attraversi la televisione. Di fronte al “pensiero unico televisivo”, la voce della critica è quella della dissonanza, non della complicità. Ma la televisione pare un mondo privo d’ironia. Preferisce la scomunica.
Nel nostro Paese, la critica televisiva è nata con il nuovo mezzo. Fin dagli anni Cinquanta, i quotidiani e le riviste hanno riservato spazi d’intervento sul nuovo mezzo, affidati spesso a firme autorevoli, a letterati. Con il passare degli anni, e con la crescita dell’incidenza sociale della televisione, alla critica si è affiancata una cronaca sempre più dettagliata, fino alle attuali pagine degli spettacoli dei giornali. Nel frattempo, anche il mondo accademico ha iniziato a interrogarsi sui meccanismi linguistici e sugli impatti sociali della televisione. Ma, come ricorda Stefano Bartezzaghi, gli ambiti e le finalità restano separati: se la cronaca fornisce anticipazioni e retroscena al lettore curioso (e costituisce un’importante forma di publicity per gli stessi canali televisivi), se l’Accademia cerca di mettere a punto apparati teorici da verificare sul campo (dell’analisi testuale o sociale), la critica “elabora giudizi attraverso la propria scrittura”. Potremmo distinguere tra una critica televisiva tradizionale, che si mette in gioco in prima persona, “dichiara amori e umori”, e parla per lo più dalle pagine dei giornali, e alcuni recenti tentativi di critica meta-televisiva, come nel caso di Blob, che ricicla la televisione e affida il giudizio alle logiche del montaggio.
“In un opera di psichiatria mi interessano solo i discorsi dei malati; in un libro di critica, solo le citazioni”.
Emile Cioran, L’inconveniente di essere nati, 1973.
La critica televisiva tradizionale gode di pessima reputazione e di commossa solidarietà. Anni fa, sulle pagine di Repubblica, Sandro Viola si è assunto il compito di vergare severe parole di compatimento: “Noi vediamo scorrere dinanzi ai nostri occhi la Cuccarini, la Goggi, Curzi, Pippo Franco, Pirrotta, Chiambretti, Baudo e Biscardi e non riusciamo a scorgere nient’altro che la loro tremenda ineleganza. Il critico televisivo li scruta invece come se fossero bilanci della Fiat, statistiche sul crimine, rapporti sulla situazione internazionale: convinto che dietro quelle presenze così fastidiose esistano Significati d’interesse generale che vanno colti, analizzati, spiegati al lettore della sua rubrica”.
In genere, si pensa, come avrebbe detto Totò, che il compito del critico sia quello di criticare, cioè “parlare male”. Non è vero niente. Il compito del critico, se mai, è un altro: quello di segnare la sua presa di distanza dal circo mediatico, di non far parte della compagnia di giro. Se è bravo, come lo era Achille Campanile, riesce anche a usare una materia “vile” come la televisione per un esercizio di immaginazione e di intelligenza. La critica televisiva – la critica, in genere – può insegnare poco: non è normativa, non è orientativa, non è pedagogica. Diciamola tutta: non serve a nulla. Ma insegna una sola cosa: l’esercizio critico. L’analisi di un programma diventa uno spunto, un attivatore della curiosità di chi guarda. C’è una definizione di Ardengo Soffici che si attaglia perfettamente a questa preziosa “inutilità”: “Compito [della critica] non è solo quello di apprezzare e fare apprezzare altrui il buono e il bello, bensì, e massimamente, quello di non prender per bello e buono il brutto e il cattivo; insomma, non tanto di distinguere tra l’ottimo e il pessimo, quanto di riconoscere il vero dal falso”. E comunque la migliore critica televisiva è quella che ha saputo inventarsi uno stile, una scrittura, a partire dalle immagini, che diventano talvolta puro pre-testo. È la critica di Achille Campanile, di Sergio Saviane, di Beniamino Placido. È la critica che si è acquistata autorevolezza e riesce a “juger en connaisseur”, a giudicare da esperti.
“Il porcello, venuto nel morir la state alle querci, appié la reina loro v’incontrò un boleto tutto ritto e scarlatto: perlocché accostati a quella invereconda porpora i due buchi del grifo gli bofonchiò a livello: ‘Io vo a tartufi’. Questa favola ne ammonisce: che ad esercitare la critica, il buon critico deve prendere esempio dal porcello”.
Carlo Emilio Gadda, Il primo libro delle favole, 1952.
Ma il critico ha un metodo? Segue, ogni volta che si occupa di televisione, una precisa applicazione analitica, una disciplina scientifica? No, il critico dovrebbe appartenere a quella categoria di persone – come Mario Praz scrisse di sé citando Charles Lamb – “dotate di intelligenza imperfetta. ‘Esse si contentano di frammenti e di ritagli della Verità. Questa non si presenta loro di faccia, ma con un lineamento o di profilo tutt’al più… Le loro menti sono meramente suggestive’”. E, di conseguenza, il loro guardaroba critico è composto di capi stravaganti, bizzarri, oggetti fuori d’uso, frammenti fuori moda. Ma il giorno in cui l’“intelligenza imperfetta” decide di presentarsi in pubblico, ecco che all’improvviso si dispiega tutto il fascino di chi sa osservare nelle più svariate direzioni, con occhio tanto acuto quanto imprevedibile. Un buon consiglio: studiare i metodi critici per poi dimenticarli. O meglio: risolverli in uno stile personale.
Quando Anton Ego, il severo critico di Ratatouille, si siede al ristorante “gestito” dallo chef Rémy (un piccolo ratto che agisce per il suo tramite umano, l’imbranato Linguini) non chiede un piatto ma un po’ di “prospettiva”, qualcosa di cui stupirsi. Anche in televisione, lo dimostrano i reality, “non tutti possono diventare dei grandi artisti ma un grande artista può celarsi in chiunque”; l’importante è offrire un po’ di prospettiva, un progetto, un domani non privo di talenti.
“Aprire il libro in modo che inviti come una tavola apparecchiata dove noi prendiamo posto con tutte le nostre idee, domande, convinzioni, con i nostri ghiribizzi, pregiudizi, pensieri, in modo che i duecento lettori (saranno tanti?) scompaiano in questa compagnia e proprio per questo se la godano – la critica è questo”.
Walter Benjamin, Ombre corte, 1928-1929.
Aldo Grasso
Professore ordinario di Storia della televisione all'Università Cattolica di Milano, fondatore del Ce.R.T.A., editorialista e critico televisivo del Corriere della sera. Fra le sue pubblicazioni: Storia della televisione italiana (1992-2004), Prima lezione sulla televisione (2011) e Storie e culture della televisione italiana (2013).
Vedi tutti gli articoli di Aldo GrassoLeggi anche

Popular culture
Scrivere una storia della tv italiana

Religione e tv
Telepredicatori e oltre, molto oltre

