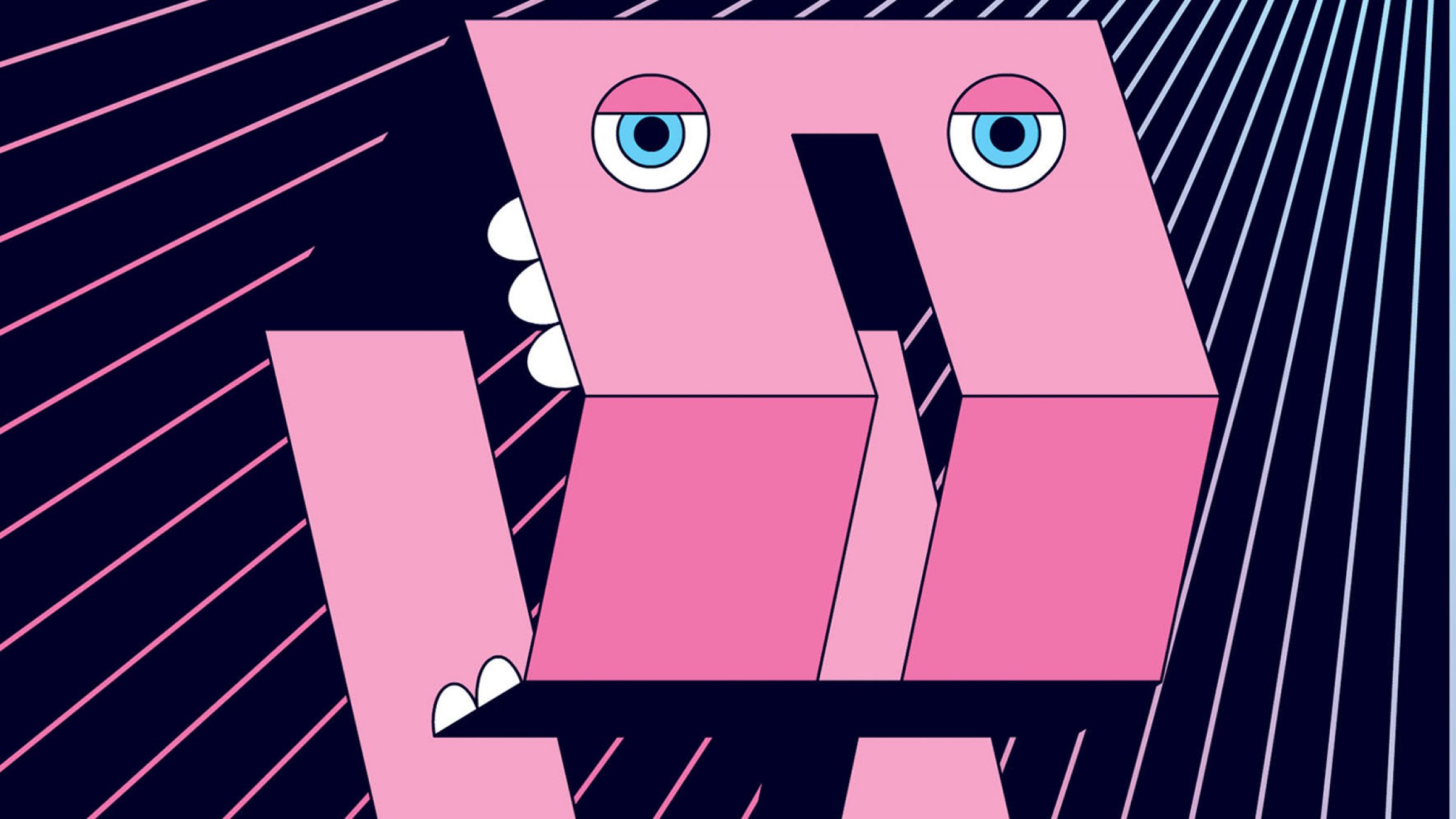
L’emergere della cosiddetta gamification ha i suoi profeti, i guru che annunciano urbi et orbi la rivoluzione. La portabandiera è Jane McGonigal. Ma ce la racconta giusta?

Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 12 - Insert Coin / Game Over del 03 dicembre 2012
Nell’istituto privato dove ho fatto le elementari, gli alunni si dividevano in due grandi insiemi: i bambini che ogni giorno atterravano in aula con scintillanti esemplari dell’ultimo giocattolo reclamizzato in fascia pomeridiana e quelli che potevano impadronirsene soltanto per una distrazione dei proprietari. Nel mezzo c’era la mia agenzia investigativa con cui pretendevo (sia nel senso dell’italiano “pretendere” che dell’inglese “to pretend”) di indagare sui frequenti furti. Erano i tempi in cui i telegiornali mostravano quotidianamente i protagonisti della lotta alla mafia – uomini baffuti e austeri che solcavano lunghi corridoi con voluminosi incartamenti sotto braccio. Seguendo il loro esempio avevo messo insieme il mio personale archivio di dossier raccolti in cartellette turchesi. All’interno “collezionavo indizi”, “raccoglievo testimonianze”, “schedavo impronte”, “seguivo piste” per “stringere il cerchio delle indagini” intorno al colpevole.
I dossier portavano i nomi dei giochi scomparsi (“Il caso del Gig Tiger”, “Il mistero dei Kombattini”, eccetera) e sono sicuro che da qualche parte mia madre li conservi ancora, ma ho sempre avuto il buon senso di non chiedere. La “Alemanni investigazioni” andò avanti per tutta la terza elementare risolvendo un solo caso: la sparizione di una specie di frisbee gommoso molto in voga, improvvisamente riemerso da un cestino delle palestre. Non riuscii a smascherare il ladro ed è sicuramente stato meglio così: ora mi rendo conto che esporre un altro bambino al pubblico rimprovero non era granché come passatempo. Benché peraltro fossi un pessimo inquirente, ci mettevo comunque tutto me stesso per trattare la struttura formale del “mio” gioco con la massima serietà. Il linguaggio, le procedure, persino la consistenza e il colore delle cartellette; era tutto pianificato per sembrare reale, e se qualcuno dei miei “assistenti” usciva dal personaggio per comportarsi come un qualunque bambino di otto anni me la prendevo moltissimo. Non riuscivo a concepire che ai miei coetanei sfuggisse del tutto che l’unico modo per gustarsi il gioco era “fare come se” non fosse affatto un gioco.
“Make believe” è “make belief”
Jane McGonigal è nata a Philadelphia 35 anni fa e da oltre dieci studia e progetta (video)giochi, ha insegnato al San Francisco Art Institute e a Berkeley e attualmente collabora con l’Institute for the Future. Negli ultimi cinque anni è diventata una superstar della divulgazione in materia di videogame ed è euforicamente convinta che questi ultimi avranno un ruolo di primo piano nella soluzione di alcuni dei più seri problemi del XXI secolo. Con le sue idee ha attratto la curiosità di una lunga lista di moltiplicatori dell’informazione: si sono occupati di lei dal New York Times al Wall Street Journal, dall’Harvard Business Review a Wired fino al comico Stephen Colbert e a Oprah Winfrey, che l’ha definita “una delle 20 donne più ispirate del mondo”. Se raccontassi a Jane l’aneddoto che ho riportato all’inizio di questo testo è probabile che ne sarebbe rallegrata. Non penso di cadere troppo lontano dall’albero affermando che la mia “Agenzia investigativa” le sembrerebbe una buona case history, per quanto rudimentale e analogica, di “gioco immersivo”: una delle pietre angolari sui cui poggiano le sue teorie in merito ai giochi in generale e al loro potenziale salvifico nello specifico.
Secondo McGonigal – che a metà degli anni Zero ha speso più di un paper per chiarire questo concetto – ciò che rende immersivo un gioco, al di là e più della sua struttura intrinseca, è la volontà, ferma e consapevole (qualcosa di simile, ma più radicale, alla sospensione dell’incredulità richiesta da un’opera di fiction non interattiva), dei suoi giocatori di “fare come se” il gioco fosse reale. Si tratta di una strategia basilare, quasi istintiva, messa in atto dai giocatori per massimizzare il divertimento che ne traggono.
Contro il parere di esperti di vari campi, perlopiù psicologi, che vedono nei giochi immersivi di massa uno strumento di alterazione nel principio di realtà dei giocatori, Jane sostiene che qualunque gamer è pienamente consapevole del fatto di essere “dentro” un gioco, solo sceglie deliberatamente di giocare al massimo livello di coinvolgimento, ignorando, altrettanto deliberatamente, qualunque indizio che lo indurrebbe a constatare che, di fatto, si tratta “soltanto di un gioco” (peraltro nella galassia noumenica in cui orbita JMG, l’espressione “soltanto un gioco” è pressoché bandita). Riprendendo una formulazione del teorico della performance Richard Schechner, secondo McGonigal la differenza tra l’intrattenimento che offrono i (video)giochi immersivi e una “frode del reale” sta tutta nella differenza tra le espressioni inglesi “make believe” e “make belief ”: “La prima attitudine – scrive – protegge con cura i confini tra ciò che è reale e ciò che fingiamo consapevolmente che lo sia, mentre la seconda li confonde intenzionalmente e, a volte, maliziosamente”.
Per McGonigal ciò che rende immersivo un gioco, al di là e più della sua struttura intrinseca, è la volontà, ferma e consapevole, dei suoi giocatori di “fare come se” il gioco fosse reale.
“I’m not good at real life”
Nonostante Jane abbia speso i suoi migliori sforzi intellettuali per sgombrare il campo dai pregiudizi che circondano i videogiochi, uno apparentemente non l’ha mai impensierita troppo: l’accusa di rappresentare una forma di fuga dalla realtà. Per Jane, la componente di escapismo insita in qualunque esperienza ludica non è un difetto, tutt’altro. È esattamente ciò che rende i giochi tanto interessanti e, potenzialmente, in grado di migliorare il mondo. In un famoso keynote tenuto al TED e intitolato eloquentemente “Gaming can make a better world”, Jane McGonigal ha mostrato una slide di se stessa con in mano un cartello “I’m not good at real life”, mentre il suo ultimo libro si intitola, con altrettanta eloquenza, Reality is broken (edito in Italia da Apogeo con il titolo La realtà in gioco). Secondo l’autrice, comparata a un videogioco, la quotidianità si rivela sub-ottimale e deludente, sostanzialmente “difettosa”. Mentre i quattro tratti salienti per una definizione elegante di “gioco” (un obiettivo chiaro a cui tendere, delle regole, un sistema di feedback e la volontarietà della partecipazione) stimolano i ricettori della felicità e il desiderio di migliorarsi sottoponendosi a nuove sfide sempre più complesse, la realtà, e in particolare il lavoro tradizionale, quotidiano e non scelto liberamente, li deprimono.
Ribaltando un archetipo consolidato, JMG sostiene che i giochi non sono l’opposto del lavoro/impegno bensì una forma di “duro lavoro scelto liberamente” (una delle sue definizioni di gioco preferite è quella del filosofo Bernard Suits: “Giocare un gioco è il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari”), che presenta un sistema d’incentivi senza pari in nessun’altra attività umana. Superando infatti una sfida – per esempio in un gioco di ruolo come la versione online di World of Warcraft (WoW) – riceviamo una gratificazione immediatamente quantificabile nel miglioramento del nostro avatar, che semplicemente non ha corrispettivi nell’esperienza di tutti i giorni.
I quattro superpoteri
In sintesi, per Jane i videogiochi ci rendono “una versione migliore di noi stessi”. Nel corso del keynote al TED già citato, Jane elenca i quattro superpoteri (li chiama proprio così) che sviluppano i gamer abituali, in particolare quelli che frequentano ambienti multiplayer online come WoW:
– OTTIMISMO nel superamento delle sfide e degli ostacoli;
– FIDUCIA nel prossimo per risolvere situazioni complesse;
– PRODUTTIVITA’ creativa derivata dal fatto che stanno svolgendo un lavoro duro liberamente scelto;
– POSSESSO di un senso epico e grandioso delle loro azioni (in un gioco come World of Warcraft può infatti capitare che a un team di giocatori venga richiesto, letteralmente, di salvare il mondo in cui si trovano immersi).
La combinazione di questi fattori produce un’attitudine proattiva riguardo alle sfide, una sorta di eudemonismo videoludico che, sempre secondo McGonigal, non dobbiamo fare altro che indirizzare verso la risoluzione delle problematiche che affliggono il pianeta. O, viceversa, sottoporre alle grandi masse di gamer i problemi del mondo, formulandoli come se fossero le sfide di un videogioco.
In altre parole: rendere la realtà simile a un gioco, gamificarla. Dotare i problemi reali di tutti i requisiti e sistemi d’incentivi che definiscono un gioco (regole, feedback, obiettivi etc.). All’inizio dello stesso keynote, JMG dà in pasto al pubblico una cifra esorbitante: “Oggi ci sono circa 500 milioni di gamer al mondo che spendono complessivamente 3 miliardi di ore settimanali giocando”.
Sentendo che la platea sussulta in mormorii, Jane aggiunge non senza un certo gusto per l’effetto scenico: “Non sono abbastanza, dobbiamo arrivare a 21 miliardi entro i prossimi vent’anni”. Facendo un breve calcolo: se la media quotidiana di gioco di un gamer è circa di un’ora, significa che per raggiungere 21 miliardi di ore il numero di giocatori mondiali dovrebbe crescere fino a tre miliardi e mezzo, metà dell’intera popolazione del pianeta. Ovviamente questa moltiplicazione per sette dei gamer dovrà essere strettamente funzionale al loro impiego in cause importanti come la soluzione del problema della fame nel mondo o dell’esaurimento delle risorse energetiche.
D’altronde, ribaltando un altro archetipo culturale che vede nei giochi una forma di svago senza scopo, McGonigal è convinta che un gioco debba sempre avere un fine, altrimenti è un gioco privo d’importanza.
Ribaltando un altro archetipo culturale che vede nei giochi una forma di svago senza scopo, è convinta che un gioco debba sempre avere un fine, altrimenti è privo d’importanza.
Un mondo senza petrolio
McGonigal ha messo le sue speculazioni alla prova della pratica, progettando alcuni videogiochi online. Il primo a ottenere una certa attenzione è stato World Without Oil (WWO), un gioco online del 2007, ambientato in un futuro potenziale (il payoff era “Play it – before you live it”) in cui l’umanità ha esaurito il petrolio. Tramite un’interfaccia che presentava alcuni parametri utili a orientarlo nelle sue scelte, al giocatore che decideva liberamente di partecipare era richiesto di immergersi in questa realtà alternativa con l’obiettivo di trovare soluzioni innovative ad alcuni problemi pratici di sopravvivenza. Ovviamente c’erano alcune regole da rispettare e a ogni soluzione equivaleva un coefficiente di “punti potenziamento” al profilo del giocatore (feedback). Le soluzioni venivano poi pubblicate sui blog personali dei gamer (il gioco chiedeva, tra l’altro, di tenere un diario) e su una serie di piattaforme collegate al progetto (blog ufficiale, Twitter, canali YouTube eccetera) e, alla fine del gioco, furono inoltrate a parti della comunità scientifica e politica americana per una valutazione d’insieme. WWO durò tre mesi, tra marzo e giugno 2007, e superò i 1.500 giocatori complessivi. “Nel corso di quei mesi ci sono pervenute migliaia di idee brillanti – ha ricordato Jane qualche anno dopo al TED – e molte delle persone che hanno preso parte a WWO hanno poi continuato a portare avanti le abitudini a basso impatto energetico che avevano appreso giocando”.
Sembra tutto bellissimo, no?
Superbetter
Apparentemente l’unico difetto di World Without Oil è quello di essere un progetto terminato cinque anni fa. Andando oggi sul sito worldwithoutoil.org si trova soltanto un consuntivo degli achievement. Nel frattempo però McGonigal ha sviluppato altri giochi online. Ho quindi deciso di testare l’ultimo in ordine di tempo, SuperBetter, che Jane ha presentato solo pochi mesi fa nel corso di un recente keynote al TED. SB (superbetter.com) è essenzialmente un gioco che punta sul potenziamento dell’individuo in termini di forma fisica generale. Sbrigate le formalità per l’iscrizione per prima cosa si deve stabilire il proprio scopo. È possibile scegliere tra “perdere peso”, “combattere lo stress”, “fare più attività fisica” e altre cose del genere. Dal momento che peso 65 chili, non ho grandissimi problemi di stress e gioco a basket e a calcio quasi due volte alla settimana ho optato per “smettere di fumare”. A quel punto il programma ha creato il mio profilo e in capo a pochi minuti mi sono trovato a osservare un’interfaccia molto simile a quella di Facebook.
Mi è bastata una settimana per capire che SB poteva fare poco per aiutarmi a dare un taglio alla nicotina. una volta che, con l’iscrizione, ho stabilito di voler partecipare e ho successivamente deciso il mio obiettivo, SuperBetter mi ha dato poi la possibilità di settare le mie regole per auto-migliorarmi: ho potuto pianificare uno scadenziario, ho potuto dividere il mio habitat sociale in buoni e cattivi (i buoni sono le persone che ho scelto per darmi supporto nell’impresa, i cattivi sono quelli che potevano indurmi in tentazione, ovviamente, nel mio caso, altri fumatori nella mia cerchia di amici) e configurare ulteriori condizioni, preliminari all’avvio del gioco vero e proprio. Dopodiché il programma ha iniziato a propormi una serie di sfide da superare nella realtà (tutte attinenti all’astinenza da tabacco, è chiaro) e, presupponendo la mia buona fede, mi ha trasmesso dei feedback sotto forma di punti ogni volta che dichiaravo di averle vinte. È evidente che SB soddisfa sotto ogni punto di vista i quattro requisiti che, secondo JMG, individuano “un gioco”. Purtroppo la soddisfazione di questi requisiti è anche la sola cosa che SB ha in comune con “il gioco”. Ciò che drammaticamente scarseggia in SB sono il divertimento, l’immersione e l’escapismo: tre delle principali ragioni per cui – secondo la stessa McGonigal – molti di noi amano giocare. In mancanza di esse, per quanto ben disposti, è pressoché impossibile trovare incentivi per proseguire l’esperienza. È come se non fosse avvenuto alcun transfert. Di fronte a SuperBetter non mi sono affatto sentito una “versione migliore di me stesso”, “un ottimista” alle prese con una “epica” missione per il benessere dei miei polmoni. Di fronte a SuperBetter mi sono sentito esattamente lo stesso fumatore eccessivo di sempre, alle prese con una versione interattiva di Smettere di fumare è facile, se sai come farlo.
Due settimane dopo
Due settimane dopo aver scritto l’ultima riga qui sopra mi sono ricollegato a SuperBetter. Ho provato nuovamente a trovarci un barlume di divertimento e di stimolo ma non c’è stato verso. Prima di chiudere la finestra del browser ho guardato per l’ultima volta il mio profilo: giaceva abbandonato in un limbo dove la realtà è troppo giocosa e il gioco è troppo reale.
Cesare Alemanni
Scrittore e giornalista, è stato caporedattore di Il Tascabile, Prismo e Studio. Tra il 2012 e il 2016 ha vissuto a Berlino dove ha fondato e diretto Berlin Quarterly, una rivista di narrativa in lingua inglese finalista al Best Magazine Award 2014 di Stack. Tra il 2011 e il 2014 è stato caporedattore cultura di Studio.
Vedi tutti gli articoli di Cesare AlemanniLeggi anche

Fenomeni
Nomadi digitali

Reality
Ti mando al Collegio!

