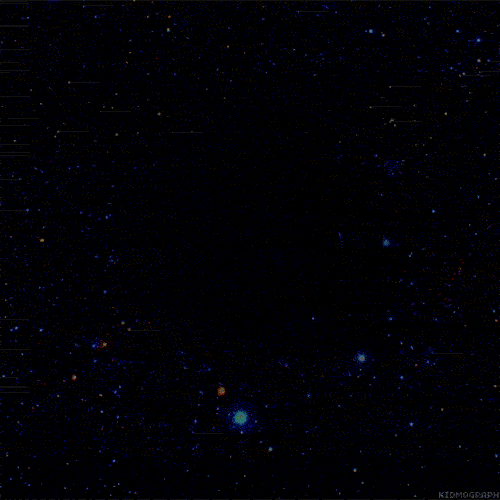
Le news passano sempre più spesso sulle piattaforme digitali. E online sono in vigore regole nuove, a partire dal ruolo sempre più importante del video.

Questo articolo è apparso per la prima volta su LINK Numero 22 - Mediamorfosi 2. Industrie e immaginari dell'audiovisivo digitale del 11 dicembre 2017
Nell’ultimo decennio, i fenomeni di progressiva adozione del digitale da parte di una sempre crescente parte della popolazione – l’ultimo dato disponibile, al marzo 2017, è di 3,8 miliardi di persone al mondo (il 49,7%) che utilizza internet – hanno completamente (s)travolto il mondo dei media come lo abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra in avanti.
Dovendo identificare i momenti topici, i passaggi chiave che hanno segnato l’evoluzione di quella che è identificata come la digital disruption, non si può che partire dal celeberrimo Cluetrain Manifesto e dalle sue novantacinque tesi. È infatti del 1999 il documento di Levine, Locke, Searls e Weinberger sulla sorte di internet e su come il web avrebbe cambiato il linguaggio e la comunicazione delle aziende e dei mercati, che traccia il cambiamento di paradigma a cominciare dalla più celebre e, se non meno compresa, a oggi certamente meno applicata delle sue proposte visionarie: “I mercati sono conversazioni”. Il documento è stato aggiornato a distanza di 16 anni, nel 2015, con 121 nuove tesi, chiamate ora direttamente indizi, New Clues, che al cinquantaduesimo punto ribadiscono che “Avevamo ragione la prima volta: i mercati sono conversazioni”, dopo aver chiarito dall’inizio che “internet non è fatta di filo di rame, fibra di vetro, onde radio, o anche tubi” per evidenziare che se ovviamente la tecnologia è un fattore abilitante sono però le persone, e le loro conversazioni, i loro contenuti e commenti, a rendere la rete quello che è: un ecosistema sociale.
La sfida principale non è comprendere il futuro, quanto avere la capacità di adattarvisi. Nel 2020 continueranno a esistere Repubblica o la Rai, ma questa continuità sarà accompagnata dalla riconfigurazione di ogni singolo bit del contesto mediale in cui opereranno.
Adattarsi al cambiamento
Si tratta di dinamiche ancora oggi prevalentemente incomprese, paradossalmente, proprio da quella che Emily Bell, nel rapporto 2012 della Columbia Journalism School, redatto congiuntamente a C.W. Anderson e a Clay Shirky e dedicato allo stato del giornalismo e dell’editoria, intitolato Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present, definisce l’ex industria dell’informazione, “perché non esiste più l’industria dell’informazione”. Anderson, Bell e Shirky contraddicono l’imprevedibilità, spesso sostenuta per spiegare l’attuale crisi, richiamando previsioni sull’effetto di internet per l’industria dell’informazione che risalgono addirittura alla fine degli anni Ottanta.
La sfida principale non è tanto comprendere il futuro, quanto avere la capacità di adattarvisi. Nel 2020 continueranno a esistere, per esempio, Repubblica o la Rai, ma questa continuità sarà accompagnata dalla riconfigurazione di ogni singolo bit del contesto mediale in cui opereranno. Aumenterà ulteriormente la variabilità. Non stiamo passando da grandi aziende a piccole organizzazioni, e neppure dal giornalismo “lento” a quello “veloce”: le dinamiche sono insieme su più assi. L’effetto principale dei media digitali è che non c’è un effetto principale. Il cambiamento apportato dalla rete, dagli smartphone e dalle app è così vasto da rendere impossibile l’identificazione di un solo elemento chiave.
L’importanza dell’informazione non sta scomparendo. La rilevanza di operatori professionali che vi si dedicano, i giornalisti, neppure. Con l’avvento dei social media, da Twitter a Newswire e al giornalismo partecipativo, i professionisti non sono stati rimpiazzati, ma riallocati a un livello superiore della catena editoriale, passando, o dovendo passare inevitabilmente, dalla produzione iniziale di osservazione della realtà a quella che pone l’accento sulla verifica e sull’interpretazione, dando un senso al flusso di testi, audio, foto e video prodotti dal pubblico. L’idea è che il giornalista si ponga al centro del processo, agendo da collettore di informazioni che provengono dalle fonti tradizionali e non, qualificando così ed elevando il proprio ruolo, altrimenti in declino. Scompaiono la linearità di processo e la passività dell’audience. Parlare di un nuovo ecosistema dell’informazione significa riconoscere che nessuna organizzazione è padrona del suo destino. Relazioni stabilite altrove nell’ecosistema mediale definiscono il contesto; e i cambiamenti nell’ecosistema lo mutano.
Un processo in atto ben identificato e analizzato nella diciassettesima edizione dell’Edelman Trust Barometer di inizio 2017, che spiega come vi sia complessivamente un capovolgimento dell’influenza. Un ribaltamento della vecchia piramide in cui l’autorità e l’influenza delle élite sia nella società in generale sia specificatamente nei media hanno forte influenza sulla maggioranza della popolazione. Infatti, dalla indagine globale – che comprende anche l’Italia, oltre a diverse nazioni del vecchio continente – emerge che l’85% del pubblico ha bassi livelli di fiducia nei confronti di autorità, élite e istituzioni pubbliche, riponendola invece nei loro pari. La fiducia nei media è scarsa nell’82% delle nazioni prese in esame, in 17 Paesi è al livello più basso di sempre. Ed è proprio l’Italia a far parte dei 17 in cui prevale le sfiducia nei confronti dei media, vissuti come il “braccio” delle élite. I media tradizionali, giornali ma ovviamente anche radio e tv, sono quelli che registrano la più grande perdita di fiducia. La fiducia nelle informazioni condivise da conoscenti e familiari è molto superiore a quella riposta negli esperti accademici e nei capitani d’industria. Bisogna parlare con qualcuno, non a qualcuno.
Le scosse subite dalla carta stampata
Di “web 2.0” – tralasciando, per semplicità, il 3.0 e il 4.0 – si parla da oltre un decennio. La linea di demarcazione, essenzialmente, è l’interattività apportata dal digitale. In realtà, questa caratteristica è tanto discussa quanto ben poco praticata, con una dispersione di risorse – anche economiche – a dir poco strabiliante. Le organizzazioni che sfruttano, nel senso positivo del termine, le potenzialità offerte in termini di co-creazione si contano sulla punta delle dita di una mano, o poco più, e anche “le conversazioni” continuano a essere l’eccezione e non la regola.
È in questo scenario che si colloca il crollo della carta stampata. È in questo senso che i video diventano trasversali alle piattaforme social (che stringono accordi con gli editori allo scopo) e ai siti web dei publisher (in cui la parte video è sempre più rilevante, come banalmente dimostrano, per restare ai due principali player dell’informazione online nel nostro Paese, con RepubblicaTV e CorriereTV). Insomma, i video diventano moneta informativa corrente, in modo trasversale agli spazi digitali. La crisi globale ha ovviamente colpito tutti, ma non allo stesso modo. Anzi, c’è chi, comunque, ha continuato a crescere: l’editore tedesco Axel Springer (Bild, Die Welt e un universo di riviste e siti), che ha dichiarato nei suoi bilanci fatturati per 2,6 miliardi di euro nel 2007 e 2,8 miliardi nel 2010, per arrivare ai 3,3 miliardi di euro a chiusura dello scorso anno (con un +28% dal 2010 al 2016). Axel Springer è un editore molto attento alla trasformazione digitale, come dimostra l’acquisizione del pure player di news online Business Insider per 450 milioni o l’investimento di 3 milioni di euro (insieme al New York Times) in Blendle, una startup innovativa che punta a costruire un’alternativa ai paywall per i pagamenti in campo editoriale. Secondo i dati di bilancio del primo semestre 2017 i ricavi da digitale costituiscono ormai ben il 70% del totale.
Per quanto riguarda i quotidiani italiani, il fatturato, comprensivo dei ricavi da pubblicità, passa dai 3.859 milioni di euro del 2007 a 1.860 del 2016, un calo del 51,8% nel corso del decennio. Non va meglio nei periodici, anzi, che perdono il 60,4% negli ultimi dieci anni, passando dai 5.069 milioni di euro nel 2007 a 2.005 milioni nel 2016 (fonte: Ufficio studi associazioni di filiera, 2017). Una conferma della progressiva riduzione dei consumi interni dei prodotti della filiera è fornita dalla dinamica decrescente del rapporto tra spesa per acquisti di libri e giornali e consumi totali delle famiglie, che passa dall’1,39% del 2006 allo 0,91% del 2016 (dati Istat).
Data la forte riduzione dei ricavi pubblicitari, si assiste a un arretramento dell’incidenza degli introiti da pubblicità nella stampa, tanto che le entrate derivanti dagli utenti, dai lettori, rappresentano la fonte di finanziamento prevalente, ma sono anche queste comunque in calo. Complessivamente, si riscontra un sempre minore accesso a questo mezzo informativo da parte della popolazione italiana, come appare evidente considerando l’esposizione ai quotidiani che, nel giorno medio, è pari a circa il 28% e, nella settimana media, non raggiunge il 50% (precisamente, il 49,2%). Occorre evidenziare come gli editori incontrino difficoltà a valorizzare il prodotto tradizionale nel mondo digitale: difatti le copie digitali, che costituiscono circa il 12% del totale delle copie vendute, rappresentano solo il 6% dei ricavi, dato che il rapporto tra ricavo medio unitario per copia digitale e cartacea risulta ancora molto basso, pari a 0,42. Mentre gli abbonamenti sono in ripresa negli Stati Uniti, nei Paesi dell’Europa centrale e meridionale (Grecia, Italia e Spagna) la gran parte dei contenuti online rimane libera, gratuita, in quanto non vi è una cultura della sottoscrizione su cui costruire per la stampa quotidiana e periodica.
L’attività tradizionale, sul cartaceo, resta il core business di gran parte dei publisher che, al di là delle dichiarazioni di intenti, di fatto tentano di mettere in atto strategie di difesa dei ricavi derivanti dalla carta stampata, seppure molto spesso questo avvenga in maniera scomposta, e dunque poco efficace. Anche i periodici non hanno ancora trovato una loro dimensione online. Complessivamente attirano, al lordo delle duplicazioni, 1,3 milioni di utenti unici nel giorno medio, meno del solo Repubblica.it. Se si esclude Donna Moderna, dove però le aggregazioni frutto di accordi commerciali pesano oltre il 50% del totale, anche brand come Tv, Sorrisi e Canzoni hanno volumi di traffico risicatissimi. Le due testate con maggior connotazione informativa, L’Espresso e Panorama, raccolgono online un interesse contenuto.
Solo digitale
Gli editori nativi digitali producono per il web e offrono agli utenti della rete contenuti informativi, di carattere nazionale e locale, di taglio generalista o specializzato, con accentuata attenzione per l’aggiornamento costante, per le immagini, i video e i contributi live in tempo reale. Gli editori online pure player presentano una struttura dei ricavi piuttosto sbilanciata sul versante pubblicitario, essendo le offerte informative a pagamento limitate per lo più alla proposizione di contenuti con un elevato livello di specializzazione in determinati settori e rivolti a nicchie specifiche. Considerato lo sbilanciamento nella struttura dei ricavi degli editori all digital e i tempi sempre più ridotti, che rischiano di comportare maggiore velocità a scapito della qualità dell’informazione, la sfida per coloro che operano sul web è quindi assicurare qualità, tempismo e rilevanza per creare coinvolgimento da parte dei lettori.
In un panorama nazionale in cui i pure player dell’informazione digitale continuano a ricercare la sostenibilità economica ma spesso hanno conti in profondo rosso, Ciao People, editore di Fanpage, da molto tempo invece riesce a generare dei profitti grazie anche a branded content, native advertising e altre iniziative in grado di generare ricavi, nei quali il gruppo editoriale è stato pioniere nel nostro Paese. Aree di ricavo sempre più essenziali per sfuggire alla “dittatura del click”. È il caso di The Economist e Financial Times, che da tempo sperimentano la vendita di spazi pubblicitari non a Cpm, a migliaia di impression, di esposizioni al messaggio pubblicitario, peraltro tutte da dimostrare, visto il diffuso utilizzo di applicativi di ad blocking, per passare a una vendita basata sul tempo di esposizione al contenuto informativo, e di riflesso pubblicitario. Una visione differente a cui ha aderito più di recente anche il Guardian, che consiste nell’adozione della vendita a Cph (cost per hour), sulla base dell’idea che maggiore è il tempo speso sul sito della testata e maggiori sono l’engagement, il coinvolgimento del lettore e dunque l’attenzione, anche, verso gli annunci pubblicitari. Questo criterio peraltro consentirebbe di omologare la vendita di spazi pubblicitari online a quelli su altri media, rendendo omogeneo il confronto.
Ancora, il New York Times da tempo ha creato una business unit ad hoc, T Brand Studio, che nelle parole di Mark Thompson, president and chief executive officer di The New York Times Company, “has become the industry leader in creating digital ad innovation and branded content, and it has been a great success story for the Times Company, doubling revenues in 2015 from the year prior”. Per restare in Europa, Les Echos a giugno 2015 ha annunciato il lancio di una piattaforma digitale per servizi alle imprese. Parzialmente finanziato dal fondo di Google – per 2 milioni di euro, su un bilancio totale di circa 4 milioni – questa piattaforma riunisce le offerte di servizi per le imprese attualmente proposte dal gruppo: un deposito di note legali, consultazioni di gara, ricerche di mercato e strumenti di comunicazione.
Sempre in Francia fa scuola il caso Mediapart. Il pensiero più diffuso, in un mondo caratterizzato dall’erosione dei fatturati e degli introiti pubblicitari, è che il giornalismo investigativo sia finanziariamente impraticabile per le società editoriali, visto che fare inchieste costa in termini di risorse da impiegare, di spese da sostenere e anche di pressioni politiche ed economiche da respingere se gli articoli sono scomodi. Invece la case history di Mediapart, sito di giornalismo investigativo in continua crescita, che fa utili, celebre per aver raccontato alcuni grandi scandali della politica francese, e confeziona tre “edizioni” giornaliere dimostra che si tratta dell’ennesima congettura errata. In un articolo pubblicato il 22 agosto 2017, il presidente e fondatore del giornale online, Edwy Plenel, ha sottolineato come “il modello economico ha conseguenze sulla qualità del giornalismo. Non solo sul valore dell’azienda che lo produce, ma anche sul valore della stessa informazione”. Insomma, ha spiegato il presidente-fondatore dell’azienda, “per riprendere la distinzione classica tra valore d’uso (utilità di un prodotto) e valore di scambio (a quanto lo si acquista), se il valore di scambio dell’informazione è zero, il suo valore d’uso – cioè la sua utilità democratica per i lettori – finirà anch’esso per tendere a zero. Il risultato finale è la corruzione dell’informazione attraverso l’intrattenimento, il cui modello economico si fonda su un’audience allargata e sulla gratuità”. Questa strategia ha portato il pure player francese dai 614.000 euro di fatturato del primo anno agli 11,3 milioni del 2016, raggiungendo il break even tre anni dopo la nascita (nel 2010) e generando profitti a partire dal 2011.
Anche i video, come anticipato, hanno un peso crescente sia in termini di tipologia di contenuti sia di relativa opportunità di monetizzazione. Il caso più eclatante è rappresentato dalla testata all digital NowThis che, dopo aver lanciato a maggio di quest’anno venti serie video originali, sta collaborando con Thrive Global, startup di salute e benessere creata dalla fondatrice di Huffington Post, Arianna Huffington, per creare una serie di video per le donne millennial su come “ottenere il benessere digitale” e l’equilibrio tra lavoro e vita. Thrive Global raggiungerà il pubblico millennial dell’editore sui social media utilizzando i suoi video social-first. NowThis conta oltre 2,5 miliardi di visualizzazioni al mese attraverso le varie piattaforme. La partnership comprende 24 video co-branded pubblicati quotidianamente sui canali social di NowThis “Her” e Thrive Global, creando un’offerta informativa verticale nell’area del wellness. Un altro mondo è possibile.
I video hanno un peso crescente sia nella tipologia di contenuti sia nelle opportunità di monetizzazione. Il caso più eclatante è rappresentato dalla testata all digital NowThis, che con i suoi video social-first conta oltre 2,5 miliardi di visualizzazioni al mese sulle varie piattaforme.
I social, primo accesso all’informazione
Se la capacità di attirare persone dai social al proprio sito è un punto di forza di Fanpage, con il 51% dei visitatori che arrivano proprio dal social network più popoloso, Facebook (secondo quanto riportato sul sito corporate di Ciao People), è al tempo stesso una possibile debolezza, poiché si è legati a doppio filo, con tutte le incertezze del caso, alle scelte spesso unilaterali di Facebook. Nonostante l’aumento degli aggregatori, social media e ricerca restano i gateway più importanti ai contenuti online, al fianco del traffico diretto verso i siti e delle applicazioni. Guardando i modi preferiti di arrivare ai contenuti informativi emerge che i siti web e le applicazioni – accesso diretto – restano leggermente in vantaggio rispetto a ricerca e social. Ma se si aggiungono tutte le altre modalità, i due terzi degli utenti di internet (65%) preferiscono usare una “porta laterale”; e salgono a tre quarti (73%) per quelli sotto i 35 anni.
Le persone, anche nel nostro Paese, passano una grande quantità del loro tempo online sui social, e in particolare su Facebook. Andiamo lì come una volta andavamo al bar a incontrare, a conoscere i giornali. I social sono piattaforme di distribuzione del contenuto ma, soprattutto, luoghi di relazione con le persone. Dobbiamo capire bene chi sono, quali sono i loro interessi, le loro preferenze, per poi – continuando nella metafora – andare via dal bar per bere qualcosa insieme a casa nostra. Facebook è un bar, una piazza di paese dove incontrare persone, comprenderne interessi, motivazioni, aspirazioni e, soprattutto, dati, da interpretare correttamente per tradurli e renderli disponibili a casa propria, nel proprio sito, nei prodotti e nei servizi forniti. Una “casa” dove ci sono comunità d’interesse, anche di nicchia, aree di partecipazione e discussione sui temi rilevanti. Ora però vi è una presenza scellerata sui social da parte di quasi tutti i newsbrand italiani, che considerano i social prevalentemente, se non solo, come repository dove collocare link ai loro articoli, con l’obiettivo di dragare il maggior traffico possibile senza alcuna gestione della community, senza interesse per l’engagement e, soprattutto, senza attenzione al social media mining. Ma i social non sono piattaforme di distribuzione, mettiamocelo in testa.
Sperimentazione: strategie e tentativi
Ben diversa la situazione a livello internazionale, dove l’approccio, la volontà di sperimentazione e l’organizzazione del lavoro, nonché le competenze necessarie, segnano un profondo divario rispetto a quanto accade in Italia, a cominciare dal fatto che fuori dai nostri confini non vi è traccia di quella cattiva pratica di proporre contenuti distinti nella versione online/digitale rispetto a quella cartacea. Un elemento che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, rende l’immagine dei newsbrand italiani “disallineata”, incoerente, e dunque potenzialmente pericolosa per la percezione del marchio. Senza arrivare al New York Times, che da tempo ha ribaltato l’approccio, separando la redazione del cartaceo dal resto dei giornalisti, affinché i ritmi di lavoro online non siano condizionati dai tempi della carta, pubblicando spesso prima online e poi su carta le notizie di maggior rilevanza, all’estero praticamente tutte le redazioni sono integrate, con i giornalisti che lavorano assieme, in maniera sinergica.
Integrazione di cui praticamente non si ha traccia in Italia, se si esclude il Digital e Visual Lab di Gedi, lanciato in via sperimentale a inizio 2017, che ha un gruppo di lavoro composto da tre giornalisti, di cui due junior, tre designer, dei quali due sono dedicati ai contenitori e uno ai contenuti, e due sviluppatori, dando così vita a un team multidisciplinare e trasversale alle redazioni invece di un satellite di servizio. Nel nostro Paese resta infatti assolutamente prevalente un’organizzazione del lavoro tradizionale, con la maggior parte dei giornalisti concentrati sul cartaceo e la redazione web o web desk, come è spesso definito separata, considerata il “figlio povero”, e con tutti i ritmi lavorativi, a cominciare dalle riunioni di redazione, ancora oggi incentrate sul quotidiano del giorno dopo. Lo stesso dicasi per le competenze, con per esempio i data journalist ancor oggi esternalizzati e utilizzati una tantum, o il social media editor, versione per i publisher di quello che è il social media strategist per i brand, che è un giornalista a cui è affidato anche il compito di definire le strategie di presenza sui social mentre continua ad assolvere al suo lavoro tradizionale. Cosa che altrove non succede, come per il team di data journalist del Guardian e i ruoli specializzati come l’editor degli standard della redazione o il cyber security editor.
Sia nel Regno Unito che Oltreoceano, l’approccio e le relative pratiche sono distinte da quelle nostrane. Vi è in primis un orientamento maggiore nei confronti del lettore, sempre focus principale dei giornali. Si assiste a una crescente pressione per far pagare i contenuti online dei quotidiani, con due approcci di fondo prevalenti: il metered paywall (introdotto anche dal Corriere della sera con scarso successo a inizio 2016 – gli abbonati dichiarati a metà 2017 sono 30.000), la possibilità di leggere solo un certo numero di articoli gratuitamente (in un mese o in una settimana) per poi essere costretti a pagare per continuare a fruire dei contenuti online; oppure, in alternativa, si spinge l’idea di membership (come nel caso del Guardian che di recente ha raggiunto 200.000 “membri”), dove il concetto di fondo è di creare uno o più pacchetti di offerta che oltre alle news offrano anche benefici materiali (sconti, offerte) e immateriali (esclusività, appartenenza al club della testata).
Il caso di maggior successo per il metered paywall è certamente quello del New York Times, che ha annunciato risultati straordinari per il primo semestre 2017, con i ricavi complessivamente aumentati del 12,6%, che nel secondo trimestre crescono addirittura del 13,9%. Per la prima volta dal 2014, nel secondo trimestre 2017 tornano a crescere i ricavi pubblicitari (+0,8%) e le revenue da advertising digitale registrano una crescita del 13,7%, fino a rappresentare il 41,7% dei ricavi pubblicitari. Gli abbonati solo alla versione digitale del quotidiano sorpassano i due milioni di persone (2,3 per la precisione), con un incremento del 46,5% che porta il progressivo dei primi sei mesi a un aumento del 43,3% rispetto all’anno precedente. Risultati che arrivano grazie alla qualità elevata dei contenuti prodotti dalla redazione del quotidiano statunitense, ma che altrettanto sicuramente sono il frutto dell’indirizzo strategico definito nel report The New York Times 2020, documento pubblicato a inizio 2017, che segna il passaggio definitivo dal giornale come strumento per la vendita di pubblico agli inserzionisti al giornale come elemento di un club che mette al centro il lettore.
“È chiaro che il futuro offre grandi opportunità. È anche disseminato di trabocchetti. Il trucco consiste nell’evitare i trabocchetti, prendere al balzo le opportunità e rientrare a casa per l’ora di cena”, scriveva Woody Allen in Effetti collaterali.
Pier Luca Santoro
Esperto di marketing, comunicazione e sales intelligence. Project Manager @DataMediaHub. Dal 1998 opera come consulente per progetti di posizionamento strategico, organizzazione, comunicazione e formazione per aziende pubbliche e private, associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche. Dal 1987 in poi è stato responsabile del marketing e dell’organizzazione commerciale di grandi imprese (Star, Giuliani, Bonomelli).
Vedi tutti gli articoli di Pier Luca Santoro


