
Cronache di giorni e notti passati online, a rivedere le serie e i film della propria giovinezza. Una ricerca, spesso vana, di memorie che ci rassicurino.
Kan ma ya kan (C’era e non c’era una volta)
“C’era una volta…” non è solo il più celebre degli incipit favoleschi. Nell’intraducibile ambiguità linguistica della lingua araba troviamo le fondamenta dello storytelling: il primo passo all’ingresso di quel territorio tra realtà e finzione – il regno del verosimile – in cui il tempo e lo spazio, ascissa e ordinata di ciò che per noi sensibilmente esiste, cessano di essere strumenti del Caso, o di Dio, per diventare gli attrezzi del mestiere del narratore.
Anche nel tempo accelerato dei nostri giorni, capita a tutti di rileggere un libro. E non solo nel senso che, per vergogna di non aver letto un classico da ragazzi, si scrive su Facebook che lo si sta “rileggendo” per condividere il proprio entusiasmo senza essere giudicati fuori tempo massimo. Come capita a tutti di riascoltare vecchie canzoni, specie quelle che sentivamo quando non avevamo ancora né barba, né iPod, capaci di restituirci, confusamente, le sensazioni di com’eravamo quando quello che oggi siamo diventati era ancora un “che ne sarà di noi?”.
Anche per chi, come la mia generazione, si è formato nella società dell’immagine, la nostalgia è un sentimento comune, non estraneo all’industria culturale, ma parte integrante di essa, oggi alla base della miriade di serie tv revival che fondano il successo sul recupero di una memoria recente frettolosamente storicizzata – dagli anni Settanta ai Novanta, passando per gli Ottanta di cui credevamo non avremmo mai sentito la mancanza – che presto scavallerà il millennio facendoci rimpiangere i primi anni Zero.
Ma quella che oggi sperimentiamo è una nuova forma di nostalgia. Se il presupposto di ogni nostalgia è qualcosa da rimpiangere, un senso di mancanza, fino a pochi anni fa, materialmente, la soddisfazione del nostalgico presupponeva attesa e ricerca. Un tempo tecnico capace di dissuaderci o motivarci, alla ricerca di una vhs prima e di un dvd poi, non in nostro possesso. Per rivedere Mamma ho perso l’aereo, per esempio, un film che come chiunque nato nella seconda metà degli anni Ottanta avrò visto almeno una quindicina di volte ma non ho mai posseduto, ho sempre dovuto attendere la programmazione tv delle feste (lo stesso valeva per Una poltrona per due, Miracolo nella 34a strada e altri grandi classici natalizi). Ora, anche se siamo in piena estate, come per la frutta di stagione, che grazie alle serre ha perso sapore ma acquisito immediata reperibilità tutto l’anno, mi basta digitare su Google “Mamma ho perso l’aereo strea…”, e subito compare un sequenza di siti che portano a un link per lo streaming. Il tempo di mettere su un caffè, e la sensazione cardine della nostalgia pre-internet – la mancanza – è sparita.
Se i libri amati siamo ancora abituati a ripescarli dalle nostre disordinatissime librerie, o a ricomprarli, e le canzoni, nei dischi, nelle compilation, o in macchina, in radio, sono sempre state più immediate da raggiungere, il trionfo della nostalgia 2.0 a cui assistiamo riguarda soprattutto film e serie (anzi, telefilm), programmi di intrattenimento, quel cortocircuito spazio-temporale di immagini in movimento su cui si è fondata la coscienza collettiva di chi è nato a ridosso del crollo del muro di Berlino.
“Che hai fatto in tutti questi anni?”
Sicuramente, non sono andato a letto presto. Prima di spegnere la luce (più quella azzurrina del pc che quella fioca dell’abat-jour) ho rivisto, e rivisto, e rivisto tutto quello che mi passava per la testa. Rivedere, più che vedere, è diventata la cifra estetica del nostro piacere. Da trentenne pigro e bulimico, la mia curiosità ha ceduto il passo a un certo conservatorismo, più comodo, più confortevole. Vedere cose nuove mi interessa e mi sorprende meno che rivedere le amate “cose vecchie”. Me ne sono convinto ieri sera, rivedendo C’era una volta in America. Ne parlavo a cena con gli amici, e rientrato a casa ecco Noodles in “diretta streaming” da una fumeria d’oppio, alla ricerca di un rassicurante torpore che mettesse a tacere gli spettri del rimorso, con lo squillo reiterato di un telefono che, apparentemente senza contraltare visivo, continuava a martellare la sua mente di fuggiasco e la mia di spettatore durante il primo memorabile flashback.
Il telefono, memento del “tradimento” di Noodles, proseguirà a squillare inesorabile nella sua mente per decenni: le note della colonna sonora di Ennio Morricone mixate nella malinconica melodia di Yesterday dei Beatles. Un cortocircuito sonoro-temporale che nella mia testa simboleggia perfettamente il filo logico-emotivo che lega tutte le mie rivisioni, una ragnatela di vasi comunicanti apparentemente sconnessi tenuti insieme solo dalle bave del desiderio della rivisione.
Nessuna pietà per nessuno. Se la rivisione tradisce le aspettative, dobbiamo sparare a zero. Nell’anno in cui, dopo i profetici 25, torna Twin Peaks, non potevamo non rivedercela tutta dal principio. Però: alzi la mano chi è riuscito ad arrivare in fondo.
“Il tempo non può scalfire”
Ci sono serie di culto che non subiscono l’effetto del tempo. Ranma ½ tiene perfettamente la seconda visione, grazie all’ironia e al ritmo comico delle puntate e dei personaggi, rispetto a cartoni più epici ma più polverosi. Quando in primavera l’ho ricominciato dall’inizio, seguendo l’esempio di un amico che lo stava rivedendo con la fidanzata, a differenza di quello che mi era successo con C’era una volta in America – in cui le atmosfere che ricordavo nitidissime avevano prevalso così brutalmente sugli elementi della trama che ricordavo solo confusamente – di Ranma ½ ricordavo ogni personaggio, ogni combattimento, ogni turbamento erotico. Ogni dettaglio mi si è riproposto esattamente nello stesso modo in cui lo avevo vissuto. E così mi sono goduto l’intera rivisione di una saga antiepica che ha sessualizzato tutta la mia generazione al pari di Non è la Rai.
Ah, Non è la Rai! Ne riguardo spezzoni su YouTube da quando la morte di Boncompagni me l’ha fatto rimpiangere. Grazie al sublime esercizio della nostalgia 2.0, che altera il tempo restituendoci il senso profondo della relatività tanto cara agli scienziati e agli amanti delle storie sci-fi, mentre Sky vorrebbe spingermi in avanti, nel 1993, mi riguardo la scena di 1992. La serie, quella con la ragazzina che balla davanti al televisore, mio contraltare di maschietto eccitato che restava immobile, ipnotizzato, sul divano. E così eccomi a caccia delle puntate vere e proprie, stavolta a letto, con il portatile sulle ginocchia, a commuovermi guardando Ambra che dice, fra mille moine: “Il Padreterno tiene per Berlusconi e Satana per Occhetto”. Attraverso il colpo di coda del kitsch degli anni Ottanta, dal titolo emblematico – Non è la Rai – eccola sferrare il colpo di grazia che la tv commerciale assestò a quella di stato, il grigiore etico di massa della stagione “morale” di Tangentopoli fatto deflagrare con una sgargiante esplosione individuale di edonismo policromo. Qualcosa di cui allora, nel 1994, naturalmente non capivo nulla, limitandomi a supplicare mia mamma, che elegantemente costernata evitava inutili dibattiti, di votare il capo di Rti come suggeriva l’amore della mia vita con l’auricolare.
“Io avrei puntato tutto su di te” (“E avresti perso”)
Nel vortice dello streaming della nostalgia 2.0 i cartoni animati rappresentano naturalmente il male di miele di tutti noi trenta-quarantenni. Così, eccomi di fronte a tutte le stagioni dell’Uomo Tigre. E a quelle di Ken il guerriero. E di Holly e Benji. E dei Cavalieri dello zodiaco (per non parlare degli ormai antidiluviani primi robottoni giapponesi). Avendo puntato tutto su di loro, sul piacere che avrei provato nel rivedere quelle saghe su cui ho fondato tutto il mio immaginario virile successivo (sì, se avessi un analista gli direi che la responsabilità di quello che sono se la dividono in parti eguali mia mamma e i cartoni giapponesi!), scopro di aver perso miseramente. Quell’estetica, con mio sommo rammarico, è fuori tempo massimo. E i dialoghi apodittici, i tempi allungati degli scontri a mezz’aria, la parodia clinteastwoodesca dei caratteri dei protagonisti, tanto erano esaltanti allora, quanto diventano sconfortantemente improponibili oggi. Le rivisioni, quasi regolarmente, producono entusiasmo o delusione. Nel primo caso, nel tempo abbiamo sottovalutato quello che avevamo visto, nel secondo l’abbiamo sovraccaricato di significati che non aveva, o che, quantomeno, ha smesso di avere.
Esistono anche eccezionali vie di mezzo. Le montagne russe della figaggine intellettuale ci portano a snobbare o idolatrare quel che vediamo seguendo una contraddittoria logica elitaria. Se Maria De Filippi da qualche anno è entrata nei radar degli intellettuali underpatinati, i fratelli Vanzina lo sono almeno da quando Tarantino ha ribaltato il senso di alto e basso del cinema italiano rendendoci tutti fruitori “cannibali”. Sulla falsariga di questa serie di improponibili visioni rivalutabili con il senno del poi, mi sono rivisto, in sequenza, e con sommo godimento, film “televisivi” come Panarea e Selvaggi. L’idea del me preadolescente che brucia di eccitazione guardandone le infinite repliche su Italia 1 mi lascia abbastanza perplesso. Le continue allusioni e le nudità esibite, un po’ come quelle di Colpo grosso (spezzoni da riguardare subito!), oggi non sconvolgerebbero nemmeno la più rigida educanda. I millennial hanno a disposizione abbonamenti internet illimitati e tutto lo sterminato ed enciclopedizzato porno che vogliono. Allora, di un topless intravisto fugacemente a scuola si parlava per settimane. E nessuno aveva ancora l’età o i soldi per comprare da un’edicolante qualche cassetta piccante per concedersi il lusso dei fermo-immagine.
Il revival del revival è la massima perversione del “rivisionista” di professione. Vacanze di Natale 2000, film del 1999, naturalmente, è la summa della storia d’Italia fino a quel momento. Un’Italia che entrava nel nuovo millennio con la coppia Boldi-De Sica ancora unita e accoglieva una giovanissima Micaela Ramazzotti, oggi icona dei radical chic che guardano e commentano i film di Virzì, che alleggerita dal peso dell’impegno interpretativo, ammaliava adolescenti e padri di famiglia prima della fine del millennio. Un periodo strano, convulso, pieno di promesse e timori, come ogni giro di boa, ma soprattutto un periodo che ci ha visto complici del più grande e misterioso sovvertimento estetico mai messo in atto a memoria d’uomo: l’idolatria per Megan Gale. Erano i tempi della Omnitel (che Dio l’abbia in gloria!) e la giunonica australiana che imperversava nelle pubblicità delle Summer Card era la guest star delle guest star sulle piste da sci di quelle Vacanze di Natale in odore di millennium bug. Come abbiamo potuto trovarla così sexy? Che gusti avevamo, all’epoca? Quanto era più grossolana delle icone di prima e di poi? Il momento topico, alla fine, lascia decisamente interdetti: Megan Gale riscatta l’onore dell’amico sfigato della coppia di amici laureati/commessi facendosi vedere in giro con lui per strada, tra gli applausi della folla. Il tutto, senza neanche un selfie. Ma quanto era difficile soddisfare il nostro narcisismo senza iPhone e social?
Fa spavento a dirsi, ma gli anni di Britney Spears, colonna sonora ideale di quelle discese sulle nevi, i 2000, sono ormai anni da Teche Rai. Vent’anni fa. Due decine, che molto più dei mitici dieci giorni d’ottobre di cui ricorre il centenario, hanno sconvolto radicalmente il nostro mondo (e immaginario).
“Un amico tradito non ha altra scelta: deve sparare”
Gli anni d’oro del grande Real. Gli anni di Happy Days e delle immense compagnie. Gli anni in motorino sempre in due. Quando gli 883 cantavano degli “anni d’oro” si riferivano a un’epoca di cui nessuno di noi aveva la benché minima memoria. Ci univamo a quel coro per il puro piacere di sentirci parte di quell’inno non nostro. Ma il punto è che anche la rivisione compulsiva ha le sue regole. Nessuna pietà, per nessuno. Così, se qualcuno avesse il guizzo di riguardarsi True Detective, potrebbe trovarsi costretto a rivalutare la seconda stagione, con atmosfere visive e solitudini dei personaggi meno scontate di quelle della prima. La cui trama, semplicemente, fa acqua da tutte le parti. Alla prima visione ci siamo tutti esaltati per il detective nichilista interpretato da un superbo Matthew McConaughey. Ma la vera sfida esistenziale (molto più appassionante di quella investigativa) era quella del personaggio interpretato da Woody Harrelson, così “normale”, limitato, fallibile, rinunciatario.
Nessuna pietà per nessuno, si diceva. Se la rivisione tradisce le aspettative, dobbiamo sparare a zero. Nell’anno in cui, dopo i profetici 25, torna Twin Peaks, non potevamo non rivedercela tutta dal principio. Però: alzi la mano chi è riuscito ad arrivare in fondo. Dopo aver riscoperto chi ha ucciso Laura Palmer, semplicemente, la più grande serie televisiva della storia diventa la versione noiosa di The Lady. La surreale brillantezza e lo sfrontato menefreghismo della verosimiglianza che ci avevano esaltato fino a quel momento diventano claustrofobici. Mentre rinunciavo a cercare di ricostruire una mappa mentale di logge bianche e nere, mi sono scoperto ad avere molto più voglia di rivedere la prima stagione di The Lady, appunto, forse meno “elevata”, ma almeno più coerente a se stessa.
Nel vortice dello streaming della nostalgia 2.0 i cartoni animati rappresentano naturalmente il male di miele di tutti noi trenta-quarantenni. Così, eccomi di fronte a tutte le stagioni dell’Uomo Tigre. E a quelle di Ken il guerriero. E di Holly e Benji. E dei Cavalieri dello Zodiaco.
“Nessuno t’amerà mai come ti ho amato io”
In C’era una volta in America, ogni atto d’amore è ridotto a bestiale impulso di sopraffazione. I versi del Cantico dei Cantici recitati sulla spiaggia da Noodles si infrangono nelle grida della donna amata pochi minuti più tardi, durante lo stupro che si consuma sul sedile posteriore di un’auto. L’amore, nel film, non ha nulla di razionale. E non ha nulla di razionale nemmeno il nostro amore per alcune delle nostre rivisioni che, per una ragione o per l’altra, ci fanno sospendere il giudizio e continuare a riguardare “cose brutte” che però amiamo alla follia. Diciamo, l’equivalente audiovisivo, per la mia generazione, di quello che sono stati gli 883 da un punto di vista musicale. Così, La signora in giallo, Il tenente Colombo, L’ispettore Derrick, Perry Mason li rivediamo e li riamiamo perché ci ricordano le nostre nonne. I film di Bud Spencer e Terence Hill, i gol della Coppa America, Tyson che mangia l’orecchio a Holyfield, i Fantozzi, con tutta la scombussolante mutazione emotiva di ilarità e tragedia che producono a seconda del momento in cui li rivediamo, li riamiamo perché ci ricordano i nostri nonni. Poi ci sono le soap delle nostre mamme (Sentieri) e delle nostre zie (Beautiful). E i servizi di informazione edificanti e i documentari geografici dei nostri padri. E poi? Poi ci sono i “nostri” telefilm, quelli di quando marinavamo la scuola con la scusa di una febbre che ci avrebbe fatti crescere di un altro centimetro, almeno. I McGyver, gli A-Team, gli Hazzard delle nostre mattinate a casa alle elementari. Repliche già allora. Non abbiamo fatto altro che continuare a replicare quelle avventure nelle nostre mattinate a casa alla medie, alle superiori, all’università, e poi, in maniera più organizzata, selezionando puntate specifiche o seguendo cronologicamente la storia, saltando qua e là all’abbisogna grazie allo streaming, nel nostro presente da freelance. Uno su tutti: Friends. Che sta su Netflix. Ma anche tutto Sex & the City, facilissimo da reperire. La qualità dello streaming pirata non sarà il massimo, ma aggiunge in realtà la giusta patina al soddisfacimento nostalgico/bulimico di chi, come me, nelle ultime settimane si è rivisto tutto Dawson’s Creek. Trovandolo struggente. Mentre Beverly Hills, che vidi ancora bambino, mi faceva sentire i conflitti di quei ragazzotti californiani decisamente avulsi dai miei, gli adolescenti di Cape Side mi erano talmente vicini anagraficamente che tutto quel che avveniva loro aveva un immediato contraltare nella mia vita. Rivedere quel grumo di sentimentalismo adolescenziale, da adulti, non può che creare qualche imbarazzo. Un imbarazzo che però cede rapidamente il passo alla meraviglia di fare i conti con tutto quel passato ancora tiepido già tutto riassunto nella sigla (anaunauei). Chissà se per i bambini di oggi vedere per la prima volta, e rivedere poi, Stranger Things produrrà lo stesso immutabile cortocircuito nostalgico alla Stand by Me.
“È solo il mio modo di vedere le cose”
Nel suo ritorno a New York alla ricerca di una sorta di inottenibile senso di espiazione, Noodles, cioè David Aaronson, incontra Max, che credeva morto a causa sua, il quale nel frattempo ha assunto le mentite spoglie del senatore Christopher Bailey. Noodles non chiamerà mai per nome Max. “È il tuo modo di vendicarti?”, gli domanda il senatore. Replica Noodles, rifiutandosi di riconoscere la vera identità dell’uomo che ha di fronte: “No. È solo il mio modo di vedere le cose”.
Il nostro modo di rivedere le cose è probabilmente la vera cifra della nostalgia 2.0, una nostalgia che ha dismesso ogni palinsesto e ogni sguardo critico. Prendiamo due opposti modi di mettere in sequenza vecchi spezzoni per dare loro un senso nuovo e soddisfare il bisogno di rivisione dello spettatore televisivo. Blob e Techetechetè. In Blob, la cifra stilistica dominante è l’accostamento ironico e consapevole degli spezzoni audiovisivi più disparati per produrre un senso nuovo e contemporaneo. Come si sa, è una trasmissione epocale, inarrivabile per la levità con cui, anche attraverso una semplice didascalia in sovraimpressione, imprimeva un significato iconoclasta alle immagini di un repertorio talvolta noto e recente, talvolta oscuro e citazionistico, un repertorio che non spettava allo spettatore conoscere alla perfezione, bensì agli autori del programma che venivano appunto dal mondo critico-accademico. In Techetechetè, al contrario, nonostante i filoni tematici, l’utilizzo del repertorio è invece fine a se stesso, una carrellata di filmati delle Teche Rai a uso e consumo del nostalgico, che però è passivamente coinvolto in un sentimento di puro e semplice amarcord organizzato a scopo emozionale.
Lo streaming, a partire dalla mixologia cotta e mangiata di YouTube, funziona in maniera diversa. La ricerca è affidata ai desideri audiovisivi individuali, il godimento deriva dal soffermarsi su dettagli intrinsecamente legati alla propria biografia e stato d’animo. Siamo diventati tutti critici e montatori di un repertorio audiovisivo senza tempo, perché il passato è diventato un eterno presente.
Se per la messa in onda del nuovo Twin Peaks rivedere le prime due stagioni in vista della terza è stato un atto dovuto al bisogno di rimettere in circolo le premesse dell’evento televisivo del 2017, poste 25 anni fa, dalle prime stagioni di Game of Thrones o House of Cards sono passati solo pochi anni. Ma questo non mi ha impedito di riguardarmi le stagioni passate ripartendo dalla prima puntata, per eliminare alla radice quel senso di mancanza alla base della nostalgia per i miei amorali beniamini, e arrivare più motivato e esaltato alle nuove stagioni appena messe in onda o di prossima programmazione.
Vale per più o meno tutte le serie, basta fare un minimo di discernimento tra link cancellati e link rigenerati, tra versioni doppiate e sottotitolate, e il nostro palinsesto di rivisioni diventa un continuo andare a spasso nel tempo, flash-forward e rewind del continuum spaziotemporale che unisce le nostre narrazioni preferite. Sta a noi scegliere il percorso più adatto. Il mio preferito è quello delle commedie romantiche (Pretty Woman, Notting Hill, Quattro matrimoni e un funerale, Harry ti presento Sally), o quello Stalloniano (i Rambo, i Rocky e poi i recentissimi Expendables visti al cinema e perfetti per essere visti saltando da una scena clou all’altra sul portatile), ma va bene qualunque altra forma di retrospettiva che i festival e i cineforum che frequentiamo non prendono in considerazione.
Stretta è la foglia, larga è la via, non esiste storytelling senza nostalgia
Pur volendo fuggire ogni morale, una morale, alla fine di ogni buona storia, c’è sempre. Come ogni favola che si rispetti ha il suo lupo, ogni immaginario collettivo ha i suoi scheletri nell’armadio con cui fare i conti. La nostalgia 2.0 ci porta a riguardarci e a nutrirci delle migliori liti televisive con cui siamo cresciuti: Sgarbi contro Busi davanti a Chiambretti, Sgarbi contro D’Agostino davanti a Giuliano Ferrara, Sgarbi contro Giletti sovrastato dalla voce tonante di Maria De Filippi che dà ragione al critico nel supportare le olgettine, sostenendo orgogliosamente di dovere il suo formidabile successo al fatto che dopo il Maurizio Costanzo Show lei tornava a casa con Costanzo, Sgarbi che resta muto per un’intera puntata di Sgarbi quotidiani…
Un altro classico contemporaneo è imparare a memoria, morbosa rivisione dopo morbosa rivisione, ogni cosa disponibile su internet che attenga alla cronaca nera, vero specchio degli abissi umani e narrativi più inconfessabili: Chi l’ha visto?, Un giorno in pretura, Storie maledette. Chi di noi può dire che Franca Leosini non sia la nostra nonna ideale? Quante volte abbiamo cenato con lei, nelle nostre stanze in affitto, con portatile e piatto sulla stessa scrivania a cui lavoriamo, andando in sollucchero per ogni suo “va detto” e rischiando di farci andare di traverso la pasta col tonno a ogni suo “ditino birichino”?
Ma è l’individualità estemporanea della nostalgia 2.0 la vera morale. La vera libertà che ci offre il web non è politica, o sociale, come vaticinato da certi fanatici della rete, ma culturale. Come nel porno, ognuno oggi è libero di coltivare le proprie perversioni preferite. La mia più inconfessabile riguarda Travaglio. Onnipresente commentatore televisivo, per formazione e cultura, sarebbe il mio nemico giurato. Razionalmente, trovo pretestuosa e raccapricciante quasi ogni cosa che dice e scrive. Eppure, con buona pace della mia fidanzata, che ne resta interdetta, sono come stregato dall’orrore di Travaglio. Così come altri non possono fare a meno di sbirciare l’interno delle lamiere delle macchine incidentate, attratti dai macabri dettagli che potrebbero notare passandoci accanto, non riesco più a prendere sonno se non metto in sottofondo uno degli innumerevoli spettacoli teatrali del nostro fustigatore morale preferito. Li ho rivisti non meno di una dozzina di volte ciascuno. Ormai li conosco a memoria, e non riesco a smettere. Nel tempo alterato della nostalgia 2.0, etica ed estetica diventano via via meno favolesche. Frantumate dalla modalità shuffle delle nostre way of life, si ricompongono per appagarci in modi misteriosi, spingendoci ad abbandonare il sentiero tracciato dall’eroe per seguire con molta più passione le vicende dell’antagonista. Appena finito quest’articolo mi rivedrò (o meglio, mi riascolterò, mezzo addormentato) È stato la mafia. E raggiungerò il mio catartico apice di godimento nostalgico appena spunterà fuori, a spiegazione di tutti i malanni nazionali, il “papello”. Più lupo di così, si muore.
Marco Cubeddu
È nato a Genova nel 1987, vive a Roma, ha pubblicato i romanzi Con una bomba a mano sul cuore (2013) e Pornokiller (2015), collabora con diverse testate tra cui La Lettura del Corriere della Sera, Panorama e Il Secolo XIX. È caporedattore di Nuovi Argomenti.
Vedi tutti gli articoli di Marco CubedduLeggi anche

Icone pop
La signora di The Lady
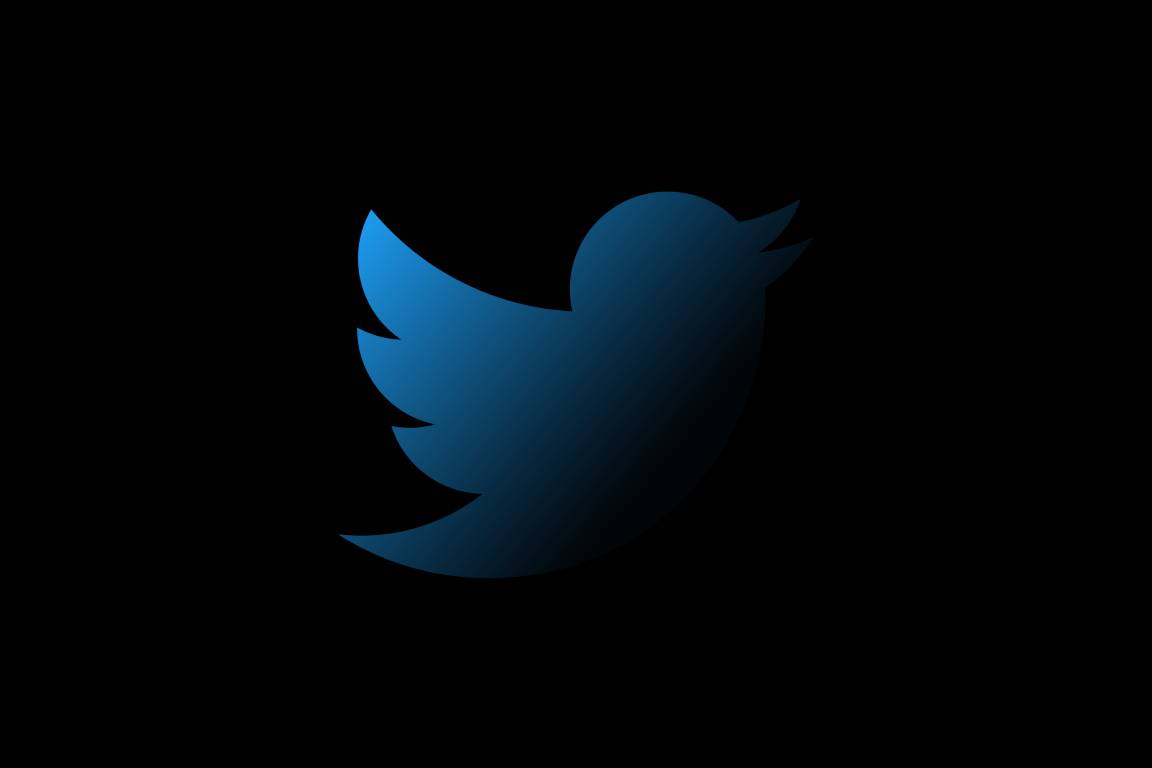
Social
Come muoiono le piattaforme

