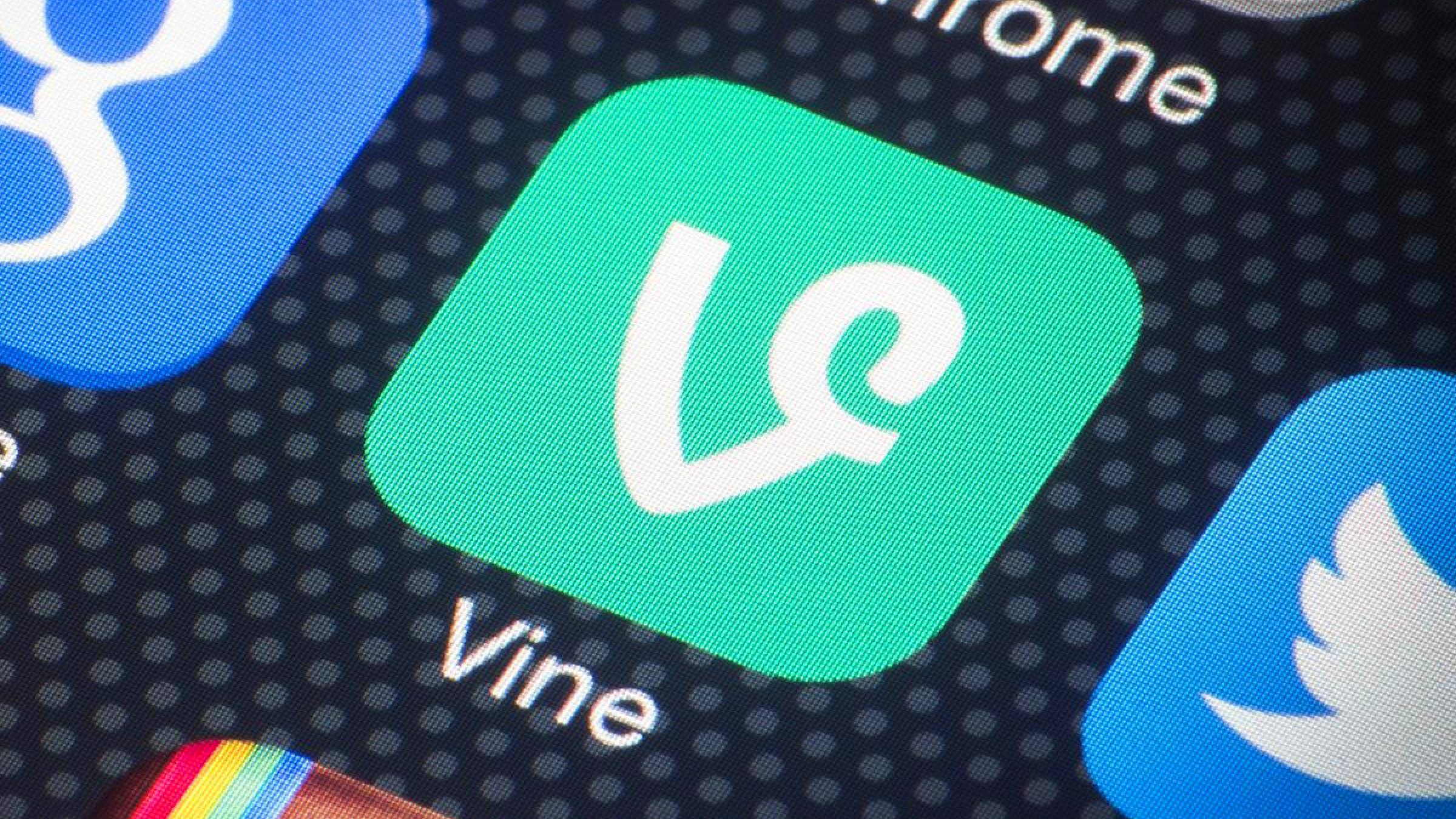
Non sempre le avanguardie creative del mondo social sono coronate da successo. È la storia di Vine, rilevata, coltivata e poi chiusa da Twitter. Se i video brevi e buffi sono ovunque, è anche colpa sua.
I social media di oggi sono una casa infestata. E ogni stanza della casa è attraversata dall’eco di un ospite ormai dimenticato, uno di quelli che non è nemmeno rimasto a lungo ma ha comunque lasciato un segno indelebile. Un’app adorata da uno sparuto insieme di utenti, ormai spesso over-30, di cui la Generazione Z conosce solo i riflessi sui servizi digitali che vanno forte oggi. Anche il nome di quest’applicazione presenta particolari bizzarri: c’è chi lo ricorda bene e chi la conosce solo per via delle compilation su YouTube. Eppure, è proprio grazie a questo spettro che l’internet ha assunto l’aspetto di oggi. Senza la sua influenza, potremmo dire, su Instagram useremmo ancora tutti i filtri per rendere le nostre foto vintage e, chissà, forse TikTok nemmeno esisterebbe.
Parliamo di Vine, ovviamente, uno strano social network la cui storia è ancora più bislacca. Fondato nel giugno del 2012, fu acquistato da Twitter nell’ottobre dello stesso anno, prima ancora che fosse aperto al pubblico nei primi giorni del 2013. L’urgenza dell’interesse di Twitter è comprensibile: così come i tweet avevano imposto un nuovo canone di brevità alla parola scritta online, Vine sembra poter fare lo stesso con il formato video. Un Vine, infatti, non era che un video di al massimo sei secondi di durata, che si ripeteva in loop. L’app dava strumenti facili per montare, tagliare ed editare questi contenuti, in modo da condensare quante più informazioni possibili in pochi battiti di ciglia. Era stata pensata per offrire agli utenti un modo di registrare brevissimi attimi di vita: video-tweet, insomma. La distanza tra quello che Twitter si aspettava dall’app e quello che l’app sarebbe diventata è, come dire, siderale.
Sviluppi inattesi
Ian Padgham, per esempio, che all’epoca si occupava di marketing per Twitter, fu tra i primi a vedere il potenziale dell’app. Questo è il suo primo Vine. Una foto in movimento, poco più. Una gif dotata di audio, ecco, qualcosa con cui aumentare il potenziale dei tweet. Questo doveva essere Vine. E invece successe qualcosa di inaspettato. Grazie alle sue limitazioni formali e tecniche, Vine attrasse sin da subito un pubblico di creativi che la utilizzarono per fare video comici, assurdi, o per sfidare il tetto dei sei secondi con prodotti sempre più ambiziosi. Nel giro di un paio d’anni “il vine” divenne un’unità di misura d’intrattenimento, un genere a sé stante. Nacquero i Grandi Classici di Vine, quelli omaggiati dalla compilation di YouTube di cui sopra. Cose come questa, con cui – mi sembra evidente – ci allontaniamo parecchio dal concetto di video-tweet previsto da Twitter.
Un Vine non era che un video di al massimo sei secondi di durata, che si ripeteva in loop. L’app dava strumenti facili per montare, tagliare ed editare questi contenuti, in modo da condensare quante più informazioni possibili in pochi battiti di ciglia. Era stata pensata per offrire agli utenti un modo di registrare brevissimi attimi di vita: video-tweet, insomma.
Non fu esattamente un “felice accidente”. La componente weird di Vine non riuscì mai del tutto a convincere i piani alti, che col tempo abbandonarono l’applicazione, creando uno splendido isolamento che, se nel primo periodo aiutò lo spirito alternativo del servizio, finì per soffocarne le possibilità di crescita. “Come si monetizza una cosa del genere?”. È una domanda lecita che, immagino, Jack Dorsey e i suoi si posero più di una volta. Lo stesso interrogativo, però, poteva essere applicato alla stessa Twitter, azienda che da praticamente sempre opera in perdita e che nel 2016 registrava perdite complessive per circa due miliardi di dollari. A cascata, tra il 2016 e il 2017, quando la fine del social network iniziò a farsi evidente, cominciò un trasbordo di talenti, la “Viner Invasion” del 2016-17, che si trasferirono in massa dall’app ormai decrepita a YouTube. Per dare un’idea del fenomeno, basta ricordare che i fratelli Logan e Jake Paul, che oggi hanno imperi mediali che vanno da YouTube ai combattimenti della WWE, hanno iniziato proprio registrando video buffi su Vine, da cui sono fuggiti al momento opportuno.
Concorrenza
Anche se il cuore dell’app erano i video, non fu YouTube a decretarne la fine, quanto la velocità di adattamento della concorrenza che, fino ad allora, aveva fatto altro. L’inizio della fine del social network fu, come ha raccontato il sito The Verge, la nascita di Instagram Video, con cui la piattaforma si aprì ai video alzando il limite di tempo a 60 secondi. Un’eternità. Ma un lasso di tempo comodissimo per influencer e brand, che potevano vendere e raccontare i prodotti con estrema libertà, in un contesto meno bizzarro e caratteristico di Vine. Era il 2013, certo, e Vine avrebbe avuto ancora un paio d’anni di crescita, ma in quel momento il suo destino fu scritto, anche a causa dell’incapacità di Twitter di reagire e aggiornare il servizio, che rimase immobile in tutta la sua peculiarità, una gemma sempre più grezza in un ambiente in continua evoluzione. La nascita di Instagram Video fu importante anche per un’altra questione, aziendale e interna a Facebook. Il gigante di Mark Zuckerberg aveva infatti comprato Instagram da poco, nell’aprile del 2012, garantendo indipendenza al team corsaro dell’app fotografica.
La nascita di Instagram Video fu quindi la prima volta in cui Instagram si ritrovò a copiare senza troppe remore un prodotto altrui, in un copione che avrebbe poi perfezionato con le Stories nel 2016 (“ispirate”, per amor di eufemismo, da Snapchat) e i Reels nel 2020 (sfrontato “omaggio” a TikTok)
Già all’epoca, però, Instagram serviva a Facebook, e molto: il servizio non poteva quindi rimanere immobile con i suoi filtri retro, doveva inseguire la concorrenza arrivando, perché no, anche a copiarla. La nascita di Instagram Video fu quindi la prima volta in cui Instagram si ritrovò a copiare senza troppe remore un prodotto altrui, in un copione che avrebbe poi perfezionato con le Stories nel 2016 (“ispirate”, per amor di eufemismo, da Snapchat) e i Reels nel 2020 (sfrontato “omaggio” a TikTok).
Tracce di Vine
Le tracce di Vine sono dappertutto, come materiale radioattivo che ha condannato una regione intera. L’ascesa e caduta del servizio ha, come si è visto, messo in moto meccanismi che ancora caratterizzano il settore digitale. Un’ombra lunga – seppur ormai distorta – che continua a ingannare utenti e investitori, che si convincono di tanto in tanto di come sarebbe bello riaprire Vine. Il suo co-fondatore Dom Hofmann ha annunciato nel lontano 2018 un “successore” all’app chiamato Vine2 (poi v2), per poi fermarne lo sviluppo e riprenderlo a sorpresa un paio d’anni dopo, quando presentò al mondo Byte. L’app è stata presentata a inizio 2020, poche settimane prima che il mondo cambiasse e il Covid-19 spazzasse via tutto. A oggi pare aver fatto la fine di Quibi.
È forse questa la vera eredità di Vine. Non una lezione di business né di UX design quanto di libertà creativa rispetto i rigidi contorni delle piattaforme. Anche a questo dobbiamo i tanti moti nostalgici che vorrebbero ricrearne la magia, per poi rendersi conto dell’amara verità: i tempi son cambiati, il web è un’altra cosa. Ogni tanto, però, capita ancora di ingannarci e riconoscere l’ombra di Vine: in un TikTok ben riuscito o in qualche post su Instagram, in un creator bizzarro e anomalo. E ci viene da voltarci e chiederci se Vine non sia tornato – o non sia pronto a farlo. E invece no. E, perdio, va bene così.
Pietro Minto
Nato a Mirano, in provincia di Venezia, nel 1987; vive a Milano. Collabora con Il Foglio, Il Post e altre testate. Dal 2014 cura la newsletter Link Molto Belli.
Vedi tutti gli articoli di Pietro MintoLeggi anche

Mediamorfosi 3
L’infinite Jest delle piattaforme

Fenomeni
Nel silenzio ti controllo

