
In poche settimane di lockdown si sono concentrate novità che di solito impiegano anni. E anche per gli spot e i marchi si è trattato di un inatteso esperimento. Con conseguenze che resteranno.
Dell’ultima riunione a cui ho partecipato di persona, circa tre mesi fa, un momento topico sembra ancora fermo nel tempo. Il direttore marketing rientra da una telefonata e dice agli altri, con una malcelata soddisfazione, “sono riuscito a bloccare le campagne per sei mesi”. Intendeva, senza penali. Era comprensibile, in quel momento. Sembrava che il mondo fosse alla fine, o almeno il mondo del consumo come l’avevamo sempre considerato, cioè immutabile. Con i negozi chiusi, gli ipermercati chiusi o deserti, con Amazon che pareva arrancare di fronte al proprio stesso successo, davanti alla prospettiva di magazzini colmi di pezzi invenduti e quindi con flussi di cassa pressoché azzerati, era più che ragionevole pensare che la sopravvivenza passasse da una dieta repentina, una messa in sicurezza di fronte a una traversata in un periodo che si preannunciava irto di difficoltà e imprevisti.
In quel minuto probabilmente anche ad altri presenti sarà venuta in mente (e suonata come ottimistica e un po’ naïf) la frase attribuita in modo più o meno accurato al solito Henry Ford. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo. In questo caso, però, nella sala sembrava che fosse stato l’orologio a fermarsi per primo: e per risparmiare soldi bisognava fermare la pubblicità. Era iniziato l’esperimento. In mancanza di precedenti e di best practice, il marketing ha dovuto inventare. Diventare creativo in senso stretto. Anziché copiare a vicenda le mosse dei competitor come accade in un ecosistema che rifugge strenuamente il rischio come il marketing, per un breve periodo di tempo (durato qualche settimana) ci si è mossi in ordine sparso e frenetico come formiche a cui si è pestato il formicaio. A completare l’entropia, a volte fatti e dichiarazioni differivano ancora più del solito. Mentre si chiariva con comunicati alla stampa di settore, con la tipica sopravvalutazione dei brand del loro ruolo nella vita delle persone, che “i nostri consumatori si aspettano che siamo vicini a loro anche in questo periodo difficile” (sottinteso, con la comunicazione), nell’ufficio marketing c’era un lavorio frenetico nel calcolare in tabelle di Excel il risparmio che si poteva ottenere tagliando o “posticipando” questo e quello, a seconda degli impegni presi (o “minacciando” di non pagare le concessionarie).
Dopo l’esperimento
La cruda realtà dell’esperimento è che la pubblicità serve a vendere, anche nel breve periodo. I discorsi involuti ed eleganti sulla costruzione di brand, sulla awareness da mantenere, sul purpose marketing e di quanto i brand debbano inserirsi nel flusso della storia con la S maiuscola si sono sciolti come neve al sole appena esposti a qualcosa di imprevisto. E quindi a rimanere in tv, la cartina di tornasole della società e di ciò che dell’interazione sociale si nutre, come il marketing e il consumo, sono rimasti in pochi. Erano quelli che avevano, salvo poche eccezioni, i negozi (di sbocco) e gli ecommerce aperti. La tv, mentre riaffermava il proprio ruolo unificatore nell’essere il minimo comune multiplo della società (che non vuole essere un giudizio qualitativo in sé) e raggiungeva vette di ascolti non immaginabili, risultava ben poco allettante per chi voleva ricordare l’esistenza del proprio brand. Essere inseriti tra un exit poll giornaliero di contagiati e un servizio video dal fronte lombardo non è una cosa che i marketing manager desiderano ardentemente. A torto o a ragione, ci tengono alla brand safety, al non essere nemmeno accostati, non dico associati, a eventi o idee negative. Come vogliono da YouTube la certezza (difficile da raggiungere) che il proprio preroll non sia inserito prima di un contenuto discutibile, così anche il Covid-19 era diventato una parola da mettere in black list per gli spazi pubblicitari.
Anche per chi poteva ancora vendere, trovare il giusto tono di voce era come camminare in un campo minato. Cosa volevano davvero i consumatori? Essere rassicurati che il brand sarebbe “rimasto con loro” qualunque cosa significasse? Avere una solo-pubblicitaria-ma-meglio-che-niente luce in fondo al tunnel? Vedere rassicuranti spot come ai vecchi tempi come nulla fosse successo? I primi a muoversi saranno gli unici a essere ricordati: Barilla con la voce di Sofia Loren, in un’Italia vuota e silenziosa, per esempio. Gli epigoni sono stati assorbiti dal consumatore medio in un blob di belle frasi in cui né il messaggio né il prodotto sembravano distinguersi l’uno dall’altro. Le residue automobili in tv usavano immagini emozionali tutte uguali, le stesse che tutti vedevamo già in casa: gente al pc che lavorava o faceva compiti, nuove routine casalinghe, promesse di ritorno alla normalità. Qualcuno ha cercato di salvare capra e cavoli: ci spiace, ti siamo vicini, ma ORA abbiamo il prodotto giusto per te! Messaggi poco apprezzati dal pubblico. Cosa sarà rimasto di tutto questo nella mente del consumatore? Di tutte queste evocazioni e suggestioni, poco. Rimuoviamo appena possibile i brutti ricordi. Ricorderà qualcosa in più dei brand che hanno riconvertito fabbriche di liquori per produrre disinfettanti, o delle maison che hanno prodotto le prime mascherine, o sconosciute fabbriche lombarde che hanno convertito maschere da sub in respiratori.
L’esperimento aveva così dato un primo responso: la pubblicità di massa non sembrava più essere un prodotto essenziale, nella piramide di Maslow del marketing. Né per vendere, né per la brand reputation. Intanto, invece sui social la vita continuava, ogni brand – si diceva – doveva coltivare la sua community. Dal logo con gli archi distanziati di McDonald al panino con la cipolla-di-sicurezza per Burger King, alle dirette Instagram con il dietro le quinte e gli ospiti di tanti altri. Se la tv era quello che ci accumunava tutti, i social media sembravano essere quello che ci differenziava e ci riuniva con la nostra prima cerchia di amici (e di brand). Inseriti in gruppi più o meno forzatamente (scuola, smart working) ma anche più che volonterosi nel creare ponti digitali con persone non raggiungibili fisicamente, i social, i messaggi e le chat sono diventati il tessuto connettivo della società. Facebook e i suoi fratelli hanno visto aumentare il tempo speso del 40%, assieme alle fughe dalla realtà in comode sottoscrizioni mensili offerte dagli Ott come Netflix e Prime Video.
Nel frattempo, sul mercato della pubblicità la forbice tra spazio disponibile e spazio comprato si allargava. Lo spazio pubblicitario è come la verdura, quella che rimane va buttata. E quindi sul mercato gli spazi erano praticamente regalati, e i clienti ricontattati a uno a uno per chiedere investimenti. È diventato celebre il video di motivazione di Cairo che incentiva i venditori a darsi da fare, indicando come da sue informazioni i clienti fossero pronti a spendere in pubblicità. Gli stessi clienti che stavano però tagliando i budget. La forbice tra domanda e offerta però si allargava soprattutto per la tv e i giornali, ma solo in minima misura per i social media. Il costo degli spot ha raggiunto minimi storici. Per un periodo è stato frequente vedere su reti nazionali pubblicità che normalmente si vedevano nelle reti locali. Non è stato inusuale osservare negozi di ferramenta che accedevano alla televisione o sul quotidiano nazionale dopo anni di spot su tv locali e annunci sui quotidiani locali.
Trasformazione digitale
Si conviene ormai che il Covid-19 abbia accelerato la trasformazione digitale. Il digitale nella sua massima espressione agisce come abbattitore di distanze e barriere, di acquisto e informative: non poteva non essere a suo agio in questo momento di ostacoli di tutti i tipi. Consumatori più che felici di essere consumatori tradizionali, come quelli che entrano venti volte in un camerino di Zara per provarsi un vestito o battono con la mano il cocomero prima di metterlo nel carrello si sono trovati obtorto collo catapultati nel futuro e hanno visto che l’online non è così male. Magari non è all’altezza del mondo fisico, ma quasi. La crescita a regime che si sedimenterà nell’uso del digitale e dell’ecommerce è pari a quella ottenibile in tre anni della vecchia normalità. McKinsey indica che il 23% degli italiani pensa di mantenere un livello elevato di uso dell’ecommerce, anche nel post Covid.
I discorsi involuti ed eleganti sulla costruzione di brand, sulla awareness da mantenere, sul purpose marketing si sono sciolti come neve al sole appena esposti a qualcosa di imprevisto. E quindi a rimanere in tv, la cartina di tornasole della società e di ciò che dell’interazione sociale si nutre, sono rimasti in pochi. Erano quelli che avevano, salvo poche eccezioni, i negozi (di sbocco) e gli ecommerce aperti.
In questo esperimento entra così in scena l’effetto scalino. L’effetto scalino è stato prodotto da questi tre mesi che in pratica hanno creato un fast forward di tre anni nella normalità digitale. Stiamo vivendo di già in ciò che consideravamo plausibile nel 2023. L’esperimento e l’effetto scalino non potranno non cambiare il corso della pubblicità, soprattutto quella della “grande” pubblicità. Perché – diciamola tutta – la ricerca a pagamento di Google e il retargeting di Facebook non sono pubblicità in senso stretto, servono solo a facilitarci alla vita nel raggiungere ciò che abbiamo già in mente. E non a caso sono state impattate dal Covid-19 in maniera residuale, con movimenti tattici sulle parole chiave o sulla destinazione finale (meno negozi, più online). La vera pubblicità è ciò che al suo meglio realizza un cambiamento che – con una parola grossa – possiamo chiamare “culturale”. Un cambiamento che poi origina discontinuità nei consumi di brand. L’effetto scalino ci ha fatto risvegliare in un mondo del consumo cambiato, che non rimarrà così cambiato ma pur sempre molto più digitalizzato e connesso, e da lì si dovrà ripartire. A volte da capo, per riconvertire il consumatore. Come? L’esperimento ha messo in luce, per i brand, che un riazzeramento nei riti della pubblicità (il “tradizionale spot” su una “tradizionale rete”) non è un dramma, ma si può riciclare come “innovazione”. Il tabù è rotto. Dal 2020, tutto sarà in discussione.
Effetto domino
Ogni mercato influenza i mercati che stanno a monte. La caduta delle vendite dell’abbigliamento influenza il mercato della pubblicità dell’abbigliamento, lo costringe a ripensare meccaniche, strumenti e budget. E quindi, in generale, anche il prodotto pubblicità come ne uscirà cambiato? L’esperimento e l’effetto scalino agiranno anche sulle dinamiche del prodotto che serve a vendere altri prodotti, la pubblicità. Questi mesi hanno dimostrato che più il settore è fluido (e quindi digitale o “programmatico”, come si dice in gergo) più gli sbalzi tra domanda e offerta sono gestiti in modo efficiente. La perdita di ricavi pubblicitari di Facebook, anche nella parte non strettamente collegata alla vendita, non è stata minimamente confrontabile a quella dell’editoria cartacea e televisiva, forse anche perché l’ambiente in cui inserire gli annunci era meno gravato di notizie ferali, era la nostra succedanea comunità ricreata digitalmente. Con il programmatic (aste automatiche, per semplificare) applicato alla pubblicità classica viene però meno il principale punto di forza della vendita di spazi: la discriminazione di prezzo tra clienti a seconda del loro potenziale di spesa. Il commerciale in carne e ossa potrebbe essere il vero perdente dell’esperimento. Ciononostante, il programmatic associato alla tv può far accedere velocemente un numero molto più elevato di possibili compratori di pubblicità. Quanti ecommerce avrebbero potuto accedere a spazi in tv durante il lockdown? Ma non c’è stato modo per loro di farlo, se non inoltrandosi in un percorso fatto di trattative, prezzi ad hoc, un ginepraio a cui buona parte degli investitori di nuova generazione non è abituato e non intende nemmeno diventarlo. Easy on, easy off. Accendi e spegni è il nuovo mantra. Come il disdici quando vuoi che è diventato la regola nello streaming.
La forza del mercato pubblicitario digitale è la sua liquidità, la sua adattabilità automatica, il suo accesso democratico a tutti: dalla ferramenta alla Fiat tutti possono usare Facebook. Tuttavia rimane il fatto che il formato tabellare a basso coinvolgimento e ipertargetizzato, tipico dello smartphone, è poco adatto a produrre “cultura” condivisa e quindi branding. Nessun megabrand è mai stato costruito unicamente sull’advertising digitale, tranne le piattaforme digitali di massa. I megabrand di massa avranno bisogno, anche in epoca post-Covid, di rivolgersi a tutti, per restaurare il loro predominio dopo l’assenza forzata. Coca-Cola, scomparsa dalla pubblicità, dovrà tornare a recitare Coca-Cola, la felicità, le immagini di vita assieme. Tanto più che non solo il quanto, ma anche il cosa è cambiato: le abitudini si sono modificate, nuovi microbrand e store alternativi sono stati provati dai consumatori in questi mesi, e non è detto che torneranno indietro. L’esperimento non ha infatti azzerato la preferenza di brand, ma ha fatto scoprire cose nuove, che a volte ci sono pure piaciute. La tradizionale avversione al rischio che sta spesso dietro la “fedeltà” al brand è scomparsa per ragioni di forza maggiore. Si sono provati nuovi biscotti, o perché quelli-di-sempre non c’erano, o perché in momenti “drammatici” vale tutto, si può rischiare qualcosa o concederci una pazzia. Io ho comprato datteri per tutto il lockdown. Forse continuerò a farlo.
L’effetto scalino ci ha fatto risvegliare in un mondo del consumo cambiato, che non rimarrà cosìcambiato ma pur sempre molto più digitalizzato e connesso, e da lì si dovrà ripartire. A volte da capo, per riconvertire il consumatore. Come? L’esperimento ha messo in luce, per i brand, che un riazzeramento nei riti della pubblicità (il “tradizionale spot” su una “tradizionale rete”) non è un dramma, ma si può riciclare come “innovazione”. Il tabù è rotto. Dal 2020, tutto sarà in discussione.
In generale i clienti, i marketer e i pubblicitari dall’esperimento saranno portati a pensare al back to basic. Si torna al sodo, si azzerano i riti. Come le riunioni pare si possano tranquillamente tenere su Zoom, la pubblicità servirà quando serve, e i contenuti dovranno essere correlati alla nuova normalità, più economica e psicologica che sanitaria, in cui la considerazione sul ruolo di un determinato acquisto nella nostra vita sarà ancora più ponderato e messo in discussione dai consumatori. Meno costose suggestioni e più frugalità e razionalità? Forse non mi arrischierei così in là, però è una possibilità.
Perdita di centralità
La mia sensazione – posso sbagliare – è che in tutto questo rivolgimento la pubblicità stia rischiando di perdere la centralità nei pensieri del marketing e delle aziende. Nuove abitudini, acquisite o forzate, devono far ripensare prodotti, servizi: l’esperimento collettivo non ha finito i suoi effetti. Anche nella migliore delle ipotesi, il “contenimento” porterà a esperienze di consumo diverse, e a volte, se ben pensate dai brand, migliori delle precedenti. La prenotazione per fare la spesa, o il click and collect, o il posto in spiaggia via app li avremmo avuti forse nel 2023. Sono già qui e ora. Il prodotto nelle P di marketing ha ripreso la scena principale, per il momento, assieme alla P di prezzo (avete notato come il classico “a partire da 299 euro al mese” sia ormai inserito nei primi dieci secondi dello spot del lussuoso suv, anziché nel frettoloso codino?). Che ci saranno meno soldi in giro, del resto, è una delle poche certezze che abbiamo in questo momento. Meno soldi per i consumatori uguale meno soldi per le aziende uguale meno soldi per le agenzie e i broadcaster. La creatività, quella vera, però potrebbe perfino avvantaggiarsene. “È solo quando ci sono pochi soldi che viene fuori il creativo”, diceva un mio ex direttore marketing. Se aziende del retail fanno spot e contenuti usando Zoom e mostrando la realtà in cui lavorano i dipendenti, lo spot girato in Costa Azzurra dovrà giustificare la sua esistenza.
L’effetto scalino e l’esperimento non avranno lo stesso effetto per tutti gli operatori e le piattaforme. Mentre per gli Ott come Facebook e Google, che erano già pronte a un futuro di advertising digitale, e anzi, avendo in pratica creato il mercato guadagnano in modo direttamente proporzionale all’avanzata della digitalizzazione, questo è solo un piccolo sobbalzo nell’asfalto dell’autostrada. Per i giornali, potrebbe essere la pietra tombale del modello basato sulla pubblicità. Il programmatic per loro è poco conveniente, e la carta, be’, è difficilmente utilizzabile in questa modalità. Ma soprattutto si inserisce in una spirale in caduta libera precedente. Per loro, la caduta del “rito” della percentuale del budget in carta potrebbe significare che i ricavi pubblicitari non torneranno mai più ai livelli di prima. Nella terza settimana di maggio 2020, ancora manca all’appello circa il 40% dei ricavi dei quotidiani, mentre “solo” il 23% manca alle reti televisive nazionali, dice Nielsen.
L’esperimento sta – secondo me – dimostrando che la tv ha davvero sette vite. Perché tiene bene in pugno il formato lungo. Quello che consente di fare imprinting nel consumatore, anche quello che appare distratto. Passato il momento in cui il palinsesto tradizionale era occupato solo da brutte notizie, rinasce dalle proprie ceneri, in forme diverse (aumento dello scalino nello streaming, accelerazione dell’addressable advertising), anche perché gode ancora di una sana e robusta costituzione, più dell’editoria. Immaginate lo stesso direttore marketing davanti al pannello di controllo simil-Google del suo advertising specialist, che può decidere in tempo reale se comprare quindici secondi su Raitre o Canale 5 (sempre che non si facciano battere da Netflix o altri, in questo: starei attento a Prime Video) solo spingendo un tasto, non appena il costo per visualizzazione scende sotto quello di Facebook. Non ci penserà due volte. Immaginatelo inserire il suo spot, ma solo per gli spettatori dai 25 ai 35 appassionati di design. Probabilmente non avrà iniziato il tradizionale processo di produzione dello spot sei mesi prima, ma sei ore prima. Sarà poi meno creativo? Non è detto. Il digitale crea nuove forme di creatività: pensate a cosa si può fare sulle stories di Instagram. Sicuramente c’è più creatività che nel classico medio spot di auto. Certo, per raccogliere fatturato da inserzionisti in un periodo di razionalizzazioni spinte, impellenti necessità di vendite a breve termine e di nuovi obblighi da parte dei marketing manager di dimostrare il ritorno degli investimenti (e non più dei riti), la tv dovrà ripensare l’accesso agli spazi e in modo più democratico e aperto, automatizzato e forse anche creativo. Di addressable TV advertising si parla da anni. L’esperimento, con i suoi effetti sulla digitalizzazione di domanda e offerta, potrebbe segnarne la definitiva consacrazione e il modo per tornare al centro dei pensieri del marketing. Fornire ampie possibilità di copertura a Coca-Cola ma anche di targetizzazione (non microtargeting, che non sarà mai la sua funzione) ai microbrand potrebbe essere il futuro della televisione, in grado di accontentare Coca-Cola e il concessionario di auto. O quantomeno di evitare che a Gianluca Diegoli capiti di vedere ancora e ancora lo spot del nuovo furgone Ducato. A meno che questo non sia un messaggio dal futuro. Del resto, siamo già nel 2023.
Gianluca Diegoli
Dalla Bocconi in poi osserva passare i trend dall’evanescente confine tra online e offline. Di giorno si occupa di marketing e digital, di notte ha scritto Svuota il carrello (2020) per UTET. È professore a contratto in IULM e in Master. Ogni venerdì alle 9 manda la sua newsletter.
Vedi tutti gli articoli di Gianluca DiegoliLeggi anche
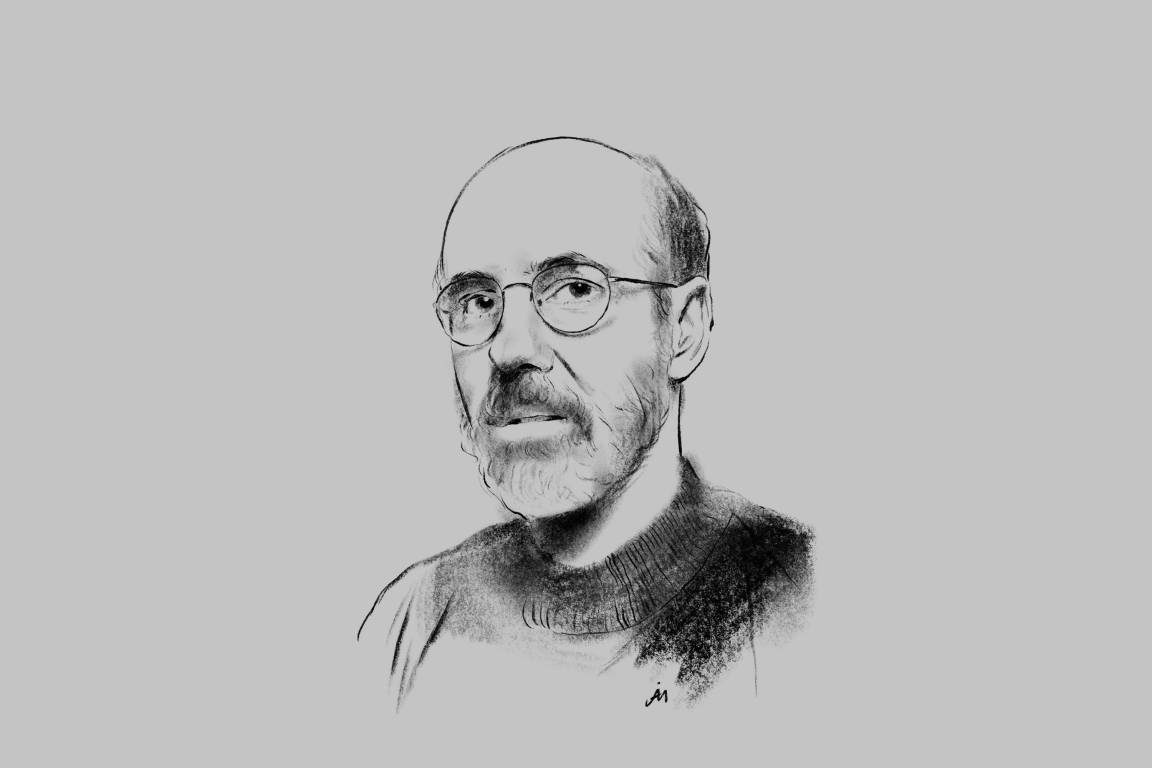
Mediamorfosi 3
Intervista a Jay David Bolter


