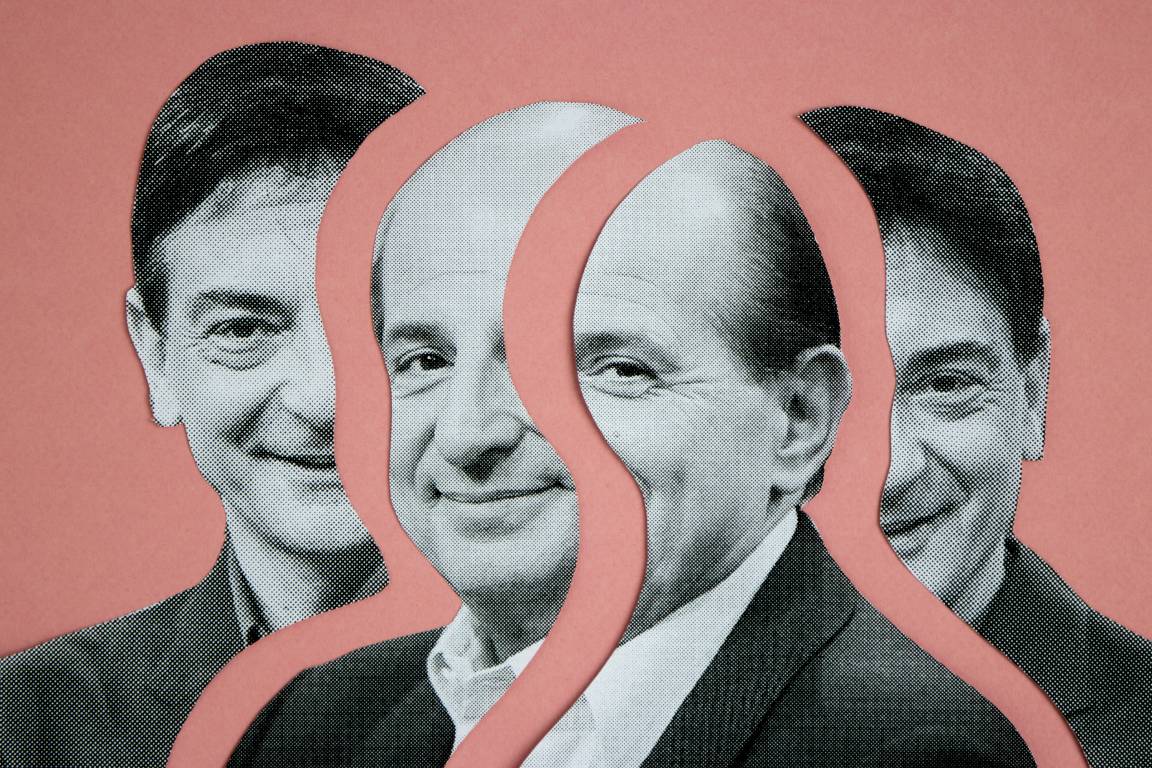Cartoline dalla televisione mainstream
Ride bene chi ride ultimo
Quando le piattaforme si travestono da generaliste, anche per colmare le lacune rimaste altrove.
di Nico Morabito
Cosa sarebbe successo se LOL: chi ride è fuori fosse andato in onda su Raidue o Italia 1? Avrebbe avuto lo stesso successo o lo avremmo liquidato come l’ennesima evidenza di un biennio funesto? Non abbiamo la controprova, ma la sensazione è che sarebbero bastati i titoli di testa (“Pintus”) per finire a ubriacarci guardando vecchi spezzoni di Avanzi o Mai dire gol. Invece eccoci su Amazon Prime Video, senza un futuro e senza un piano vaccinale serio all’orizzonte, talmente disperati da ridere fino alle lacrime con gente che per campare si fa chiamare Fru. Come siamo arrivati a questo punto?
Stiamo parlando di un format con varie declinazioni in giro per il mondo, di un cast trasversale e di un’idea abbastanza sciocca da piacere a chiunque: vince chi riesce a non ridere malgrado le gag cretine degli altri concorrenti. L’effetto esilarante è amplificato dal fatto che tutti abbiamo fatto questo gioco (chi non ride con le smorfie di Matano evidentemente all’asilo leggeva già Tolstoj, o forse non è mai andato all’asilo, troppo da poveracci). Insomma, il famoso minimo comun denominatore che la generalista ha nel dna ma che non riesce più a trovare ché la diritta via è ormai smarrita, soprattutto nella comicità.
Mettiamo infatti che io voglia sottrarmi al flusso di tragedie, sfighe e psicodrammi italo-russi di gente scomparsa per farmi due risate, a chi devo rivolgermi? Quelli bravi sono in pensione o in panchina, i nuovi (Raimondo, Lundini, Fanelli) sono ancora usati come tappabuchi. Seriamente, chi rimane? Brignano? Crozza? Le Iene? Il punto è che reti che hanno fatto la storia del varietà comico oggi sono troppo impegnate a fare l’1% in prima serata e non hanno tempo per il divertimento intelligente. In un sistema televisivo maturo autori come Benincasa e Bottura lavorerebbero senza sosta, Cucciari avrebbe già condotto tre Festival di Sanremo e non soltanto programmi random di cui il pubblico si accorge quando smettono di andare in onda. Con un’offerta davvero ampia ci sarebbe posto anche per titoli più leggeri come LOL, e noi saremmo liberi di fare gli snob persino con Elio e Caterina Guzzanti. Ma la realtà è diversa. Le piattaforme streaming hanno budget, libertà e una patina di perenne novità che sembra inscalfibile. Il paradosso è che riescono a sbancare tutto proprio quando si travestono da generaliste. Vale per certe discutibili fiction ispanofone e vale per certi programmi comici che ci fanno ridere a nostra insaputa.
Cartoline dalla televisione mainstream
Pronto, chi gioca?
Perché certi programmi del mattino, nonostante tutto, sono ancora importanti
di Nico Morabito
Uno dei motivi per cui mi ostino a guardare la tv di flusso è la fascia tra le 11 e le 13. Il momento in cui i politici per un po’ si tolgono di mezzo, gli intellettuali condividono foto di gattini sui social, e le mamme su Whatsapp progettano spedizioni punitive contro i professori dei propri figli. Quel momento.
La tv del mattino è una landa abbandonata ma viva, ultimo avamposto ai confini dell’umanità. Qui si usano ancora parole come réclame e comitato, non si dicono mai volgarità (al massimo “Oh cavolina!” se cade una pentola) e la pandemia non è mai esistita (“Lo so, lo so, anche per voi del capricorno è stato un anno un po’ immobile dal punto di vista lavorativo”). Qui si imparano le coreografie dei balli più amati o le ricette più innovative (“Dimenticate come avete fatto gli gnocchi finora”).
Nella tv del mattino, soprattutto, esistono ancora le telefonate da casa e il montepremi che diminuisce a ogni risposta sbagliata, o quello che aumenta un po’ alla volta: in palio non gettoni d’oro ma opere di bene e buoni spesa. Giochi semplici per gente come noi, in cui bisogna indovinare quante foglie ha un albero (ciao fagioli, ciao Raffaella) o cosa si trova nel cassetto (ciao zainetto, ciao Ambra). Giochi che durano sempre troppo poco, perché bisogna cambiare pagina, sapore e stacchetto, ma intanto la gente da casa compone in eterno il numero della Rai sperando di parlare con Antonella e Giancarlo.
Ma chi è questa gente che continua a girare il sugo e che non usciva mai di casa neanche prima di questi anni disgraziati? È il disoccupato che giura di non volersi arrendere. È la signora che crede in Paolo Fox (“Oggi ha messo al primo posto l’acquario quindi dico casella numero uno!” “Noo! Sbagliato!”). È la 26enne di Cusano Milanino in cassa integrazione (“Dai, sei giovane, passerà!” “Eh”). È il signor Mario che non sa che farsene della bellezza (“Cosa vedi dalla tua finestra?” “E che devo vedere, ci sta la Reggia di Caserta”). Un pezzo di paese che continua a presidiare la fortezza Bastiani malgrado il nemico se ne sia già andato da un pezzo, sperando soltanto di scavallare un’altra giornata, e poi un’altra ancora. Ecco perché mi ostino a guardare certi programmi del mattino: uscire dalla bolla, ogni tanto, fa bene.
Cartoline dalla televisione mainstream
E adesso un’altra canzone!
Va bene tenere la musica al centro, ma tutto intorno è bene costruire un racconto o una gara. Meglio non dimenticarsene…
di Nico Morabito
L’ostinazione di Raiuno nel mandare in onda, a ogni stagione televisiva, la solita sfilza di programmi musicali ha qualcosa di davvero commovente. Cambiano i decenni, i governi e i flagelli per l’umanità ma possiamo star certi che al primo buco di palinsesto arriverà una gragnuola di canzonette a farci pentire di esserci cascati di nuovo. Nel recente La musica che gira intorno Fiorella Mannoia ha così introdotto la lista infinitadi ospiti: “Le canzoni mettono d’accordo tutti, per ogni emozione che proviamo c’è una canzone che ce la ricorda. Nessuna forma d’arte ha questa capacità”.
In effetti c’è stato un tempo in cui eravamo molto bravi, e non siamo i soli a pensarlo. Ogni volta che qualcuno nel mondo posta Prisencolinensinainciusol cantata e ballata da Adriano Celentano e Raffaella Carrà, assistiamo a commenti estasiati e milioni di visualizzazioni per qualcosa che noi italiani abbiamo tatuato nella retina e che fa parte del nostro patrimonio genetico. Delizia, ma anche croce: a furia di vecchi estratti decontestualizzati, ci siamo sul serio convinti che in tv bastano le canzoni. Eppure, da Canzonissima in giù, la storia ci insegna che la musica funziona soprattutto con gare, lotterie, classifiche, squadra bianca e squadra blu. È necessario un pretesto, altrimenti gli spettatori cambiano canale (persino chi nella vita vorrebbe solo rinchiudersi in una teca Rai). Lo sa Carlo Conti, quando si inventa qualche meccanismo facile facile, lo sa Milly Carlucci con i suoi cantanti mascherati, lo sa Canzone segreta, in cui la musica è il tramite per arrivare alle lacrime (che però non sempre arrivano: se non ci si può abbracciare e toccare, a che serve l’emotainment?). Se invece il pretesto è troppo debole o assente, come nel caso della serie antologica A grande richiesta, in cui vengono celebrati i grandi artisti della nostra storia (“Ancora? Ma cos’è, una persecuzione?”), il pubblico scappa. Anche in tempi di crisi e di budget ridotti le idee sono più importanti del semplice elenco di grandi ospiti e grandicanzoni. Chissà, forse grazie a questo tonfo Raiuno capirà che si può anche smettere di guardare al passato e crogiolarsi nei ricordi. Se proprio si deve fare l’8% in prima serata, allora tanto vale sperimentare nuove strade nell’intrattenimento, come accade nei servizi pubblici di altri paesi europei. Così, giusto per vedere l’effetto che fa.
Cartoline dalla televisione mainstream
Il reality è morto, viva il reality
Perché il reality, una volta allungatosi all'infinito, è diventato anche la migliore soap opera che abbiamo
di Nico Morabito
Parlare del genere televisivo una volta conosciuto come reality show è molto complicato. Dobbiamo prenderlo sul serio o per finta? Guardarlo dall’alto, dal basso o come uno stanco guilty pleasure di cui peraltro abbiamo smesso di vergognarci già ai tempi di Francesca Piri? Il punto è che tutti hanno un ricordo personale legato ai reality, anche chi giura di non averne perché era troppo impegnato a rileggere la Recherche in lingua originale per la terza volta. C’è chi si indigna perché è tutto falso, o perché è tutto vero, e c’è chi non ha mai smesso di televotare.
Nell’anno infinito in cui tutto è durato troppo (il Covid, la sconfitta in slow-motion di Trump, le Maratone Mentana), il Grande Fratello Vip è andato oltre, macinando, tra il 2020 e il 2021, una quantità illogica di prime serate, con una tenuta sorprendente di numeri e di share. Come è possibile? Sarebbe facile ricorrere all’immagine del “tutti rinchiusi in casa che guardano altri rinchiusi in casa”. Ma forse la spiegazione è da cercare altrove. Dopo anni di prove ed errori, con l’ultima edizione il GFVip ha compiuto un definitivo mutamento: non più reality, non solo show, soprattutto soap opera. Meglio, una soap opera in diretta, capace di organizzare il materiale narrativo in una struttura multistrand e di sfruttare il tempo eterno delle soap, in un riciclo continuo di pezzi pregiati, scarti, agnizioni e colpi di scena: varie linee narrative (il b-romance, la comedy, il melo-psico-dramma) portate avanti da personaggi-archetipi (Dayane, l’unica cattiva all’altezza di Marina Giordano; Zorzi, un po’ stratega come Stephanie Forrester e un po’ romantico come Guido Del Bue; la sventurata Rosalinda che si sdoppia come Reva Shayne). Senza scomodare ulteriormente Propp, si tratta di un’operazione unica, che ha fatto di necessità virtù: se dentro e fuori dalla tv tutto ormai è reality, perché non trasformarsi in qualcos’altro? Un po’ come cerca di fare da tempo L’Isola dei famosi. Gli indizi (attori e attrici hard, la playa desnuda) erano già ben disseminati, ma adesso il format è pronto a diventare quello che forse ha sempre voluto essere: una spensierata commedia sexy all’italiana che si nutre di doppi sensi, gaffe e neologismi sgangherati. Mai come quest’anno gli interpreti sembrano all’altezza di una scrittura senza pudori. D’altronde il nuovo motto è: liberi di sognare. Dobbiamo crederci?
Cartoline dalla televisione mainstream
L’ospite, l’unica cosa che conta nella tv della parola
Fiumi di parole: se tutto è talk show, finiamo per ascoltare la televisione molto più che vederla
di Nico Morabito
Molti programmi televisivi italiani possono essere visti facendo altro. Mentre ti azzuffi con sconosciuti sui social (“Ma ti pare che Orsetto è la Gelmini?”), mentre ridi per un meme che ti ha già stufato prima ancora di condividerlo, mentre impasti il pane con la farina di farro. Oppure, ancora meglio, senza guardare: basta ascoltare.
A un certo punto, per strappi e per inerzie, la tv italiana è diventata una tv di parola. Solo di parola. Si parla dall’alba alla notte fonda. La visione si è persa per strada. Molti programmi sono esteticamente poveri, da tv locale che trasmette negli scantinati (ma senza il fascino seppiato della nostalgia). Il pubblico ormai si è abituato. In tv non c’è niente da vedere. Programmi come Otto e mezzo o L’assedio vengono riproposti come podcast ufficiali. Interi palinsesti potrebbero essere ascoltati in macchina mentre si guida (“Radio la7”). Una questione economica, certo. Con i fichi secchi (e con la pandemia) è dura, ma almeno le parole non mancano mai.
In questa tv il solo oggetto di valore è l’ospite. L’ospite è l’idea, e viceversa. L’ospite fa la scaletta. L’ospite parla, parla, parla. L’ospite è tutto. Levi l’ospite e la tv italiana scompare. Ma non è facile essere ospite. Perché se è vero che per andare in televisione basta la spontaneità (“Alfonso ti giuro, io sono sempre stata me stessa qua dentro”), allo stesso tempo un po’ di talento è necessario. Persino nei programmi in cui bisogna saper fare qualcosa (ballare, cantare, cucinare), se non sai parlare come si deve, ti fanno fuori in mezza mystery box.
Per non annegare nel fiume di parole tutte uguali (“Ma questo linguaggio da talk show cosa c’entra con noi?”) l’unica cosa che conta è dunque avere l’ospite giusto. L’ospite che sa parlare nel mio programma, nella mia rete, al mio pubblico: Barack Obama, Caterina Collovati, Asia Argento. Oppure, bisogna arrivare sul pallone prima degli altri, come ha fatto qualche settimana fa Lilli Gruber con l’ex tante cose Rocco Casalino: puntare su volti esclusivi che poi verranno spremuti altrove. C’è chi cerca solo l’inedito, chi vive di cover. Ma è solo melina. Fermare l’erosione di spettatori nella tv della parola è difficilissimo: tutti parlano, pochi sanno farsi ascoltare.
Cartoline dalla televisione mainstream
Anzi leggerissima
Sanremo 2021: il difficile equilibrio tra le esigenze dello spettacolo televisivo e la crisi sanitaria
di Nico Morabito
C’è un elefante all’Ariston che tutti vorremmo non vedere ma che è lì, nei tristi palloncini gialli che si sgonfiano di noia, nel carrello di fiori che scompare dopo la prima puntata come un personaggio che avevano dimenticato di tagliare al montaggio, nei volti dei conduttori radiofonici rinchiusi nella gabbia del nostro sconforto. “È un altro Sanremo, è un’altra Italia”, aveva detto Amadeus alla vigilia. Sì, ma è pur sempre Sanremo, la sola festa comandata che ci rimane, la messa a cui avremmo scelto di partecipare anche se non fossimo stati costretti.
Si poteva fare finta di niente, spostando il Festival altrove, in un vero studio televisivo. E invece no, Sanremo è Sanremo, meglio partire con l’handicap che rinunciare al teatro. Sanremo è fatto di scrittura e regole sempre uguali. Può cambiare l’ordine degli addendi ma non le geremiadi di chi pensa sempre che era meglio l’anno scorso. Bisogna accontentare tutti, abbassare e alzare il livello senza perdere mai l’equilibrio. Sanremo è un programma-palinsesto che non butta via niente: Ibrahimović e la queerness ingenua di Achille Lauro, le storie vere e i lussuriosi mash-up che non ci faranno dormire stanotte, le dita dei piedi e i monologhi di Elodie from the block, le citazioni per palati fini e i duetti amorosi du du da da da.
E allora perché questa sensazione di vuoto, questo tormento in sottofondo persino quando saltiamo giù dal divano e ci buttiamo ai piedi di Loredana? Sarebbe facile prendersela con l’assenza del pubblico e con tutte le cose che non si possono più fare in scena. Ma c’è un’altra ragione, e riguarda il patto con il pubblico. Il secondo Sanremo consecutivo è molto difficile. A volte riesce e a volte si schianta contro un muro. Puntare sull’usato sicuro di Fiorello e sullo schema-fotocopia si è rivelato un boomerang. Tra il Festival del 2020 e quello del 2021 non c’è nulla: non c’è spensieratezza, non c’è memoria condivisa. L’ultimo momento felice delle nostre vite non ha nemmeno fatto in tempo a diventare ricordo. Siamo ancora là, a cantare a squarciagola con Diodato. Ecco perché, mai come quest’anno, la promessa di intrattenimento avrebbe meritato una declinazione più nitida e compatta: meno minestrone e più mash-up, meno gag e più spettacolo puro. D’altronde, era già tutto scritto nell’unica canzone che non ha fatto finta di niente: sì, i tamburi annunciano un temporale ma tu intanto metti un po’ di musica leggera. Anzi leggerissima.